|
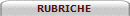

.

.

.

.
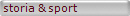
.
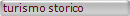
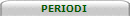
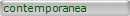
.

.
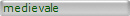
.


.
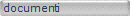
.
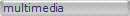
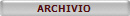


|
N. 29 - Maggio 2010
(LX)
ASIA, BUDDHA E UN REPORTER senza lavoro
PARTE XIIi – Rohingya, un popolo senza identità
di Gianrigo Marletta
Cox’s
Bazar,
20
Giugno
2008
“C’era
una
volta
un
re,
di
fede
buddista,
che
governava
sulla
provincia
di
Sittwe
nel
nord
del
regno
Arakan”
inizia
così
un’antica
leggenda
che
riporta
a
cinque
secoli
fa
“quando
la
sua
terra
venne
invasa
da
un
popolo
barbarico
”.
Il
re
si
recò
dunque
dal
suo
amico
musulmano,
sovrano
di
Chittagong,
regno
ai
confini
del
Bengala,
in
cerca
di
aiuto.
“Prestami
un
esercito
ti
prego,
così
che
possa
riconquistare
il
mio
trono”
– La
richiesta
fu
accolta
e il
re
di
Sittwe
sconfisse
gli
invasori
riprendendo
il
potere
sulla
sua
terra.
Colmo
di
riconoscenza
egli
propose
ai
sodati
venutigli
in
salvo
di
rimanergli
al
fianco,
in
sua
protezione,
ed
in
cambio
avrebbe
dato
loro
un
terreno
ciascuno.
L’esercito
accettò
ed è
così
che
apparve
la
prima
presenza
musulmana
in
territorio
Arakan,
oggi
uno
dei
sette
stati
che
compongono
l’attuale
Unione
del
Myanmar.
La
realtà,
sicuramente
meno
romantica,
scaraventa
l’intera
vicenda
in
epoca
più
recente,
precisamente
in
era
coloniale
britannica
quando
gli
inglesi
controllavano
quella
parte
d’Asia
che
comprendeva
gli
odierni
Pakistan,
India,
Bangladesh
e
Myanmar
(allora
Birmania).
In
quegli
anni
furono
abbattuti
i
confini,
migrazioni
e
deportazioni
caratterizzarono
un’epoca
di
massicci
spostamenti
e le
decine
di
etnie
differenti
vennero
forzatamente
riunite
sotto
il
nome
di
un’unica
dominatrice,
la
corona
inglese.
Etnie
differenti
che
da
tempi
immemorabili
si
sono
combattute,
si
sono
alleate,
si
sono
ignorate,
creando
un
complesso
intreccio
di
stati,
feudi
e
regni
suddivisi
in
tribù,
clan
e
famiglie.
Un
intreccio
non
ponderato
quando,
a
metà
del
novecento,
le
colonie
europee
hanno
tracciato
le
nuove
mappe,
fatte
di
nuovi
confini,
segnati
da
squadre
e
righelli
anziché
da
attente
analisi
sulle
complicate
interconnessioni
tra
i
vari
popoli.
Ad
un
tratto
chi
era
di
qua
avrebbe
dovuto
trovarsi
di
là e
chi
di
là
perseguitato
dagli
abitanti
di
qua.
I
Rohingya
sono
tra
quelli
che
si
son
trovati
nel
posto
sbagliato
al
momento
sbagliato
ed
ora,
a
distanza
di
mezzo
secolo,
si vedono
ancora come
un
popolo
senza
terra,
vittima
sia
di
quelli
di
qua
che
di
quelli
di
là.
Rohingya
è un
termine
che
indica
un’etnia relativamente
nuova:
figli
di
quei
soldati
venuti
a
salvare
il
re
buddista
nella
leggenda
o,
più
semplicemente,
il
prodotto
di
piccoli
spostamenti
al
di
là
di
confini
che
prima
non
esistevano.
Un
nome
dato
ad
un
popolo
che
si
vede
importunato
nel
paese
in
cui
è
nato
e
malvoluto
dal
paese
da
cui
discende,
geograficamente
parlando
afflitto
in
Myanmar,
sgradito
in
Bangladesh.
Una comunità
musulmana
che
abita
in
un
paese
buddista
e che,
oggi, conta
oltre
30.000
rifugiati
costretti
ad
abitare
in
campi
profughi
eretti
nel
versante
bengalese
del
confine.
Un
popolo
obbligato
a
nascondersi
da
entrambe
le
parti,
a
non
poter
far
valere
alcun
diritto,
da
quello
di
sposarsi
a
quello
di
spostarsi.
Il
mio
incontro
con
essi
è
avvenuto
da
entrambi
i
lati
del
confine.
Ho
visitato
prima
la
loro
comunità
a
Sittwe,
in
Myanmar,
poi
ho
preso
una
serie
di
aerei,
treni
ed
autobus
che
mi
hanno
portato
in
Bangladesh,
nella
zona
di
Cox’s
Bazar,
dove
oggi
i
Rohingya
vivono
da
refugees,
profughi.
La
differenza
tra
gli
stili
di
vita
di
quelli
incastrati
di
qua
e
quelli
scappati
di
là è
quasi
impercettibile:
umiliati,
martoriati
e
torturati
da
un
lato;
sovraffollati,
impotenti,
inutili
dall’altro.
Nella
ex
Birmania
un
giovane
volontario
musulmano,
ingaggiato
come
guida, ci
mostrava,
a
bordo
di
un
ciclo
taxi,
vaste
distese
di
terreni,
ora
disabitati
ed
incolti,
usurpati
negli
anni
dai
militari
del
governo
ai
contadini
“calà”.
“Ci
chiamano
calà,
vuol
dire
immigrato,
colui
venuto
di
recente,
ci
chiamano
così
con
disdegno”-
poco
più
avanti
passiamo
dinnanzi
ad
una
bella
moschea
di
pietra
bianca
-
“vedi
questa
moschea?
Fu
costruita
quasi
duecento
anni
fa,
come
fanno
a
dire
che
siamo
venuti
di
recente?”.
Quei
terreni
furono
strappati
con
la
violenza
e
poi
abbandonati;
perfino
i
cimiteri
gli
furono
sottratti
e
ora
le
sepolture
devono
avvenire
in
piccoli
riquadri
di
terra,
circostanti
alle
moschee,
sovraffollati
di
tombe
e
cadaveri.
La nostra
giovane
guida
racconta
delle
torture
fisiche
subite
dai
soldati
governativi
e di
quelle
psicologiche
inflitte
dagli
Arakaneese,
gli
abitanti
“originari”
e
buddisti
dello
stato
Arakan.
“Se
andiamo
all’ospedale
dobbiamo
pagare
di
più,
se
andiamo
a
scuola
dobbiamo
pagare
di
più.
Ed a
proposito
di
scuola” -
aggiunge
- “
a
noi
non
è
concesso
studiare
l’inglese
né
laurearci
in
medicina
ed
ingegneria”.
Il
governo
proibisce
loro
diplomi
che
potrebbero
portare
a
mestieri
altolocati.
“Questa
è
anche
la
nostra
terra,
e
noi
chiediamo
solo
di
vivere
in
pace”.
Questa
frase,
pronunciata
quasi
con
sottomissione,
è la
frase
che
avrei,
poco
più
avanti,
sentito
e
risentito
uscire
dalle
bocche
e
dai
cuori
di
centinaia
di
altre
persone,
uomini
e
donne:
“Chiediamo
solo
di
vivere
in
pace”.
A
soli
cento
chilometri
a
nord
di
Sittwe,
un
tratto
di
strada
però
inaccessibile
per
un
occidentale,
scorre
la
linea
di
confine
tra
Myanmar
e
Bangladesh.
Una
linea
di
speranza
ma
che
in
realtà
divide
semplicemente
la
padella
dalla
brace.
Un
confine
che
offre
poco,
anzi
pochissimo,
in
cui
tutti
coloro
che
lo
hanno
varcato
hanno
trovato
ulteriore
povertà
e
cattiveria,
miseria
ed
ingiustizia.
Moltissimi
di
questi
sono
stati
catturati
dagli
invisibili
artigli
ed
inghiottiti
nelle
viscere
di
TAL:
un
ammasso
disumano
di
devastazione.
Andando
verso
sud, lungo
la strada
che
collega
il
capoluogo Cox’s
Bazar
con
Teknaf,
la
cittadina
di confine,
in
seguito
ad
un
massiccio
posto
di
blocco
dell’esercito
bengalese,
sulla
sinistra,
appaiono
le
prime
baracche:
soffitti
fatti
di
teloni
di
plastica
nera
che
si
appoggiano
su
muri
composti
da
sacchi
di
patate
inchiodati
a
rami
di
legno
impalati
nel
fango.
Le
prime
presto
diventano
le
seconde,
poi
le
terze
fino
a
diventare
un
amalgama
continuo
di
legna
e
plastica
che
si
sussegue
ininterrottamente
per
un
chilometro.
Percorrendo
la
strada
in
auto
è
impossibile
distogliere
lo
sguardo
da
tanto
orrore.
Nel
cuore
nasce
la
spontanea
speranza
di
trovarsi
davanti
ad
un
reperto
abbandonato
o a
una
serra
di
qualche
frutto
esotico
che
cresce
nella
melma
e a
tutto
si
pensa
fuorché
ad
un
luogo
abitato,
per
di
più
da
esseri
umani.
E
invece
così
è.
TAL
è un
campo
profughi che
contiene oltre
10.000
persone:
accampate,
rannicchiate,
malate,
sovraffollate,
disperate,
accaldate,
affamate
ed
assetate.
Condizioni
di
vita
in
cui
una
sola
di
queste
porterebbe
rabbia
e
malcontento
e
che
messe
tutte
insieme
creano
quell’incubo
inimmaginabile
e
così
difficile
da
raccontare.
La
prima
intervista
ad
un
uomo
che
abita
in
uno
scheletro
di
baracca
perché
non
ha
abbastanza
soldi
per
permettersi
i
teli
di
plastica
per
il
rivestimento
esterno:
-
“Perché
sei
qui?”
-
“Perché
il
governo
del
Myanmar
mi
ha
confiscato
la
terra,
mi
ha
arrestato,
torturato
e
costretto
ai
lavori
forzati”
-
“Perché
ti
hanno
confiscato
la
terra?”
-
“Perché
sono
musulmano,
un
Rohingya,
considerato
un
immigrato”
-
“Immigrato?
Da
quante
generazioni
abitate
nell’Arakan?”
- “
Non
lo
so
di
sicuro,
certo
è
che
il
padre
di
mio
nonno
è
nato
in
Birmania”.
Ad
un
tratto
veniamo
interrotti
dalle
urla
di
una
donna.
Ha
gli
occhi
spiritati,
piange
senza
lacrime,
grida.
Dritta
verso
di
noi
ci
urla
contro,
il
nostro
interprete
cerca
di
decifrare
e a
tradurre.
“Ieri
è
morta
la
mia
bambina!
L’ha
investita
da
un
camion!
Fate
qualcosa,
perché
state
lì
senza
far
nulla?”
Era
impazzita.
La
sua
bambina,
di
undici
anni,
è
una
delle
indecifrabili
vittime
che
ogni
anno
perde
la
vita
sotto
le
ruote
di
un’auto.
Le
strade
in
Bangladesh
sono
strettissime,
gli
autisti
di
camion,
autobus
ed
automobili
raramente
hanno
la
patente
ed i
limiti
di
velocità
sono
inesistenti.
La
regola
che
vige
è
quella
del
più
grosso:
in
un
sorpasso,
seppur
sia
il
camion
a
trovarsi
nella
corsia
opposta,
sta
alla
macchina,
motorino
o
bicicletta
(in
direzione
giusta)
lanciarsi
disperatamente
nel
fossato
per
evitare
lo
scontro.
Nelle
strade
in
Bangladesh
il
rallentare
è
sostituito
dal
suono
del
claxon
e i
bambini
spesso,
presi
dal
gioco,
non
fanno
in
tempo
a
decifrare
quel
suono
letale.
TAL
dimora
sul
bordo
di
una
di
queste
strade.
Tentiamo
di
entrare
all’interno
di
una
di
queste
baracche.
Un
uomo
barbuto
con
la
pelle
del
viso
incollata
alle
ossa,
seduto
sull’uscio,
ci
invita
ad
entrare.
Ha
lo
sguardo
opaco,
perso
verso
un
orizzonte
inesistente.
Ci
sediamo
in
due,
l’uomo
rimane
sull’uscio.
Per
accomodarci
ci
vogliono
una
serie
di
assestamenti,
i
nostri
corpi
si
toccano,
stiamo
stretti.
Lo
spazio
dobbiamo
condividerlo
anche
con
due
pentole,
tre
ciocchi
bruciacchiati
e
due
mattoni
su
cui
poggia
una
delle
pentole.
Allargando
le
braccia
in
ogni
direzione
le
mie
mani
toccano
i
muri
da
entrambi
i
lati,
la
casa
misura
due
metri
per
due,
in
più
stando
seduto
devo
rimanere
ricurvo
perché
la
testa
non
sbatta
sul
soffitto
(di
plastica).
“Quanti
siete
ad
abitare
qui?”
- “In
quattro”.
In
una
baracca
a
pochi
metri,
poco
più
grande,
sono
in
sette.
“L’aria
non
passa”-
si
lamenta
una
donna-
“l’acqua
piovana
eccome!”.
Oggi
non
ha
piovuto
e il
termometro
segnava
trentacinque
gradi
sotto
un
sole
cocente.
Il
pavimento
all’interno
delle
abitazioni
è lo
stesso
di
quello
all’esterno:
terra,
che
durante
i
sei
mesi
di
monsoni
diventa
prima
fango
e
poi
torrente.
-
“Perché
sei
qui?”
- La
solita
ed
unica
domanda
usata
a
capo
di
tutte
le
altre.
-“Mio
figlio
si è
sposato
segretamente
ma
il
governo
militare
è
venuto
a
saperlo
e
prima
che
lo
arrestassero
siamo
scappati
tutti
in
Bangladesh.”
-
“Perché
si è
dovuto
sposare
segretamente?”
-“I
musulmani
hanno
bisogno
di
un
permesso
per
sposarsi,
e
questo
costa
troppi
soldi,
è
difficile
poterselo
permettere”.
I
Rohingya
hanno
anche
bisogno
di
un
permesso
per
spostarsi
da
una
cittadina
all’altra.
-
“Per
andare
a
trovare
la
mia
famiglia
devo
chiedere
il
permesso
al
governo
e
pagare
molti
soldi
sottobanco”.
Il
perché
dei
permessi
è
molto
semplice:
i
Rohingya
non
hanno
nazionalità,
non
hanno
documenti,
non
hanno
identità.
Li
avevano
ma
gli
sono
stati
tolti.
Nel
1991
il
governo
dell'autoimposto-dittatore
Ne
Win,
tra
le
altre
sanguinarie
riforme,
ha
iniziato
una
dura
campagna
contro
questi
musulmani
indesiderati,
imponendo
loro
di
consegnare
le
carte
di
identità.
Quella
vicenda
causò
la
prima
ondata
di
profughi:
250.877
persone
attraversarono
la
frontiera.
Una
volta
privi
di
documenti,
i
Rohingya
e
tutti
i
loro
averi
divennero
presto
bottino
e
proprietà
di
governo
e
popolazione
locale.
Il
primo
li
arresta,
li
obbliga
ai
lavori
forzati
e
confisca
loro
la
casa
e il
terreno,
i
secondi
li
umiliano,
non
offrono
loro
lavoro
e li
impediscono
l’accesso
a
sanità
ed
educazione.
La
puzza
di
escrementi
è
onnipresente
in
TAL.
Putrido
ovunque,
cacche,
diarree,
fanghiglia,
zanzare.
Un
colpo
alla
vista
ma
soprattutto
all’olfatto.
Una
signora
scarta,
avvolta
in
uno
scialle,
una
creatura
fatta
di
ossa
ricoperte
da
un
fino
strato
di
pelle.
Un
bambino
o
forse
una
bambina
di
due
anni,
sembrava
nato
da
poche
settimane.
Si
capiva
che
era
vivo
solo
dal
suo
tentativo
pigro
di
tenere
gli
occhi
aperti:
occhi
malati,
spenti.
Così
ogni
persona
incontrata
nel
campo:
malata,
malnutrita,
inebetita.
Soltanto
una
piccola
squadra
di
MSF
(Medici
Senza
frontiere)
operativa
da
una
clinica/baracca
costruita
sulla
sponda
opposta
della
strada
interviene
nel
tentativo
di
salvare
qualche
vita.
“TAL
non
è un
vero
e
proprio
refugee
camp”
-
spiega
Jim
Worrol,
Amministratore
Esecutivo
della
UNHCR
(United
Nations
High
Commetee
for
Refugees)
a
Cox’s
Bazar
-
“non
fu
mai
riconosciuto
come
tale
dal
governo
bengalese
e
per
questo
l’UNHCR
non
è
potuta
intervenire”.
Ora
finalmente,
a
distanza
di
anni,
questa
gente
verrà
trasferita.
La
Islamic
Relief
(una
ONG
fondata
in
Inghilterra
nel
1984)
prenderà
le
redini
del
nuovo
campo
al
momento
ancora
in
costruzione,
avviando
i
lavori
di
trasloco
entro
la
fine
dell’anno.
Diventeranno
così
tre
i
campi
uffcializzati
aggiungendosi
ai
già
esistenti
Kutupalong
Refugee
Camp
e
Nayapara
Refugee
Camp, fondati
dalla
UNHCR
e
contenenti
un
totale
di
2.956
famiglie.
Nel
1994
una
triplice
commissione,
formata
dai
due
governi
in
questione
intermediati
dalla
UNHCR,
emise
la
sentenza
di
rimpatriare
i
profughi:
il
Bangladesh
non
li
riconosceva
più
come
tali.
236.599
persone,
al
tempo
disposte
in
20
campi
d’accoglienza,
furono
ritrasferite
oltre
confine
e
rimesse
nelle
mani
della
giunta
militare
birmana.
Il
flusso
fuggitivo
però,
da
allora
fino
ad
oggi,
continua
imperterrito
nella
sua
evasione
in
direzione
inversa.
Il
governo
bengalese
sembra
essersi
arreso
nella
sua
lotta
intollerante
di
respinta.
L’ultima
deportazione
la
applicò
nel
2005
rispedendo
in
Myanmar
appena
novantadue
persone.
Da
allora
sulle
tabelle
della
RRRC
(Refugee
Relief
Repatriation
Commissioner)
accanto
alla
voce
“rimpatriati
quest’anno”
appare
la
scritta
NIL.
La
speranza
per
i
Rohingya
risiede
là
dove
risiede
la
speranza
per
ogni
birmano.
Democrazia,
Aung
San
Suu
Kyi,
pace
e
fine
del
regime
militare
sono
le
uniche
parole
che
si
ripetono,
da
anni,
inutilmente
e
senza
tregua.
Anche
qui,
nei
campi
profughi
dei
Rohingya,
la
nostra
presenza
ha
acceso
occhi
pieni
di
speranza.
“Ci
aiuterete
vero?”
–
domandano
fiduciosi.
Nonostante
la
razionale
consapevolezza
che
i
tempi
di
cambiamenti
siano
ancora
molto
lontani
rispondiamo
con
il
solito
energico
-
“Ci
proveremo!”-
cercando
di
alleviare
così
quel
bagaglio
di
responsabilità
tanto
dolcemente
adagiatoci
addosso.

|
|
|
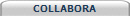
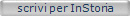
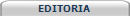
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
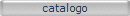
.
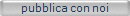
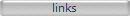
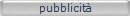
InStoria.it




|