|
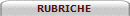

.

.

.

.
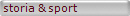
.
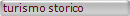
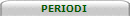
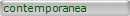
.

.
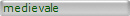
.


.
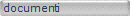
.
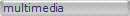
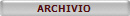


|
N. 27 - Marzo 2010
(LVIII)
ASIA, BUDDHA E un reporter senza lavoro
PARTE XI – Dietro le quinte di un documentario
di Gianrigo Marletta
Dopo
molti
articoli
scritti
ed
un
piccolo
documentario
già
girato,
si
ritorna
in
Birmania
per
raccogliere
notizie
e
raccontarne
nuovamente
la
storia.
Nel
recente
agosto
del
2007
molto
è
successo
nell’odierno
Myanmar
e
molto,
seppur
per
poco,
è
stato
detto.
Ora
di
nuovo
il
silenzio.
Un
silenzio
che
rimbomba
troppo
forte
nelle
vite
dei
birmani,
un
silenzio
che
forse
non
meritano,
un
dimenticatoio
in
cui,
di
nuovo,
stanno
per
precipitare.
Ecco
la
decisione
di
tornare
sul
posto,
di
rischiare
nuovamente,
di
augurarsi
di
non
essere
già
conosciuti
dalle
autorità
del
regime
e
per
questo
arrestati
o
espulsi,
di
sperar
di
non
mettere
alcun
birmano
in
pericolo
semplicemente
puntandogli
una
telecamera
addosso,
registrando
la
sua
disperazione.
Questa
volta
cercheremo
di
uscirne
con
un
documentario
fatto
meglio,
con
un
film
che
duri
almeno
un’ora
e
mezza,
con
un’opera
che
venga
esposta
in
rassegne
e
festival
più
prestigiosi
e
per
questo
con
più
occhi
che
la
osservino.
Ciò
che
segue
è la
narrazione
dei
preparativi
e
delle
emozioni
alle
quali
un
documentarista
è
sottoposto.
Il
grosso
è
stato
deciso
in
una
stanza
d’albergo.
Precisamente
in
una
stanza
d’albergo
al
ventunesimo
piano
di
un
grattacielo
di
New
York.
È lì
che
si
sono
discussi
i
particolari.
È lì
che
sono
state
decise
date
e
luoghi.
È
dal
piccolo
computer
portatile
collegato
al
cavo
telefonico
della
stanza
che
abbiamo
scaricato
le
mappe
e
gli
articoli
di
recente
data
riguardanti
il
caso.
È lì
che
è
stato
buttato
giù
il
copione,
la
linea
guida
di
sei
pagine
da
seguire.
Seppur
siano
gli
eventi
e la
fortuna
a
decidere
il
corso
e lo
svolgimento
delle
riprese
per
un
documentario
vi è
sempre
bisogno
di
un
testo
guida,
di
un
foglio
di
carta
che
ricordi
ad
ogni
momento
le
piste
da
seguire
e le
domande
da
fare.
Sembrerebbe
cosa
semplice,
fare
domande,
ma
puntualmente
al
momento
di
farle
ecco
che
tutto
svanisce.
L’emozione
s’intromette
sempre.
L’emozione
di
entrambi,
di
colui
che
chiede
e di
colui
che
risponde.
Si
dimenticano
i
concetti
e le
parole
non
vanno
mai
dannatamente
al
di
là
della
punta
della
lingua.
Le
circostanze
poi
non
sono
mai
ottimali.
Suoni,
rumori,
distrazioni
e
nel
nostro
caso
paura
e
paranoia
sono
i
nemici
più
spietati.
È
comico
notare
come
un
luogo
silenzioso
e
semideserto
al
momento
dei
un’intervista,
si
popoli
improvvisamente
di
camion
e
motorini
rumorosi,
passanti
curiosi
ed
elicotteri
sorvolanti.
La
paura
di
essere
scovati
obbliga
a
grandi
precauzioni.
L’equipaggiamento
deve
essere
piccolo
e
leggero
ma
anche
professionale.
La
qualità
delle
immagini
non
deve
soffrire
per
la
necessità
di
rimanere
anonimi.
I
trucchi
sono
pochi
e
non
sempre
efficaci.
Le
telecamere
devono
rimanere
perennemente
pronte
all’uso
eppure
anche
ben
nascoste
nel
bagaglio.
Agganciate
all’apparecchio
vi
sono
altri
dispositivi
che
tutt’altro
sembrano
che
la
telecamera
di
un
viaggiatore
appassionato:
lenti
e
microfoni,
trasmittenti
senza
fili,
antenne
e
un’infinità
di
cassette
vergini
su
cui
registrare.
Con
noi
abbiamo
due
telecamere
Canon,
una
grigia
ed
una
nera
( i
colori
diversi
per
non
far
sembrare
la
cosa
troppo
organizzata)
ed
una
gran
bella
macchina
fotografica.
Il
terrore
più
grande
è
quello
di
far
la
fine
di
Tim
Syrota,
il
nostro
amico
documentarista
australiano
(autore
del
libro
Welcome
to
Burma)
che
nel
2005
è
stato
drogato
dai
soldati
della
SPDC
mentre
viaggiava
in
pullman
e,
risvegliandosi
in
un
fosso
lungo
l’autostrada
che
collega
Yangon
con
Mandaly,
notò
che
tutte
le
cassette
su
cui
aveva
registrato
erano
sparite.
Essere
drogati
non
è
poi
molto
considerando
la
pena
che
deve
scontare
il
contadino
birmano
se
viene
colto
a
raccontare
la
sua
triste
e
disperata
storia
ad
un
reporter
dell’Occidente.
Nulla
gli
accade
in
quel
momento
sotto
gli
occhi
dell’uomo
bianco,
ma
presto,
precisamente
nel
mezzo
della
notte,
egli
deve
aspettarsi
il
famoso
tok
tok
alla
porta.
Ciò
che
segue
quel
suono,
che
ogni
birmano
riproduce
con
terrore,
nessuno
lo
sa
semplicemente
perché
nessuno
è
mai
tornato
per
raccontarlo.
Questa
volta
non
raccoglieremo
immagini
e
testimonianze
solo
all’interno
dei
confini
della
Birmania.
Andremo
anche
in
Bangladesh
negli
orrendi
campi
profughi
della
martoriata
tribù
dei
Rohingya,
fuggiti
dal
regime
della
giunta;
in
Cina,
nelle
città
di
confine
dove
i
due
paesi
commerciano
indisturbati
ogni
genere
di
merce
inclusa
quella
umana
ed
ovviamente
in
Tailandia,
nella
cittadina
di
confine
situata
a
nord
ovest
chiamata
Mae
Sot.
È
qui
che
si
nascondono
gran
parte
dei
fuggitivi,
profughi
e
rifugiati
politici,
è
qui
che
convergono
gran
parte
gli
aiuti
da
parte
delle
Organizzazioni
Non
Governative
di
tutto
il
mondo
ed è
qui
che
si
raccolgono
le
informazioni
più
utili
e le
interviste
più
succulente.
Siamo
appena
all’inizio
e la
speranza
che
tutto
vada
alla
perfezione
è
smisurata.
Con
il
documentario
che
ne
uscirà
fuori
tenteremo,
ancora
una
volta,
di
rimuovere
questo
paese
già
dimenticato
dall’oscuro,
ma
soprattutto
di
sensibilizzare
quelle
persone
e
quei
paesi
che
ancora,
imperterriti,
continuano
a
commerciare
e a
fare
affari
con
questo
regime
tanto
affamato
di
crudeltà.
Non
ci
vuole
molto
a
girare
un
documentario
del
genere,
basta
un
po’
di
coraggio,
dello
spirito
di
avventura
e
tanta,
tantissima
fortuna.
Il
resto
lo
deciderà
lo
spettatore.
Tre
giorni
con
la
SSA
Un
giorno
di
aprile,
metà
aprile,
da
qualche
parte
nel
Nord
Est
della
Birmania.
Anno
2008.
Mi
trovo
in
un
campo.
Campo
inteso
come
campo
militare.
Precisamente
nel
campo
militare
della
SSA
(Shan
State
Army)
uno
dei
maggiori
gruppi
armati
intenti
a
proteggere
il
proprio
popolo,
quello
Shan,
dalle
barbarie
del
governo
birmano.
È
tutto
iniziato
di
mattina,
quando
Saigon
(questo
è il
soprannome
che
gli
abbiamo
dato)
la
nostra
guida
trovata
praticamente
per
strada
a
Bagò,
una
cittadina
del
sud,
si è
presentato
alla
guest
house
di
Mr
Charles
con
due
motorini:
“Andiamo”.
Il
fatto
che
eravamo
in
cinque
non
è
mai
stato,
neanche
per
un
secondo,
un
problema.
Tre
su
uno
e
due
sull’altro:
io
alla
guida
di
quello
da
tre,
mentre
Saigon
trasportava
il
suo
unico
passeggero
Bruno.
La
canna
dell’Ak-47
mi è
stata
puntata
alla
faccia
dopo
quattro
ore
ininterrotte
di
viaggio,
a
bordo
delle
due
ruote
traballanti,
sulle
strade
fatte
di
sabbia
e
sassi.
Più
che
strada
sarebbe
corretto
definirla
sentiero,
un
sentiero
che
taglia
a
metà
una
vegetazione
arida
e
bruciacchiata
conficcata
in
un
deserto
di
sabbia
rossa.
La
canna
dell’AK-47
mi è
stata
puntata
alla
faccia
all’arrivo
presso
il
cancello
del
monastero.
Non
avrei
mai
immaginato
di
trovarmi
già
in
territorio
dell’esercito
Shan,
convinto
com’ero
che
prima
ci
saremmo
imbattuti
in
uno
o
più
posti
di
blocco
della
SPDC.
Per
l’occasione
avevamo
comprato
due
bottigliette
di
rhum
destinate
a
corrompere
i
soldati
in
cambio
di
un
lascia
passare.
Ma
nessuna
sbarra
o
transenna
di
filo
spinato,
nessun
posto
di
blocco
dell’esercito
birmano
a
frenare
la
nostra
corsa.
Eravamo
“dentro”
e il
viaggio
mi
aveva
condotto
dritto
verso
la
canna
dell’AK-47.
Saigon,
che
aveva
preso
la
missione
molto
seriamente,
trattandosi
della
sua
gente,
aveva
in
precedenza
contattato
un
suo
amico
d’infanzia,
monaco,
il
quale
ci
stava
aspettando
sul
ciglio
della
strada
appena
dieci
chilometri
dall’albergo.
Fortunatamente
aveva
con
sé
un
motorino
e
questo
ci
portò
a
viaggiare
comodamente
in
coppie
per
le
restanti
quattro
ore.
Il
monaco
pronunciò
poche
parole
e
quella
canna
dell’AK-47
di
tolse
dalla
mia
faccia
diventando
lo
strumento
con
cui
la
sentinella,
un
ragazzino
di
tredici
anni,
ci
fece
segno
di
benvenuto.
Eravamo
dentro!
L’eccitazione
indescrivibile.
Grazie
ad
una
combinazione
di
eventi,
calcolati
e
casuali,
ero
finalmente
entrato
nel
campo
della
SSA.
Nessuno
ci è
mai
venuto,
questa
frase
me
l’hanno
ripetuta
cento
volte,
è la
prima
volta
che
dei
bianchi
occidentali
mettono
piede
qui.
Il
benvenuto
è
stato
caloroso
anche
se
un
po’
bizzarro.
“
Non
sappiamo
e
non
sapremo
mai
se
siete
sinceri
o
spie
del
governo”
- ci
ha
detto
guardandoci
dritti
negli
occhi
uno
degli
ufficiali
venutici
incontro
-
“ma
in
entrambi
i
casi
vi
diamo
il
benvenuto”.
La
mia
reazione
spontanea
fu
quella
di
mettermi
una
mano
sul
cuore
e
l’altra
nella
borsa
per
estrarre
il
mio
tesserino
finto
da
giornalista,
qualsiasi
cosa
purché
non
pensassero
che
siamo
spie.
“Ecco
vedi,
siamo
giornalisti!”-
L’ufficiale,
che
tutto
sembrava
tranne
che
un
ufficiale,
vestito
a
quella
maniera
con
il
longy
(tipico
pareo
a
quadretti
che
tutti
gli
abitanti
della
Birmania
tengono
legato
intorno
al
bacino)
e la
canottiera
bianca,
coperto
dalla
testa
ai
piedi
di
tatuaggi,
respingendo
il
mio
“documento”
mi
sorrise,
dicendo
di
credermi.
Fummo
accompagnati
nel
cortile
del
monastero
dove
ci
sedemmo
attorno
ad
una
grandissima
tavola
rotonda
protetta
da
un
enorme
ombrellone
di
paglia.
Il
sole
ardeva
ogni
cosa.
Bruno
il
canadese
era
lì
per
l’esperienza.
Lo
avevamo
conosciuto
a
Yangon
due
giorni
prima
di
partire
per
il
nord.
Bruno
era
un
aspirante
giornalista
e ci
pregò
di
portarlo
con
noi,
promettendo
di
aiutarci
durante
il
corso
delle
riprese.
È
stato
grazie
a
lui
che
avevamo
con
noi
Saigon,
si
erano
conosciuti
qualche
giorno
prima.
Saigon
era
lì
un
po’
per
staccare
dagli
studi
universitari
che
lo
impegnavano
a
Bagò,
due
giorni
di
viaggio
dalla
sua
terra
nativa
che
non
vedeva
da
dieci
anni,
e un
po’
per
approfittare
della
“troupe
di
giornalisti”
venuti
a
filmare
la
sua
gente.
Il
nostro
cameraman
Jeffrey
era
lì
perché
lo
pagavano.
Jennifer
condivideva
il
mio
stesso
eccitamento.
Non
era
la
prima
volta
che
entravamo
in
un
campo
militare
di
rivoluzionari,
era
però
la
prima
volta
ad
essere
i
primi
a
visitarne
uno
e la
cosa
ci
diede
un
profondo
senso
di
responsabilità.
Portavamo
con
noi
un’invisibile
bandiera,
la
bandiera
dell’Occidente,
uno
stendardo
che
loro
vedono
come
speranza.
Rappresentavamo
un
convoglio
di
ambasciatori
più
che
un
gruppo
di
reporter
curiosi
e
una
volta
tornati
saremmo
stati
gli
unici
a
riportare
le
loro
testimonianze,
a
rappresentarli
ed a
raccontare
al
mondo
la
loro
storia.
Sentivo
questa
responsabilità
e
cercai
di
registrare
tutto
con
meticolosa
attenzione.
La
nostra
presenza
smosse
l’intero
plotone.
Furono
cucinati,
per
i
tre
giorni
di
nostra
permanenza,
i
cibi
migliori;
fummo
accomodati
nella
casa
del
capitano,
capo
assoluto
del
campo,
e di
sua
moglie.
Ci
vennero
offerti
alcolici
ed
addirittura
ci
obbligarono
ad
accettare
dei
soldi,
da
puntare
ai
giochi
da
circo
che
in
quei
giorni,
in
occasione
della
festa
dell’acqua,
si
svolgevano
nelle
bancarelle
erette
per
l’occasione.
Eravamo
costantemente
seguiti
da
una
scorta
armata.
Uno
dei
generali
dalla
faccia
simpatica
ma
che
non
amava
parlare
ci
aveva
preso
in
simpatia
e ci
accompagnava
ovunque
andassimo.
Lo
soprannominammo
cowboy
perché
aveva
un
cappello
stile
texano
ed
una
magnum
perennemente
infilata
nei
pantaloni.
I
tatuaggi
sono
una
caratteristica
tipica
del
popolo
Shan.
Vengono
incisi
con
lunghe
canne
di
bambù
esclusivamente
da
monaci.
Le
rappresentazioni
variano
tra
scritte,
figure
geometriche
con
scritte
e
personaggi
mistici
con
scritte.
In
tutti
e
tre
i
casi
seguono
la
tradizione
pali,
cioè
la
lingua
che
precede
il
sanscrito
e
che
veniva
parlata
all’epoca
e
nella
zona
dell’India
in
cui
visse
Buddha.
Ogni
tatuaggio
è
una
benedizione,
un
amuleto
intento
a
proteggere.
“Questo
tatuaggio
mi
ripara
dalle
pallottole
dei
birmani”
- ci
diceva
il
capitano,
un
uomo
di
sessanta
e
passa
anni,
mentre
si
indicava
una
scritta
sul
petto
completamente
imbrattato
di
simboli.
Anche
i
bambini
sono
quasi
interamente
tatuati,
ma
la
cosa
non
sconvolge
tanto
quanto
l’arma,
spesso
più
grande
di
loro,
che
devono
sempre
avere
in
spalla.
Il
soldato
bambino,
in
questa
circostanza,
mi
ripugna
di
meno
che
nei
casi
in
Africa
o
nella
stessa
Birmania,
dalla
parte
del
governo:
famoso
per
l’utilizzo
di
questa
penosa
risorsa.
Innanzi
tutto
questi
bambini
(Shan)
sono
figli
di
qualcuno,
hanno
un
padre
e
una
madre
che
li
amano
e li
educano,
a
differenza
dell’esercito
della
SPDC
che
rapina
o
recluta
i
bambini
nelle
aree
più
povere
e
remote
del
paese.
I
padri
di
questi
child
soldiers
sono
loro
stessi
soldati
con
forti
valori
familiari
e
culturali.
Nel
caso
del
governo
invece
i
bambini
vengono
istruiti
semplicemente
a
morire
e ad
uccidere.
Ai
bambini
Shan
viene
insegnato
che
l’arma
serve
solo
a
proteggersi
dall’aggressore,
ai
bambini
schierati
dall’altra
parte
viene
insegnato
ad
aggredire
e
basta.
Forse
la
cosa
che
colpisce
di
più
in
questo
campo
è
l’unità
ed
il
supporto
con
cui
ogni
membro
del
clan
contribuisce
al
benessere
ed
alla
sicurezza
della
sua
gente.
I
monaci
aiutano
i
soldati,
i
soldati
proteggono
i
contadini,
i
contadini
procurano
il
cibo
alle
donne
e le
donne
alimentano
i
monaci.
L’abate
stesso
del
monastero
centrale
porta
sempre
con
sé
una
radio
trasmittente,
un
walkie
talkie
gigante
verde
militare
che
tiene
costantemente
attaccato
all’orecchio.
È
buffo
guardarlo,
seduto
nella
posizione
del
loto
a
meditare,
con
la
radiolina
che
di
tanto
in
tanto
emette
frasi
del
tipo
“l’aquila
sta
bevendo,
passo”.
Ma
torniamo
al
popolo
Shan
ed
al
perché
vi
fu,
nel
1962
la
necessità
di
creare
un
esercito
che
li
difendesse.
Il
termine
con
cui
essi
si
autodefiniscono
in
realtà
è
Tay
o
Thai
che
si
pronuncia
Dhai
(a
differenza
di
Shan:
nome
dato
loro
dagli
inglesi).
La
loro
lingua
è
assai
simile
a
quella
parlata
nel
Laos,
che
a
sua
volta
è
simile
al
thai,
tailandese.
Seppure
l’epicentro
del
territorio
Shan
sia
la
vastissima
regione
nel
nord
della
Birmania
essi
risiedono
in
un’area
ben
più
grande
che
va
dal
sud
della
Cina,
passando
per
Laos,
Thailandia,
Cambogia
fino
al
Vietnam.
L’unico
vero
e
proprio
stato
Shan
però
si
trova
in
Myanmar
ed è
per
questo
che
è
solo
in
Myanmar
che
si
trovano
a
dover
combattere.
Come
negli
altri
casi
di
minoranze
etniche
in
territorio
birmano,
gli
Shan
sono
oggi
forzatamente
inclusi
nelle
linee
geografiche
di
un
paese
che
non
è il
loro
e
obbligati
ad
essere
cittadini
sottomessi
ad
un’altra
etnia,
quella
dei
Bamar
(Birmani).
Con
una
storia
millenaria
di
conquiste
e
sottomissioni
nell’intera
penisola
indocinese
il
popolo
Shan
nel
dopoguerra
(seconda
guerra
mondiale)
venne
chiamato
a
partecipare
al
nuovo
disegno
geografico
che
i
nuovi
mappamondi
dell’epoca
post-coloniale
avrebbero
dovuto
riportare.
Nel
1947
i
leader
Shan,
insieme
ai
capi
delle
altre
entine
del
territorio,
si
unirono
ai
Bamar,
che
costituivano
la
maggioranza,
nella
lotta
contro
gli
inglesi
per
l’indipendenza.
Ottenutala,
parteciparono
in
quella
che
venne
chiamata
la
Conferenza
di
Panglong,
tenutasi
proprio
nello
stato
Shan
e
capeggiata
dal
Generale
Aung
Sang,
(eroe
che
condusse
infine
l’Unione
all’indipendenza
e
padre
di
Aung
San
Suu
Kyi),
per
riorganizzare
le
politiche
di
un
paese
appena
nato:
L’Unione
della
Birmania.
Durante
la
conferenza,
in
una
clausola,
fu
scritto
che:
superato
il
decimo
anno
d’indipendenza,
lo
Shan
State,
se
lo
avesse
voluto,
avrebbe
ottenuto
la
completa
autonomia
dal
resto
degli
stati.
La
linea
storica
che
il
paese
appena
nato,
ricco
e
glorioso,
aveva
appena
imboccato
fu
presto
bruscamente
deviata.
Nel
1962
il
Generale
Ne
Win,
con
un
colpo
di
stato,
prese
il
potere
cambiando
le
carte
in
tavola
e
mettendo
a
ferro
e
fuoco
l’intero
paese.
Tutte
le
promesse
e
gli
accordi,
sia
per
gli
Shan
che
per
le
altre
minoranze,
vennero
cancellati
e
qualsiasi
tentativo
di
ribellione
soppresso
nel
sangue.
La
nostra
visita
alla
SSA
si
concluse
con
l’intervista,
la
nostra
missione
fu
portata
a
termine.
Il
terzo
giorno
finalmente
i
generali
si
decisero
di
concedercene
una,
di
parlare
davanti
agli
obbiettivi
delle
nostre
telecamere.
Fino
all’ultimo
vivemmo
nell’incertezza
e
nella
speranza
di
un
“sì”
che
però
tardava
ad
arrivare.
Saigon
cercava
ripetutamente
di
tranquillizzarci:
“vedrete
che
ce
la
concederanno”.
I
motivi
di
tanta
indecisione
erano
diversi:
primo
c’era
il
fatto
della
loro
completa
incertezza
sul
nostro
non
essere
spie,
poi
si
doveva
capire
se
mostrare
i
propri
volti
alle
telecamere,
che
li
avrebbero
poi
ingranditi
e
proiettati
sugli
schermi
di
tutto
il
mondo,
era
saggio.
Infine
esisteva
il
problema
di
decidere
se e
come
fare
entrare
questi
quattro
stranieri,
accompagnati
da
uno
Shan,
nel
cuore
del
Quartier
Generale:
luogo
segreto
dalla
locazione
estremamente
confidenziale.
La
mattina
alle
cinque
e
mezza
spaccate
rivetti
una
botta
da
parte
di
Jeffry
-
“svegliati!
C’e’
il
generale!”.
Dormivamo
tutti
e
cinque
accucciati
per
terra
nella
palafitta
di
bambù
di
un
contadino
che,
o
per
gentilezza
o
sotto
ordine,
ci
aveva
ospitati
per
quella
notte.
Mi
alzai
di
scatto,
mettendomi
quasi
sull’attenti,
e
prima
ancora
di
rendermi
conto
di
dove
fossi
e di
cosa
stesse
succedendo
risposi
con
le
uniche
due
parole
in
Shan
che
avevo
imparato
fino
a
quel
giorno:
“Buongiorno
Generale!”
Lui
ci
fissò
per
alcuni
istanti,
ci
sorrise
e ci
ordinò
di
andare
a
sciacquarci.
Dopo
una
breve
colazione
sarebbe
venuta
a
prelevarci
una
jeep
che
ci
avrebbe
condotti
al
Quartier
Generale.
Non
potevo
crederci,
avevano
accettato!
L’auto
era
una
4x4
verde
militare
con,
per
l’occasione,
tutti
i
finestrini
coperti
da
lenzuola
scure.
Non
dovevamo
intravedere
nulla
e
soprattutto
nessuno
doveva
intravedere
noi.
Al
termine
di
un
viaggio
durato
circa
mezzora,
la
jeep
si
fermò
di
fronte
a
un’enorme
struttura
di
cemento,
anche
lei
verde
militare.
Sul
tetto
piatto
spuntavano
diverse
antenne
paraboliche.
“Svelti
entrate”-
ci
fu
comandato,
e
noi
ci
precipitammo
verso
l’unica
porta
che
si
affacciava
su
quel
lato
della
struttura.
Il
cuore
mi
batteva
fortissimo,
ero
eccitato,
incredulo,
soddisfatto.
All’interno
si
aprì
un
salotto
dalla
vastità
enorme.
Circa
quindici
generali,
verdi,
dalle
divise
lucide
e
stirate,
ognuno
con
una
sfilza
di
medaglie
colorate
e
piene
d’importanza
a
luccicargli
sui
petti,
si
alzarono
di
colpo
e,
senza
spostarsi
dal
punto
in
cui
si
misero
in
piedi,
ci
salutarono
con
la
mano
offrendoci
un
caloroso
sorriso
di
benvenuto.
Lo
stanzone
non
era
niente
di
ché,
se
non
fosse
stato
per
le
bellissime
panche
di
tek,
intarsiate
e
lucidate,
poste
ad
intermittenza
lungo
i
quattro
muri.
Ad
uno
ad
uno
ci
presentammo.
Ad
uno
ad
uno
si
presentarono.
Il
Generale,
capo
assoluto
della
SSA
fazione
Nord,
sedeva
ad
un
tavolo
da
solo,
di
fronte
a
lui,
ossia
ai
lati
della
stanza,
sedevano
tutti
gli
altri,
su
quei
bei
divani
di
legno.
Dalle
camice
a
maniche
corte
spuntavano
da
ognuno
due
braccia
completamente
tatuate,
alcune
muscolose,
altre
rugose
dai
peli
bianchi.
L’interprete
dall’inglese
poverissimo
era
nervoso,
sicuramente
di
parecchi
gradi
inferiori,
doveva
essere
terrorizzato
nel
trovarsi
nella
stessa
stanza
con
tutti
quei
capoccia
messi
insieme.
Anch’io,
che
non
ho
mai
amato
le
gerarchie,
devo
ammettere
di
aver
provato
una
sensazione
simile
alla
sottomissione.
Noi
eravamo
lì
per
farci
raccontare
la
loro
storia,
ma
più
di
ogni
altra
cosa
eravamo
lì
per
dar
loro
la
possibilità
di
lanciare
uno
o
più
messaggi
al
mondo
che
ci
appartiene
e
che
loro
vedono
così
lontano,
sognandolo
salvatore:
l’Occidente.
Io
volevo
renderglielo
chiaro.
Volevo
che
si
aprissero
come
uomini,
come
soldati,
come
generali,
come
capi
e
come
membri
di
un’etnia
sottomessa.
Ho
chiesto
loro
di
parlare
alla
telecamera
immaginando
si
rivolgersi
al
presidente
Bush
(sempre
perché
visto
come
potenziale
aiuto),
al
Segrtario
Generale
delle
Nazioni
Unite,
Ban
Ki
Moon,
chiesi
loro
persino
di
immaginarsi,
al
posto
dell’occhio
di
vetro
della
nostra
Canon,
Than
Shwe,
il
leader
del
regime
che
li
tiene
schiacciati.
Loro
lo
fecero.
L’interprete
dall’inglese
poverissimo
tradusse.
Le
storie
non
cambiano,
cambia
solo
chi
le
racconta.
Per
la
prima
volta
le
sentivo
da
parte
di
uomini
adulti
in
uniforme,
con
tanto
di
gradi
e
importanza
a
luccicargli
negl’occhi.
Stupri,
torture,
prepotenze,
sottomissioni,
dolore
e
sofferenza.
Ci
dissero
che
nonostante
la
tenacia
stanno
perdendo,
giorno
dopo
giorno,
la
lotta
contro
i
loro
oppressori.
Non
hanno
fondi,
i
confini
geografici
se
li
vedono
stringere
sempre
più
a
torno.
Le
malattie,
la
fame,
la
povertà.
Al
termine
dell’incontro,
prima
di
risalire
su
quella
jeep
che
censurava
la
vista
dal
finestrino,
tra
i
saluti
calorosi,
gli
scambi
di
indirizzi
e
gli
inviti
a
tornare
a
trovarli
in
qualsiasi
altro
momento,
sentii
pronunciare,
da
uno
dei
generali
più
anziani,
una
richiesta
che
mi
congelò
sull’istante.
Si
rivolse
a
Jennifer,
l’unica
donna
del
gruppo,
e
sussurrandole
nell’orecchio
le
chiese
sottovoce:
“signorina
la
prego,
ci
faccia
arrivare
delle
armi!”

|
|
|
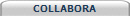
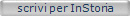
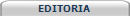
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
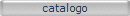
.
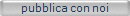
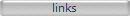
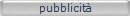
InStoria.it




|