|
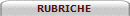

.

.

.

.
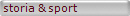
.
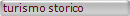
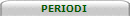
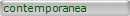
.

.
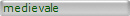
.


.
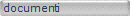
.
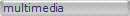
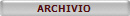


|
N. 24 - Dicembre 2009
(LV)
ASIA, BUDDHA E un reporter senza lavoro
PARTE VIII – STORIE DI BAMBINI CAMBOGIANI
di Gianrigo Marletta
Ad
agosto
Jennifer
ed
io
andammo
ad
abitare
a
Phnom
Penh.
La
Cambogia
ci
fece
sentire
a
casa
e
così
decidemmo
di
provare
a
stabilircisi
per
un
po’.
Resistemmo
solo
quattro
mesi.
In
quel
periodo
contattammo
un
canale
televisivo
americano:
Current
Tv,
fondato
dall’ex
vice
presidente
americano
Al
Gore.
Mandammo
loro
dei
progetti
di
brevi
documentari
su
cui
stavamo
lavorando.
Volevamo
raccontare
la
storia
di
alcuni
personaggi
incontrati
nelle
strade
di
Phnom
Penh.
Nello
specifico
quella
di
un
gruppo
di
bambini
“randagi”
che
vivono
e
crescono
a
bordo
dei
suoi
marciapiedi.
Current
Tv
accettò
la
nostra
proposta
e
finalmente
arrivò
il
primo
giorno
di
riprese.
Finalmente
il
primo
ingaggio:
un
mini
documentario
sui
bambini
di
strada
costretti
a
vendere
libri
che
trasportano
in
pesantissime
ceste
legate
sulle
spalle
e
che
alle
volte,
per
pochi
dollari
in
più,
oltre
ai
volumi
si
vedono
costretti
a
vendere
anche
i
loro
corpicini
a
qualche
turista
voglioso
(anche
se,
e
bisogna
ricordarlo,
i
più
grandi
“consumatori”
di
prostituzione
infantile
sono
gli
asiatici
stessi).
Chiamarli
bambini,
se
non
fosse
per
la
piccola
statura
e la
giovanissima
età,
sarebbe
quasi
incorretto.
Autosufficienti
già
dall’età
di
quattro
anni,
questi
piccoli
esseri
umani,
hanno
l’astuzia
e la
furbizia
di
un
ragazzo,
la
violenza
di
un
uomo
e la
saggezza
di
un
vecchio.
Sono
talmente
abili
nel
parlare
da
mettere
in
difficoltà
chi
ha
trent’anni
di
vita
in
più.
Per
noi
oggi
hanno
cantato
e
poi
ci
hanno
raccontato
la
loro
storia.
Orfani,
senza
dimora,
senza
educazione,
senza
passato
e
senza
futuro.
A
metà
degli
anni
settanta,
ossia
nel
periodo
in
cui
il
comunismo
sconfisse
l’America
prendendo
il
sopravvento
sull’intera
penisola
indocinese,
quarantamila
famiglie
cambogiane
furono
accolte
dagli
Stati
Uniti
come
rifugiati
politici
e
profughi
di
guerra.
Emigrarono
principalmente
donne
e
bambini.
Approdate
le
sponde
degli
U.S.A.
però,
ad
accoglierli
non
vi
erano
gli
eleganti
quartieri
dalle
tipiche
villette
a
due
piani,
circondate
da
giardinetti
ritagliati
perfettamente
e
sottratti
ai
bei
viali
di
cemento,
col
canestro
da
basket
e la
piscina
nel
backyard.
Quelle
ville
sono
sempre
state
riservate
a
un’altra
tipologia
di
cittadino.
Le
famiglie
khmer
furono
disposte
invece
nei
quartieri
cosiddetti
“svantaggiati”,
meglio
conosciuti
come
“ghetti”.
Madri
e
pochi
padri,
in
gran
parte
analfabeti,
si
videro
scaraventati
in
un
nuovo
mondo
di
cui
conoscevano
ben
poco.
Dovettero
imparare
a
decifrare,
ma
soprattutto
a
sopravvivere
in
quella
che
era
una
giungla
di
nuovi
impulsi,
di
nuovi
costumi
e
soprattutto
di
nuove
difficoltà.
Credevano
di
aver
abbandonato
da
povertà
lasciando
il
loro
paese,
ma
presto
si
accorsero
che
la
povertà
non
aveva
abbandonato
loro.
Lavoro
ce
n’era
poco,
aiuto
sociale
ancor
di
meno.
Presto
l’unico
conforto
e
senso
di
familiarità
iniziarono
ad
arrivare
da
una
sola
direzione:
la
propria
comunità.
I
cambogiani
segnarono
un
cerchio
e se
lo
strinsero
attorno.
Così
fecero
i
laotiani,
i
vietnamiti
e
tutti
gli
altri
derelitti
sopravvissuti
alle
bombe
sganciate
dal
paese
che
ora,
così
generosamente,
li
ospitava.
In
uno
stesso
quartiere
vivevano
cittadini
di
paesi
diversi
e
ognuno
di
questi
“paesi”
chiuse
le
proprie
frontiere.
I
bambini
pian
piano
crescevano.
Bambini
diventati
americani
ma
nati
altrove.
Bambini
rinchiusi
nei
confini
etnici
di
nazioni
che,
a
migliaia
di
chilometri
oltre
oceano,
praticamente
non
avevano
mai
visto.
Bambini
poveri,
poverissimi
che
presto
divennero
adolescenti
e
poi
adulti.
Le
scuole
da
frequentare
erano
le
peggiori,
l’educazione
nei
“ghetti”
americani,
come
si
sa,
non
è
tra
le
più
prestigiose.
Le
famiglie,
smarrite,
vittime
di
stress
post
traumatici,
arrabbiate
e a
questo
punto
ostili
verso
tutto
e
tutti,
non
furono
dei
veri
e
propri
“modelli”
per
i
loro
figli
e
questi,
in
grandissima
parte,
divennero
negl’anni
a
seguire
il
prodotto
dei
loro
quartieri:
membri
delle
gang.
Droga,
sesso,
armi
e
violenza
formarono
il
quartetto
tipico
e
gli
strumenti
con
cui
ogni
gangster
iniziò
a
dirigere
la
propria
vita.
Ragazzi
sofferenti,
arrabbiati;
appartenenti
ad
etnie
fantasma:
americani
forse,
cambogiani,
laotiani
e
vietnamiti
solo
per
l’onore.
Chi
in
California,
chi
a
Chicago,
chi
a
New
York,
chi
a
Philadelphia,
in
ogni
città
del
paese
il
fenomeno
si
realizzò
nella
stessa
maniera,
come
se
creato
ed
orchestrato
da
un’unica
mano
invisibile,
invariante
da
metropoli
a
metropoli.
Natura
umana?
Istinto
interiore?
Mal
gestione
del
programma
per
l’immigrazione
condotto
dal
governo
statunitense?
Fatto
sta
che
centinaia
di
questi
giovani
nati
sotto
le
bombe,
trasportati
in
braccio
da
madri
disperate,
approdati
in
terre
sconosciute,
divenuti
criminali
di
strada,
finirono
tutti
in
prigione.
Chi
da
omicida,
chi
da
stupratore,
chi
da
spacciatore.
Le
galere
americane,
alla
fine
degli
anni
novanta,
si
riempirono
di
figli
di
profughi.
La
sovrappopolazione
nelle
carceri
è un
problema
crescente
in
America
e
nel
2001
(anno
in
cui
gli
Stati
Uniti,
con
la
scusa
delle
torri
gemelle
perdute,
approfittarono
per
regolare
quei
conti
nazionali
e
internazionali
che
prima
il
pudore
non
gli
avrebbe
mai
permesso)
il
presidente
George
Bush
fece
passare
una
legge
che
ordinava
l’immediata
deportazione
di
ogni
detenuto
nato
fuori
dal
suolo
americano.
Lo
shock
colpì
loro
quando
il
giudice
li
convocò
per
una
seduta
straordinaria,
emettendo
una
sentenza
di
cinque
semplici
parole:
“Ve
ne
tornate
in
Cambogia!”.
Stesso
per
i
laotiani,
per
i
vietnamiti
e
per
tutti
gli
abitanti
dei
paesi
dilaniati
dalle
bombe
sganciate
da
quell’America
che
ora
li
sbatteva
fuori.
La
cosa
passò
in
sordina,
i
media
non
ci
si
dedicarono
granché
e
ora,
a
distanza
di
pochi
anni,
qualche
centinaio
di
loro
vive
nei
quartieri
“svantaggiati”,
o
meglio
conosciuti
come
“ghetti”,
delle
città
in
cui
nacquero.
Un
“aereo
speciale”
li
ha
scaraventati
nella
loro
(ennesima)
nuova
esistenza.
Gran
parte
dei
deportati
non
parla
la
lingua
locale;
molti
di
loro
a
malapena
parlano
l’inglese,
sanno
esprimersi
solo
tramite
lo
slang
di
un
americano
violento.
All’arrivo
nessuno
aveva
una
famiglia
ad
attenderli
all’aeroporto,
semplicemente
perché
nessuno
aveva
una
famiglia
sopravvissuta
ai
risultati
della
guerra.
Privi
di
una
qualunque
forma
di
educazione,
l’unica
attività
con
cui
avevano
familiarità
e
con
cui
si
presentavano
nella
nuova
patria
era:
la
delinquenza.
Incontrai
alcuni
di
questi
ragazzi
a
Phnom
Penh.
Vivono
ora
sparpagliati
per
la
città.
Molti
di
loro
hanno
continuato
lo
stile
di
vita
scelto
per
loro
dal
destino,
in
Asia
e in
America,
e
muoiono
tra
coltellate
e
overdose.
Spacciano,
si
bucano
e si
ammazzano.
Altri
invece
hanno
subito
un
cambiamento
talmente
radicale
da
lasciare
chiunque
di
senza
parole.
Posti
davanti
ad
un
bivio
con
i
due
cartelli
che,
puntando
le
strade
in
opposte
direzioni
indicavano
continuazione
o
svolta
del
corso
di
una
vita
che
li
aveva
trascinati
fin
lì,
essi
optarono
per
la
seconda
ed
imboccarono
il
sentiero
che
li
avrebbe
condotti
nel
punto
in
cui
si
trovano
oggi:
operatori
di
un’organizzazione
umanitaria
da
loro
stessi
ideata,
creata
e
portata
avanti.
Capelloni,
pieni
di
piercing,
vestiti
con
abiti
di
almeno
dieci
taglie
troppo
grandi,
tatuati
ovunque
(anche
in
faccia),
dalla
parlata
da
spaventare
anche
il
più
cattivo
dei
rapper
di
Los
Angeles,
oggi,
mentre
chiacchiero
con
loro,
mi
parlano
di
compassione,
di
educazione,
di
bambini,
di
aiuti,
di
donazioni,
di
O.N.G.,
di
prevenzione
e di
tutti
gli
argomenti
che
occupano
e
preoccupano
chiunque
abbia
scelto
di
offrire
la
propria
esistenza
all’aiuto
verso
il
prossimo.
Hanno
creato
un’organizzazione
che
ripesca
i
bambini
di
strada
dalle
fauci
affamate
di
un
destino
impaziente
che
gravita
continuamente
su
di
loro:
prostituzione,
AIDS,
colla,
eroina.
KK,
il
fondatore
di
un’organizzazione
chiamata
Tiny
Toons,
un
ragazzo
dolce
e
delicato
ma
anche
molto
attento
a
sopprimere
tali
caratteristiche,
fu
scovato
un
pomeriggio
da
alcuni
ragazzini
mentre
praticava
la
break
dance
in
un
parco
vicino
casa.
“Insegnaci
signore,
insegnaci
a
ballare
così!”
in
coro
i
bambini
lo
pregarono.
Un
po’
perplesso
all’inizio,
KK
impartì
qualche
mossa.
I
bambini
entusiasti
ne
vollero
ancora.
Lui
li
accontentò.
KK e
un’altra
decina
di
deportees
oggi
tengono
una
scuola
che
educa
circa
settecento
bambini.
Iniziarono
con
lezioni
di
break
dance,
passando
poi,
negli
anni
successivi,
all’educazione
sessuale
e
all’importanza
dell’astensione
dalla
droga:
riempiendo
loro
il
tempo
con
lezioni
di
lingua
khmer
e
d’inglese.
I
bambini
imparano
a
leggere
e a
scrivere,
a
comportarsi,
a
stare
attenti,
ad
amare
e ad
essere
amati.
Questi
criminali
di
strada,
senza
famiglia,
senza
patria
e
senza
passato,
anticipando
le
intenzioni
che
il
futuro
aveva
in
serbo
per
loro,
decisero
di
dargli
quel
brusco
cambio
di
direzione,
quella
svolta
che
tanto
avrebbe
giovato
alla
vita
altrui,
impegnandosi
fino
in
fondo
a
non
far
sprofondare
altri
nello
stesso
baratro
da
cui
loro
stessi
stavano
ancora
risalendo.
Girammo
un
video
reportage
(il
secondo
per
Current
Tv)
su
KK e
Tiny
Toons.
Raccontammo
la
storia
dei
deportati
khmer/americani.
Vivemmo
a
stretto
contatto
con
loro
per
alcuni
mesi,
di
conseguenza
convivemmo
momenti
anche
con
coloro
che
KK e
gli
altri
stanno
così
stupendamente
cercando
di
salvare:
i
bambini.
Ispirato
da
ciò
che
vissi
quei
giorni
scrissi
una
lettera
contro
l’indifferenza
e
poi
la
inviai
a
tutte
le
mie
conoscenze:
Oggi
un
altro
giorno
dietro
la
telecamera.
Stiamo
lavorando
su
un
progetto
che
vede
protagonisti
dei
ragazzi
cambogiani
andati
in
America
come
bambini
rifugiati
di
guerra
nel
1975
ed
ora,
a
distanza
di
trent’anni,
deportati
in
Cambogia
come
criminali
di
strada.
Questi
ragazzi
nel
prendere
in
mano
la
loro
nuova
vita
hanno
deciso
di
migliorare
anche
quella
di
altri.
Settecento
bambini
oggi
godono
della
loro
attenzione.
Di
un’attenzione
che
li
rende
felici,
li
rende
educati,
meno
affamati
ma
soprattutto
più
amati.
Siamo
andati
nella
scuola
che
i
nostri
amici
deportati
hanno
messo
su
per
questi
piccoli:
una
stanza
con
i
muri
di
legno
e
cartone.
Una
stanza
che
funge
da
classe
solo
quando
non
è
allagata
dai
monsoni
e
riempita
da
tutti
i
detriti
che
esso
porta.
La
scuola
si
trova
in
un
quartiere
dietro
le
quinte.
Phnom
Penh
non
è un
bel
vedere.
Questo
quartiere
è
ancora
peggio.
Si
entra
da
un
cancello
adiacente
alla
stazione.
Dopo
pochi
metri
le
prime
carrozze
sedentarie.
Appoggiati
su
binari
arrugginiti
e
frammentati
questi
vagoni
ora
fanno
da
casa:
vestiti
appesi
a
lunghe
corde,
spazzatura
e
puzza
di
escremento,
uscendo
dai
grandi
portelloni
di
quelli
che
erano
treni
merci,
confermano.
Tra
un
binario
e
l’altro
un’infinità
di
baracche
con
il
loro
accompagnamento
di
spazzatura
e
puzza.
Fin
dove
l’occhio
si
perde,
putridume
e
catapecchie.
Niente
di
che
per
chi
vive
qui.
La
Cambogia
è
fatta
di
puzza
e
catapecchie.
Ci
si
fa
presto
l’abitudine.
Il
perché
di
questo
che
vi
sto
scrivendo
è un
altro.
Diverse
ore
ho
trascorso
in
quella
scuola.
Ho
fatto
le
mie
riprese
ed
ho
fatto
sparire,
grazie
ai
giochi
di
prestigio,
il
fazzoletto
rosso
che
tengo
sempre
in
tasca.
Una
bambina
di
sei
ed
un
bambino
di
cinque
anni
si
sono
particolarmente
affezionati.
Non
mi
lasciavano
stare
un
minuto.
Il
piccolo
si
arrampicava
su
di
me
come
fossi
stato
un
albero.
Lei
voleva
solo
stare
in
braccio.
Che
carina,
mentre
sudavo
(e
Dio
quanto
ho
sudato!)
lei
mi
soffiava
addosso
per
rinfrescarmi.
Fratello
e
sorella,
orfani,
malati
di
AIDS.
I
genitori
sono
morti
di
AIDS.
I
genitori
come
la
stragran
maggioranza
degli
abitanti
di
questo
quartiere
erano
“sex
workers”,
lavoratori
del
sesso.
Anche
loro,
i
piccoli,
presto
se
non
già,
lo
saranno:
distruggendo
la
loro
piccola
e
graziosa
personalità,
dipingendo
di
nero
la
loro
piccola
e
misera
vita
e
spargendo
senza
fine
questa
dannata
malattia.
Quella
piccola
creatura
che
oggi
mi è
stata
attorcigliata
intorno
al
collo
per
ore
ed
ore
presto
sarà
morta.
E
prima
di
morire
sarà
colta
da
dolore
e
sofferenza.
Non
c’è
nulla
da
fare.
Non
ci
sono
soldi
che
pagheranno
per
un’educazione
ed
un’adeguata
sanità
per
tutti
gli
abitanti
del
mondo.
Non
ci
sono
abbastanza
volontari
per
alleviare
le
sofferenze
o
almeno
per
regalare
sufficiente
amore.
Non
c’è
nulla
che
possiamo
fare
per
loro
ma
c’è
molto
che
possiamo
fare
per
noi
stessi.
Con
la
decisione
di
scrivere
articoli
e
creare
filmati
ho
deciso
di
fare
da
tramite.
Di
mediare
tra
questo
mondo
e
quello,
il
nostro,
il
vostro.
È
per
questo
che
mi
son
preso
la
libertà
di
scrivere
a
tutti
voi.
Con
quello
che
c’è
qui
vorrei
far
vedere
alle
persone
quello
che
hanno
lì.
Spesso,
troppo
spesso
siamo
accecati
dai
Nostri
problemi.
Fobie,
paranoie,
incazzature,
gelosie.
Arrivismo,
odio,
rancore,
ingordigia.
Superficialità,
ignoranza,
ambizione
e
mancanza
di
carità.
Tutti
stati
mentali
che
nel
corso
di
una
giornata
almeno
una
volta
si
affacciano.
Crediamo
che
sarà
la
fine
se
non
riusciamo
ad
ottenere
una
certa
cosa
o
ancor
peggio
per
ottenerla
non
guardiamo
in
faccia
a
nessuno.
Non
guardiamo
in
faccia
a
nessuno!
Ci
disperiamo
per
cazzate,
vogliamo
sempre
di
più,
non
siamo
mai
soddisfatti
con
ciò
che
fino
ad
oggi
ci
ha
tenuto
in
vita.
Certo
non
è
questo
sempre
il
caso.
Ma
se
lo
fosse
è
qui
che
voglio
colpire.
Pensiamoci
di
più
prima
di
incazzarci.
Pensiamoci
di
più
prima
di
voler
assolutamente
ottenere.
Pensiamo
di
meno
al
passato
e al
futuro
e
godiamoci
di
più
il
presente.
Perché
volente
o
nolente
è
quello
che
stiamo
vivendo,
il
presente.
Trattiamo
meglio
tutti.
Se
si
ha
tempo
da
perdere
non
regaliamolo
alla
noia.
Diamone
a
chi
ne
potrebbe
gioire.
I
bambini,
i
malati
ed i
vecchi
più
delle
medicine
hanno
bisogno
di
amore.
E
l’amore
si
da
con
l’attenzione.
Basta
dare
un
minimo
di
attenzione,
cosa
facilissima,
e
qualcuno
gioisce.
Ti
rendi
conto?
Facilissimo!
Noi
possiamo
molto,
basta
farlo.
Chi
visita
un
paese
non
dovrebbe
limitarsi
ai
costumi
ed
ai
sapori
locali.
Non
dovrebbe
visitare
solo
i
musei
e le
attrazioni
tipiche.
Chi
visita
un
paese,
specie
del
Terzo
Mondo,
deve
trovare
quel
qualcosa
che
gli
cambia
la
vita
e
che
magari
aiuti
a
cambiarla
a
qualcun’altro.
E
quando
torna
deve
spartirlo
con
gli
amici
in
modo
che
anche
loro
possano
sentirsene
ispirati.
Quella
bambina
con
suo
fratello
oggi
mi
hanno
cambiato
la
vita.
Mi
hanno
ispirato.
Ora
sono
io a
voler
ispirare
voi.
Ieri
finalmente,
dopo
un
lunghissimo
tragitto
in
un
pullman
notturno
da
Bangkok,
ho
attraversato
il
confine
con
il
Laos.
Le
pratiche
per
il
visto
sono
avvenute
in
una
remota
frontiera
proprio
mentre
il
sole
sorgeva.
Lo
spettacolo
fu
immenso.
La
bandiera
di
questo
paese,
simile
a
quella
del
Giappone,
composta
però
da
tre
colori,
rappresenta
perfettamente
ciò
che
ieri
mattina
ho
vissuto.
Al
centro
un
cerchio,
il
sole,
in
un
campo
blu,
il
cielo,
in
un
riquadro
rosso,
l’alba.
Questo
viaggio,
che
non
vorrei
mai
terminasse,
mi
sta
regalando
tantissimo.
Come
in
ogni
altro
viaggio
vivo
la
libertà.
Vedere
le
stelle
la
sera
è
più
bello,
non
ci
sono
pensieri
né
preoccupazioni
che
offuscano
il
piacere
di
osservare.
La
luna,
quando
piena,
è di
grande
aiuto
perché
illumina
le
strade
e i
sentieri
spesso
bui,
e mi
fa
rendere
conto
che
un
altro
mese
è
passato.
La
libertà
è
assoluta.
Il
muoversi,
lo
spostarsi
caccia
via
le
noie,
le
abitudini.
Regala
nuove
emozioni.
Guardare
fuori
dal
finestrone
dei
pullman
o
dei
treni
mentre
questi
lasciano
il
conosciuto
per
l’ignoto,
vedere
i
paesaggi
che
cambiano,
i
visi
che
mutano,
è
una
sensazione
difficile
da
descrivere.
Le
differenti
frontiere,
lingue,
monete
e
abitudini
di
volta
in
volta
mi
regalano
enormi
emozioni
ed
io
ne
resto
ogni
volta
esterrefatto.
In
un’atmosfera
fatta
di
preistoria
mista
a
recente
attività
bellica,
la
valle
delle
giare
conduce
gli
animi
a
rifugiarsi
dietro
la
sua
bellezza
ed a
rintanarsi
nella
suggestiva
meraviglia
delle
sue
pianure.
La
stagione
secca
è
ormai
agli
sgoccioli
e la
vegetazione
insieme
alla
popolazione
sembra
sopportare
a
stento
tanta
mancanza
d’acqua.
Il
Laos
con
le
sue
palafitte
di
legno,
i
bambini
giocosi
e
sorridenti
e le
strade
raramente
asfaltate
si
presenta
caldo
nel
clima
ma
anche
nell’anima.
La
fierezza
e
gentilezza
della
gente,
che
sembra
appena
in
questi
anni
uscir
fuori
dalle
pene
che
hanno
messo
il
loro
paese
nel
primato
tra
quelli
più
bombardati
del
pianeta,
accoglie
i
visitatori
con
un
gesto
delicato
di
benvenuto
rendendo
la
visita
ad
ogni
viaggiatore
piacevole
ed
indimenticabile.
I
segreti
da
scoprire
risalendo
dalla
capitale
Vientiane
passando
per
Vang
Vieng
e
Luang
Prabang
sono
infiniti,
ma
uno
dei
più
antichi,
unici
e
misteriosi
è
quello
che
si
trova
qui,
a
mille
metri
di
altitudine
e a
soli
quindici
chilometri
dal
centro
di
Phonsavan:
la
piana
delle
giare.
Arrampicandosi
su
un
sentiero
marcato
da
piastrelle
che
ne
indicano
la
sicurezza,
data
dalla
mancanza
di
mine,
si
arriva
in
cima
ad
una
collina
ricoperta
di
erba
secchissima.
Il
panorama
che
si
apre
di
fronte
all’osservatore
è
quasi
surreale.
Vastissime
valli
circondano
l’orizzonte
giallastro
e
arido,
facendo
da
sfondo
ad
uno
spettacolo
di
strani
vasi
enormi
di
pietra
che
spuntano
quasi
intatti
dal
terreno,
appoggiati
spesso
l’uno
all’altro.
Delle
grandi
fosse
dapprima
danno
l’impressione
di
esser
state
scavate
dall’uomo
per
ricavarne
la
terra,
ma
poi,
notandole
tutte
in
fila
ad
intervalli
regolari,
si
capisce
che
sono
crateri
creati
dalle
bombe
dei
B-52
che
hanno
così
pesantemente
bombardato
quest’area
nel
corso
della
guerra
americana
contro
il
Vietnam.
Dei
cartelli,
infilati
al
centro
di
questi
buchi,
confermano.
Il
mistero
delle
giare
dunque
viene
avvolto
da
una
macabra
atmosfera
fatta
di
reperti,
bombe,
mine
e
guerra.
Una
delle
teorie
ora
più
avanzata
è
quella
che
questi
vasi
giganteschi
alti
fino
a
tre
metri,
risalenti
a
circa
duemila
anni
fa,
funzionassero
da
sarcofagi.
A
reggere
quest’
idea
che
prevale
sulle
altre,
che
li
sostengono
contenitori
per
la
fermentazione
del
vino
o
per
la
conservazione
del
riso,
sono
dei
resti
di
ossa
umane
trovati
all’
interno
di
alcuni
vasi
durante
il
corso
delle
ricerche
che
avvennero
da
parte
dell’
illustre
archeologa
francese
Madeleine
Colani
negli
anni
‘30.
In
parte
distrutte
dal
tempo,
in
parte
dalle
bombe,
il
segreto
di
queste
giare
sta
diventando
sempre
più
misterioso.
Un
progetto
iniziato
nel
1998
da
una
collaborazione
tra
UNESCO
ed
il
governo
laotiano,
si
trova
nel
pieno
dell’attuazione
della
seconda
fase
delle
tre
prefissate.
La
prima
fu
quella
di
creare
una
mappa
satellitare
(G.I.S.)
dell’intera
zona
archeologica
con
lo
scopo
di
segnalare
tutti
questi
UXO
(unexploaded
ordines,
ordigni
inesplosi)
presenti
nell’area
ed
allo
stesso
tempo
permettere
la
realizzazione
della
fase
due,
cioè
di
creare
un
inventario
di
tutti
i
reperti
archeologici.
La
terza
fase,
quella
più
delicata
e
decisiva
sarà
quella
della
completa
rimozione
degli
UXO.
La
speranza
a
seguire
è
quella
di
far
diventare
questa
valle
un’area
turistica
sicura
ed
accogliente,
con
l’importante
e
primario
compito
per
lo
sviluppo
economico
di
questo
paese
stravolto
da
una
povertà
estrema.
In
una
calda
e
rilassata
atmosfera
la
piana
delle
giare
nel
suo
vasto
e
silenzioso
spazio
trasmette
la
sensazione
di
essere
popolata
da
innumerevoli
spiriti:
quelli
antichi
morti
in
pace
e
sepolti
con
rito
nelle
giare
e
quelli
moderni
trucidati
dalle
bombe
pioventi
dal
cielo.
Basta
sapere
che
non
lontano
da
qui
un
siluro
americano
centrò
una
caverna
dove
si
nascondevano
quattrocento
persone
che
bruciarono
vive
e
quella
sensazione
diventa
ancor
più
viva
dando
spesso
l’impressione
di
udire
ancora
nel
vento
le
urla
di
tanta
innocenza.
L’immaginazione
di
chiunque,
in
queste
aride
pianure,
può
avere
infiniti
spunti
e
persino
dare
un
suo
contributo
al
grande
mistero
che
avvolge
questi
vasi
giganti
provando
ad
azzardare
qualche
risposta
alle
moltissime
domande
ancora
irrisolte:
chi
li
ha
costruiti?
Quando
precisamente?
Come
li
hanno
trasportati?
E
soprattutto,
per
quale
scopo?
Alla
stazione
degli
autobus
di
Vientiane
un
orologio
fermo
da
chissà
quanto,
fisso
su
un
palo
alla
mia
destra,
segna
le
sei
e
dieci.
In
realtà
sono
le
tre
e
venti
del
pomeriggio.
Le
panche
scomode
di
legno
fanno
d’appoggio
per
me e
per
i
tanti
laotiani
che
pazienti
e
sudati
attendono
l’ora
della
loro
partenza.
La
mia
è
tra
quaranta
minuti,
alle
quattro.
Il
gran
caldo
dettato
da
un’atmosfera
priva
di
vento
si
appiccica
sul
corpo
umidiccio
rendendolo
un
paradiso
per
mosche
e
zanzare.
Direzione
Udonthani,
per
poi
cambiare
e
alle
sette
di
stasera
prendere
un
autobus
per
Chang
Mai.
Quel
viaggio
durerà
almeno
nove
ore.
La
Dengue
ha
condizionato
l’intera
durata
della
mia
visita
in
Laos
e
alla
fine
mi
sta
costringendo
a
tornare
nella
moderna
Tailandia
per
fare
i
vari
controlli
del
sangue
necessari.
È
buffo
come
le
sensazioni
febbricitanti
di
morte,
inflitte
da
questo
virus
della
zanzara
tigre,
ora
mi
appaiano
come
semplice
ricordo.
Rimembro
di
aver
invocato
Dio
diverse
volte,
chiedendogli
aiuto.
È
poi
bastato
andare
all’ospedale
(una
baracca
sporca
e
putrida),
spendere
otto
dollari
e
ingerire
delle
anonime
pillole
verdi,
tre
volte
al
giorno
per
tre
giorni,
per
far
cessare
quelle
sensazioni
orribili.
E
perché
migliaia
di
persone,
specie
vecchi
e
bambini,
ogni
anno
muoiono
di
Dengue
nei
paesi
del
Terzo
Mondo?
Perché
quelle
migliaia
di
persone,
otto
dollari
da
spendere
all’ospedale,
proprio
non
li
hanno.
Dei
bambini
continuano
ad
abbordarmi.
Chi
cerca
di
vendere
gomme
da
masticare,
chi
sacchetti
di
plastica
pieni
di
un
liquido
con
ghiaccio,
evidentemente
da
bere,
color
piscio.
Delle
donne,
nella
fila
di
panchine
di
fronte
a
me,
si
stanno
truccando,
chissà
per
chi.
Un
ragazzo
dietro
di
me
mi
fissa
ormai
da
più
di
un’ora.
Trovo
divertente
come
qui
in
Asia
le
persone
si
incantino
ad
osservare
senza
interruzione
e
per
tempi
lunghissimi
chi
da
loro
è
diverso.
Questo
ragazzo
non
ha
la
minima
idea
dell’imbarazzo
che
crea
in
colui
che
viene
fissato.
Lui
è
semplicemente
curioso
e
nessuno,
da
piccolo,
gli
ha
mai
insegnato
che
fissare
non
sta
bene.
Il
caldo
è
insopportabile.
La
stagione
secca
è
agli
sgoccioli.
Il
Mekong
quasi
scomparso.
Tutto
è
arido
e
secco.
La
vegetazione
morta
e la
popolazione
spossata.
Il
cielo
è
perennemente,
da
Vientiane
a
Luang
Prabang,
coperto
da
una
nube
bianca,
secca
e
sabbiosa.
Un
misto
di
fumo
dato
dagli
incendi
e di
polvere
alzata
dalle
auto.
Vientiane,
la
capitale
del
Laos,
è
poco
più
grande
di
un
tipico
villaggio
indocinese,
carina,
con
molti
templi,
ma
senza
particolari
attrattive
e
divertimenti.
Vang
Vieng
è
invece
un
paesino
costruito
per
i
turisti
“zaino
in
spalla”.
Sorge
per
cinquecento
metri
lungo
la
strada
che
collega
la
capitale
con
Luang
Prabang.
Qui
i
viaggiatori
vengono
condotti
ad
intraprendere
le
attività
appositamente
prefissate
per
loro.
La
principale
è la
droga.
Marijuana,
oppio
e
funghi
allucinogeni
sono
esposti
sui
menù
“speciali”
di
tutti
i
ristoranti
sotto
la
voce
“happy”
e
vengono
offerti
sottoforma
di
tè,
frullato,
ingrediente
sulla
pizza
o
allo
stato
naturale.
Per
poi
svagare
la
mente
“in
viaggio”
gli
stessi
ristoranti
trasmettono
senza
sosta,
ventiquattro
ore
al
giorno,
su
grandi
schermi
piazzati
qua
e
là,
telefilm
e
cartoni
animati
americani.
La
birra
Lao,
fierezza
nazionale,
scorre
a
fiumi
lungo
le
gole
dei
turisti,
ogni
giorno
vengono
stappate
innumerevoli
bottiglioni
e
chiunque
ne
beve
sembra
obbligato
a
decantarne
la
bontà
urlando
a
squarcia
gola
“beer
Lao,
beer
Lao!”
Le
altre
attrattive
sono
il
tubeing,
il
kayaking
e la
visita
alle
svariate
grotte
rocciose
scavate
nei
monti
circostanti.
La
prima
di
queste
sarebbe
quasi
pacifica
e
illuminante
se
non
fosse
per
i
numerosi
bar
rumorosi,
emittenti
di
musica
ad
alto
volume
e
fuori
luogo,
che
s’incontrano
lungo
la
via.
La
parola
tubeing
significa
letteralmente
andare
su
un
tubo,
in
questo
caso
su
una
camera
d’aria.
E
così
è.
Si
scorre
trascinati
dalla
corrente
lungo
un
fiumiciattolo,
affluente
del
Mekong,
con
il
sedere
incastrato
nel
pneumatico
gigante
di
un
camion.
Ormai
esperti
nelle
tendenze
dei
turisti,
i
laotiani
stanno
costruendo
sulle
due
sponde
del
fiume
dei
veri
e
propri
bar
di
legno
che
offrono
birra
Lao,
Lao
Lao
Whiskey
ed
altri
super
alcolici
insieme
a
musica
ed
altalene
da
cui
gli
stranieri
ubriachi
mostrano
tutto
il
loro
coraggio
lanciandosi
giù
nell’acqua
urlando
a
squarciagola.
Il
27
Marzo
sono
tornato
in
Italia
con
un
last
minute
della
Singapore
Airlines.
Il
25 è
morta
mia
Nonna,
il
26
il
mio
Grande
Amico
Marco
Sonnino.
Il
dolore
fu
ed è
ancora
immenso.
Ho
passato
in
Italia
più
di
un
mese
ormai.
Il 4
Maggio
però
salirò
su
quello
stesso
volo
della
Qatar
Airways
verso
Bangkok
che
ho
già
preso
mesi
fa.
L’indomani
ho
un
volo
per
Rangoon,
in
Birmania.
Ormai
il
caso
è
mio.
I
tragici
eventi
che
occorrono
quotidianamente
in
questo
paese
e
fin
troppo
trascurati
dai
nostri
media,
sono
troppo
forti
per
essere
ignorati.
E le
persone,
soprattutto
quelle
che
intendono
andar
lì a
farsi
la
vacanzetta,
dovrebbero
conoscerli.

|
|
|
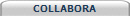
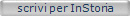
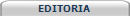
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
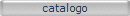
.
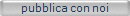
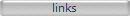
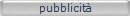
InStoria.it




|