|
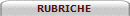

.

.

.

.
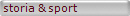
.
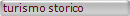
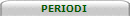
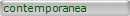
.

.
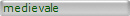
.


.
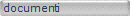
.
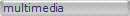
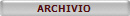


|
N. 22 - Ottobre 2009
(LIII)
aSIA, BUDDHA E UN REPORTER SENZA LAVORO
PARTE VI - Cambogia dolce Cambogia
di Gianrigo Marletta
Mi
stavo
scoraggiando.
Persa
l’ispirazione
avrei
quasi
abbandonato
il
Vietnam
senza
neanche
scriverne
una
parola.
Saigon
o
meglio
Ho
Chi
Minh
city
mi è
parsa
come
una
brutta,
caotica
e
puzzolente
copia
di
New
York,
le
città
costiere
solo
un
ammasso
di
strutture
in
cemento
fatte
per
accogliere
il
maggior
numero
di
turisti
possibile
e
gli
altipiani
centrali
una
deprimente
versione
della
Svizzera.
Un
Vietnam
diverso
da
quello
vissuto
e
raccontato
da
un
Giorgio
Bettinelli:
quella
Saigon
vista
come
meta
finale,
come
punto
di
arrivo,
trofeo
finalmente
conquistato
dopo
24.000
chilometri
percorsi
a
bordo
di
una
Vespa.
Bettinelli
ne
parla
bene,
ne
apprezza
gli
abitanti,
descrivendo
benissimo
quel
fardello
di
dolore
ancora
portato
sulle
spalle,
così
dignitosamente
sopportato
e
anzi
trasformato
in
sorriso
e
cortesia.
Un
sorriso
e
cortesia
verso
lo
straniero
occidentale
venuto
proprio
da
quell’occidente
(prima
francese,
poi
americano)
che
tanta
pena
venne
fin
qui
a
distribuire.
Un
sorriso
e
cortesia
che
sono
sopravvissute
a
due
guerre,
due
invasioni,
migliaia
di
morti,
torture,
napalm,
ma
che
a
malapena
ce
la
fanno
a
perdurare
l’influenza
del
turismo,
questo
turismo
di
massa
che
li
rende
aggressivi,
bramosi
e, a
mio
giudizio,
arroganti.
O
forse
l’espressione
adatta
sarebbe
contro-arroganti,
cioè
quell’atteggiamento
quasi
di
difesa,
tipico
di
ogni
popolazione
troppo
a
stretto
contatto
con
questo
nuovo
fenomeno,
da
un’arroganza
più
gratuita
e da
quel
senso
di
superiorità
tipico
di
molti,
troppi
visitatori.
Allora
Saigon,
e il
Vietnam
in
generale,
venivano
appena
visitati.
“Per
le
strade
di
Saigon
vedevi
circolare
pochi
stranieri,
backpakers
e
“viaggiatori”
più
che
turisti
nel
vero
senso
della
parola,
i
quali
avevano
quasi
tutti,
indistintamente
e
loro
malgrado,
una
comica
sindrome
da
voyeur
a
luccicargli
negli
occhi.
E
ancora
meno
stranieri
vedevi
ad
Hanoi,
la
capitale
del
Vietnam
riunificato
[…].
In
quell’inizio
di
Marzo
1993,
quando
parcheggiavo
la
Vespa
davanti
al
chiosco
di
bibite
il
Vietnam
non
era
ancora
diventato
una
destinazione
turistica
troppo
“alla
moda”;
il
Club
Med
non
vi
aveva
ancora
aperto
un
villaggio
con
animatori
fracassoni,
e le
agenzie
di
viaggi
lo
includevano
timidamente
nei
loro
programmi.”
Così
scrive
Bettinelli
nel
suo
diario
di
bordo
‘in
Vespa’.
Volo
809
della
Pacific
Airlines
da
Hanoi
a
Saigon.
Sono
seduto
vicino
al
finestrino
sul
lato
sinistro
di
questo
antiquato
Boeing
737.
Dall’oblò,
enorme
e
chiara,
risplende
la
luna
da
qualche
giorno
ormai
calante.
Nelle
ultime
ore,
da
quando
il
taxi
collettivo
mi
ha
piantato
all’aeroporto,
mi è
tornata
intorno
tutta
la
modernità
dalla
quale
ero
scappato
e
che
non
vedevo
da
due
mesi.
Persone
pulite
e
benvestite,
businessman
solitari,
vietnamiti
diversi
da
quelli
che
si
vedono
per
strada:
sputacchiosi,
sporchi
e
sempre,
in
un
modo
o
nell’altro,
a
chieder
soldi.
I
pavimenti
risplendenti,
le
file
di
persone
perfettamente
ordinate,
cartelloni
scorrevoli
illuminati,
voci
delicate
e
metalliche
che
danno
indicazioni
dagli
altoparlanti
invisibili,
negozietti
puliti
e
costosissimi:
la
tipica
menzogna
dell’aeroporto.
La
luna
è
davvero
bella.
Risplende
tutta
sola
appesa
a
quell’immensa
parete
buia.
Arrivo
a
Saigon
dove
passo
la
notte.
Nella
lenta
fuga
dal
Vietnam
verso
il
ritorno
in
Cambogia
mi
sono
ostinato,
per
l’ultima
volta,
a
fare
il
turista
‘fai
da
te’.
Sfidando
l’imponenza
dei
tour
operator
impacchettati
e
organizzati
che
in
questo
paese
regolano
i
ritmi
e
gli
spostamenti
dei
turisti,
mi
trovo
ora
seduto
nell’ufficietto
caldo,
sporco
e
appiccicoso
della
grande
stazione
degli
autobus
di
Ho
Chi
Minh
City.
Tra
un
quarto
d’ora
partirà
il
mio
pullman
(per
gente
locale)
per
My
Thon,
nel
cuore
del
Delta
del
fiume
Mekong.
Tutto
intorno
a me
è
tipico
Vietnam.
Donne
con
i
cappelli
a
cono
che
spingono
carretti
o
che
tengono
in
bilico
su
una
spalla
un
lungo
bastone
con
due
secchi
penzolanti
dalle
estremità,
uomini
che
urlano,
strillano,
con
aria
sempre
nervosa
ma
pronti
a
rispondere,
a un
sorriso,
con
un
sorriso.
Saigon
oggi
è un
torpore.
Ci
saranno
trentacinque
gradi
e i
due
ventilatori
attaccati
al
muro
di
questo
piccolo
ufficio
non
fanno
altro
che
muovere
aria
calda.
Il
sole
però
è
splendente
e
questo
rende
tutto
più
allegro.
È
iniziato
tutto
alle
sei
del
mattino
quando,
nella
stanza
208
della
Six
Guest
House
mentre
impacchettavo
le
ultime
cose
da
mettere
nello
zaino,
mi
sono
accorto
di
aver
dimenticato,
appoggiato
sulla
mensola
della
stanza
numero
5
della
Hein
Guest
House,
nella
cittadina
che
ho
lasciato
ieri
a
tre
ore
di
autobus,
il
mio
lettore
MP3.
Questo
marchingegno
oltre
a
essere
molto
costoso,
contiene
tutte
le
fotografie
scattate
durante
il
viaggio
che
man
mano
salvavo
nella
sua
memoria.
Alle
sette
partiva
il
mio
traghetto
per
la
Cambogia,
il
mio
visto
stava
scadendo
e io
avevo
appena
iniziato
ad
inveire
prendendo
a
pugni
ogni
cosa
mi
capitasse
sottomano.
Dopo
una
serie
di
telefonate
la
fortuna
e la
gentilezza
della
proprietaria
della
Hein
Guest
House
hanno
fatto
sì
che,
alle
tre
del
pomeriggio,
il
mio
MP3
sarebbe
arrivato
a me
tramite
l’autista
della
corriera.
Il
traghetto
era
partito,
il
prossimo
sarebbe
stato
alle
sette
dell’indomani
mattina
e
io,
una
volta
riottenuto
il
mio
marchingegno,
dovevo
assolutamente
attraversare
quel
confine:
quello
stesso
giorno.
Alle
tre
e
mezza
cominciai
a
fare
l’autostop.
La
frontiera
distava
non
so
quanti
chilometri.
Finalmente
un
ragazzo,
proprietario
di
un
motorino,
mi
raccatta
dal
ciglio
della
strada
offrendomi,
in
cambio
di
una
fregatura,
di
trasportare
me e
i
miei
due
bagagli
fino
a
dove
il
Vietnam
terminava.
Di
nuovo
il
confine.
Di
nuovo
il
paesaggio
che
lentamente
cambia.
Sporchi
alla
stessa
maniera
i
due
paesi
indossano
vesti
molto
diverse.
Il
Vietnam,
finto
fighettino,
cerca
di
atteggiarsi
mostrando
tutto
il
cemento
di
cui
le
case
son
fatte,
le
immense
ricche
risaie
verdissime,
in
realtà
farcite
di
rifiuti
e
buste
di
plastica
e i
suoi,
particolarità
di
questo
paese,
internet
caffè
in
cui
centinaia
di
giovani
e
giovanissimi
passano
tutto
il
giorno
a
rincoglionirsi
davanti
a un
videogame,
lo
stesso
per
tutti,
di
un
omino
che
balla
regalando
punti.
Seduto
in
sella
al
motorino
dietro
al
mio
‘moto
driver’,
felice
di
lasciare
un
paese
vissuto
come
arrogante
e
maleducato,
finto
ricco
e
turisticamente
impacchettato,
osservo
con
gioia
il
paesaggio
cambiare.
Pian
piano
la
strada
da
asfalto
torna
a
essere
d’argilla,
le
case
diventano
palafitte,
il
cemento
si
trasforma
in
legno.
Attraversiamo
un
ponte
di
corde
e
legno
marcio.
L’idea
del
peso
del
motorino
sommato
al
mio,
a
quello
del
guidatore
e a
quello
dei
miei
due
bagagli
non
mi
fece
stare
affatto
tranquillo.
Lo
attraversai
interamente
a
occhi
chiusi
e
fortunatamente
dopo
pochi
secondi
fummo
già
dall’altra
parte.
Presto
si
presentò
un
altro
fiume
da
attraversare
ma
stavolta
a
trasportare
i
passanti
vi
era
ad
attendere
un
piccolo,
spartano,
traghetto
di
legno.
La
traversata
durò
dai
quaranta
ai
cinquanta
secondi.
Pochi
chilometri
più
avanti
lungo
la
strada
che
ormai
riportava
in
tutto
e
per
tutto
alla
Cambogia
spuntò
una
capannina
di
legno.
“Ecco
il
confine”
- mi
congedò
il
‘moto
driver’.
Sapevo
già
che
dopo
averlo
attraversato
avrei
dovuto
dormire
lì
da
qualche
parte,
in
quel
villaggio
di
capanne
e
senza
nome,
sapevo
anche
che
la
barca
per
Phnom
Penh
sarebbe
passata
l’indomani
mattina.
Quello
che
non
sapevo
era
che
in
quel
villaggio
di
capanne,
tutte
disposte
lungo
una
strada
di
argilla
circondata
da
fitta
boscaglia,
non
vi
era
nemmeno
una
guest
house
né
un
piccolo
albergo.
Fu
il
poliziotto
cambogiano
stesso
a
chiedermi,
dopo
avermi
timbrato
il
passaporto:
“e
ora
cosa
fai?
Dove
vai?”
“Ma
come,
sono
io a
dover
fare
questa
domanda
a
lei!”
-
avrei
voluto
rispondergli
e
invece
mi
uscì
-
“non
si
preoccupi,
qualcosa
troverò”.
Col
peso
enorme
di
un
bagaglio
sulle
spalle
e
uno
da
tenere
in
mano
mi
avviai
lungo
la
strada
di
argilla
verso
una
delle
uniche
due
direzioni.
Appena
pochi
passi
dopo
mi
venne
incontro
un
uomo
che,
con
un
ottimo
inglese,
mi
chiese
se
avevo
bisogno
di
un
posto
dove
stare.
“Si!”
- Mi
propose
dunque
una
stanza
a
dieci
dollari.
“Dieci
dollari?!”
-
Decisamente
troppo
considerando
che
in
tutti
i
paesi
che
ho
visitato
negli
ultimi
anni
non
ho
mai
pagato
più
di
cinque.
Sfidando
le
circostanze
rifiutai.
E
quando
mi
avvertì
che
non
vi
sarebbe
stata
altra
accomodazione
per
passare
la
notte,
che
rapidamente
si
avvicinava,
rifiutai
di
nuovo.
Conosco
la
gentilezza
e
l’ospitalità
del
popolo
khmer,
è
unica
e
non
ha
niente
a
che
vedere
con
l’opportunismo
che
ho
trovato
in
Vietnam.
Quell’uomo
non
sarà
certo
khmer,
mi
son
detto
proseguendo
per
la
mia
strada.
Avanzando
un’altra
manciata
di
metri
un
uomo
ubriaco,
dall’aria
simpatica,
mi
sorrise.
Colsi
la
palla
al
balzo
e mi
autoinvitai
nella
sua
palafitta.
“Five
Dolla,
ok?”
-
gli
offrii
cinque
dollari.
Gli
occhi
gli
si
illuminarono
- “Ok!”
Passai
così
la
notte
sulla
tavola
di
legno,
nella
stanza
da
letto
del
figlio
che
era
andato
a
trascorrere
qualche
giorno
nella
capitale.
Seppur
nascosto
sotto
la
zanzariera
le
pulci
mi
mangiarono
vivo.
Non
chiusi
occhio
e mi
grattai
freneticamente
tutta
la
notte.
Il
bagno,
ovviamente
esterno
alla
casa,
mi
sembrava
così
lontano
che
preferivo
tenermi
tutto
dentro;
quella
paura
di
incontrare
cobra
e
scorpioni
lungo
la
strada,
nel
buio
pesto
della
notte
però
aumentava
drammaticamente
il
mio
bisogno
di
fare
pipì.
Il
giorno
dopo
ero
di
nuovo
a
Phnom
Penh.
Il
mio
ritorno
in
Cambogia
avvenne
per
un
motivo
ben
preciso:
volevo
scrivere
un
articolo
che
mi
venisse
pubblicato
in
Italia,
un
reportage
che
servisse
a
qualcosa,
che
pubblicizzasse
un
settore
valido,
che
portasse
attenzione
in
una
direzione
giusta.
Mi
recai
a
Batambang
dove
si
trova
l’ospedale
Ilaria
Alpi
della
ONG
italiana
Emergency.
Il
mio
articolo
venne
pubblicato
per
la
prima
volta
su
una
rivista
italiana:
50&più.

|
|
|
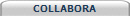
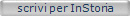
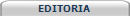
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
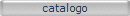
.
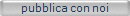
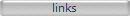
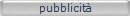
InStoria.it




|