|
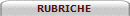

.

.

.

.
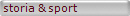
.
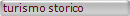
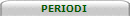
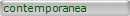
.

.
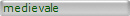
.


.
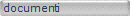
.
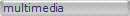
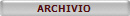


|
N. 3 -
Marzo 2008
(XXXIV)
STORIA DELLA SPAGNA CONTEMPORANEA
Il Caudillo della reazione - Parte V
di Cristiano Zepponi
La
Spagna
della
“crociata”
(per
lungo
tempo
questa
sarebbe
stata
l’immagine
di
Franco
proposta
dal
regime,
a
partire
dalla
tela
di
Arturo
Reque
Meruvia)
esaltò
la
propria
vittoria,
e sé
stessa,
con
una
profusione
di
energie
tale
da
tradire
il
sollievo
per
lo
scampato
pericolo:
il
terrore
di
una
sconfitta
era
stato
troppo
vivo,
per
essere
rimosso
d’improvviso.
Il
19
maggio
del
1939
si
svolse
quindi
un’interminabile
sfilata
militare,
patriottica
e
simbolica,
per
“mostrare
i
muscoli”
del
neonato
regime.
All’inizio
della
cerimonia,
il
gen.
Varala
decorò
il
vincitore
con
la
massima
onorificenza,
la
Gran
cruz
laureada
de
san
Fernando,
mentre
i
velivoli
nel
cielo
rappresentavano
le
parole
‘VIVA
FRANCO’.
La
damnatio
memoriae
della
Repubblica
decollò
subito,
attraverso
la
delegittimazione
dello
sconfitto
ordinamento
democratico
operata
dalla
pubblicistica
di
regime,
per
poi
procedere
a
braccetto
con
l’esaltazione
del
capo
vittorioso.
Il
“generalissimo”,
subito
dopo
l’investitura
dei
suoi
parigrado,
aveva
già
imposto
l’appellativo
di
“Caudillo”,
corrispondente
locale
del
teutonico
Führer
e
dell’
italico
Duce,
ma
forgiato
e
tenuto
a
battesimo
da
un’attenta
campagna
propagandistica
di
culto
della
personalità.
Le
radici
conservatrici
di
questa
scelta
emersero
dall’accostamento
ad
epoche
mitiche
e
personaggi
leggendari
del
passato
spagnolo
(la
Spagna
imperiale
del
XVI
e
XVII
secolo
per
quanto
riguarda
le
prime,
il
“Cid”
tra
i
secondi),
dalla
chiara
connotazione
miliare
del
termine,
e
dall’
immancabile
dimensione
messianico-provvidenziale
che
i
vescovi
spagnoli,
in
un
eccesso
di
zelo,
non
mancarono
di
esaltare.
Il
giorno
dopo
la
sfilata,
a
Madrid,
ebbe
luogo
anche
l’offerta
della
spada
della
vittoria
all’altare
della
chiesa
di
Santa
Barbara,
addobbata
con
evidenti
richiami
a
passati
momenti
di
splendore
(i
lontani
echi
di
Lepanto,
la
vittoria
navale
cristiana
del
1571,
e
della
Riconquista)
e
con
la
vasta
panoplia
di
membri
del
governo,
falangisti,
ambasciatori
e
uomini
di
chiesa
che
lì
resero
l’estrema
unzione
allo
Stato
laico
sconfitto.
Pio
XII
(che
negli
ultimi
anni
sembra
assurgere
a
modello
di
virtù
morale..)
diede
anzi
l’esempio,
se
così
si
può
dire,
incoraggiando
la
collaborazione
con
uno
Capo
di
Stato
vittorioso
sì,
ma
pur
sempre
illegale.
L’Azione
cattolica
si
propose
quindi
come
“officina
ideologica”
alternativa
alla
Falange,
ed
il
franchismo
vi
attinse
a
piene
mani;
in
più,
la
giustificazione
del
potere
arrivò
addirittura
a
scatenare
una
lotta
personale,
tra
i
vari
membri
del
clero,
sulla
primogenitura
dell’appoggio
al
Caudillo.
Senza
dubbio
la
spuntò
l’arcivescovo
di
Toledo
Pla
y
Deniel,
che
nel
maggio
del
’42,
al
momento
dell’intronizzazione,
elogiò
“questo
governo
che
ha
riconosciuto
nelle
sue
leggi
la
chiesa
come
una
società
perfetta,
che
ha
ristabilito
la
nostra
unità
cattolica
proclamata
dal
re
Recaredo”.
L’alleanza
trono-altare
divenne
così
un
tratto
fondamentale
del
nuovo
ordinamento,
nonostante
sotterranei
scontri,
soprattutto
con
la
Falange,
su
singoli
settori
della
società
(l’integrazione
forzata
delle
associazioni
studentesche
cattoliche
nei
circuiti
del
partito
unico,
la
predica
in
dialetto
basco
e
catalano,
l’informazione).
Gli
organici
legami
con
la
chiesa
trovarono
alfine
conferma
nel
“giuramento
di
fedeltà
allo
Stato
spagnolo”
pronunciato
di
fronte
a
Franco,
ripristinando
un’usanza
secolare,
dai
nuovi
vescovi
in
conseguenza
degli
accordi
con
la
S.ta
Sede
del
giugno
’41.
La
ricattolicizzazione
simboleggiata
dall’evocazione
del
triplice
motto
“ordine,
patria,
religione”
nei
discorsi
del
generale,
nei
bollettini
episcopali,
nella
stampa
e
nei
vari
organi
di
regime
procedette
spedita,
ed
euforica,
senza
curarsi
del
destino
di
quella
Spagna
sconfitta,
e
massacrata,
che
in
quegli
anni
scomparve
in
silenzio.
I
settori
più
conservatori
della
società
(proprietari
terrieri,
elìte
finanziaria,
chiesa,
esercito
ma
anche
contadini
e
piccolo-borghesi)
assistettero,
compiaciuti
e
distaccati,
all’epurazione
dei
“rossi”.
La
chiesa
colse
al
volo
l’occasione
di
apostolato,
e,
semplicemente,
venne
meno
ai
precetti
evangelici:
nel
gennaio
del
’41
la
rivista
dell’Azione
cattolica
(“Ecclesia”)
pubblicò
le
parole
del
direttore
generale
delle
carceri,
il
quale
assicurò
che
nessuno
“sconto
di
pena
sarà
accordato
a
chi
non
avrà
accolto
i
principi
elementari
della
nostra
religione”,
né
più
umano
si
dimostrò
l’atteggiamento
dei
200
cappellani
dell’amministrazione
penitenziaria,
impegnati
in
un
massiccio
ciclo
di
conversioni,
messe,
catechismi
e Te
deum
forzati.
La
retroattività
delle
leggi,
ed
un
principio
di
“justicia
al
revès”
(per
usare
le
parole
di
Serrano
Suňer
nelle
memorie
del
1977)
permisero
l’incarcerazione
e lo
sterminio
di
socialisti,
anarchici,
comunisti,
repubblicani,
deputati
e
sindacalisti,
specie
dopo
la
promulgazione
(il
1°
marzo
del
’40)
della
legge
sulla
repressione
della
massoneria
e
del
comunismo
. La
popolazione
carceraria
decollò
dai
12.500
detenuti
pre-bellici
ai
270.000
del
’40,
mentre
i
fucilati,
a
metà
del
’39,
come
riferì
Franco
al
conte
Ciano
(“Diario
1939-1943”,
vol.
I),
assommavano
a
200-250
a
Madrid,
150
a
Barcellona,
80 a
Siviglia.
Al
giorno.
Le
stime
non
tengono
conto
dei
decessi
per
maltrattamenti,
malattie
ed
omicidi
sommari.
Al
contrario
di
quelli
dell’antichità
classica,
i
numeri
vanno
presi
per
difetto:
alcuni
propongono
una
valutazione
di
circa
192.000
morti
tra
il
1°
aprile
del
’39
ed
il
30
giugno
del
’44
(S.G.
Payne,
“Franco’s
Spain”,
1967,
p.
111).
A
questi,
vanno
sommati
anche
quelli
causati
dai
volenterosi
carnefici
alleati,
la
Germania
nazista
e la
Francia
sconfitta
di
Vichy
(responsabile
diretta
dell’uccisione
di
Lluis
Companys,
ex
presidente
della
Generalidad
di
Catalogna).
La
Spagna
perse
allora
i
suoi
settori
più
dinamici,
emigrati
e
trucidati,
oppure
epurati
pazientemente
dall’amministrazione
pubblica,
dalle
imprese,
dalla
vita
comune.
Restarono
ai
loro
posti
160
professori
universitari
sui
430
presenti
nel
’36
(Hermet,
“Storia
della
Spagna
nel
Novecento”,
pag.
168),
ed
una
simile
proporzione
di
operai.
Le
fameliche
orde
di
fascisti
dell’
ultimo
minuto,
di
cantori
della
pecunia,
di
arrivisti
sfegatati,
si
scatenarono
allegramente.
La
Falange
passò
dai
36.000
membri
del
’36
ai
932.000
del
’42,
e
popolò
così,
dotandoli
di
patenti
politiche
incontrovertibili,
i
settori
lasciati
desolati
dal
repulisti
post-bellico.
Il
“nuovo
Stato”
a
carattere
confessionale
si
caratterizzò
subito
per
una
precisa
scelta
antimodernizzatrice,
visibile
soprattutto
nell’istruzione.
L’Università
divenne
cattolica,
mentre
la
partecipazione
ai
concorsi
in
facoltà
fu
subordinata
alla
presentazione
di
un
certificato
di
ferma
adesione
ai
principi
fondamentali
dallo
Stato,
rilasciato
dalla
Segreteria
generale
del
Movimento.
I
giovani
furono
inquadrati
in
apposite
organizzazioni
– il
“Fronte
della
gioventù”
e la
“Sezione
femminile”
della
Falange
–
gerarchiche,
patriottiche,
cattoliche
e
conformiste.
Le
donne
dovettero
anche
frequentare
il
Servizio
Sociale,
creato
durante
la
guerra
e
riorganizzato
nel
’40,
un
corso
obbligatorio
semestrale
atto
a
rilasciare
un
altro
certificato
necessario
per
ottenere
un
posto
nell’amministrazione
pubblica,
la
patente,
e
poi
diploma
e
passaporto.
Il
Servizio
Sociale,
sottomesso
alla
“Sezione
femminile”
(presieduta
a
vita
da
Pilar
Primo
de
Rivera,
sorella
di
Josè
Antonio),
promosse
un
modello
femminile
tradizionalista,
fondato
sull’assunto
che
“il
fine
essenziale
della
donna
[…]
è di
servire
da
perfetto
completamento
dell’uomo”,
e
via
delirando.
“Repressione,
inquadramento
sociale
ed
una
rigida
censura
connotano
il
lungo
dopoguerra
spagnolo”
(Di
Febo-Julià,
“Il
franchismo”,
pag.
21).
La
censura
in
particolare
era
“dogmatica,
xenofoba
e
improntata
alla
pudicizia
in
forma
inverosimile”,
come
candidamente
ammesso
dal
responsabile
del
Servizio
di
Propaganda,
Dionisio
Ridruejo.
L’intellettuale
assurse
a
simbolo
di
disgregazione
dell’unità
nazionale,
e
per
questo
subì
un’intensa
attività
denigratoria;
la
censura
e
l’attacco
diretto
si
scagliarono
ferocemente
contro
la
Instituciòn
Libre
de
Enseňanza
e le
migliaia
di
maestri
eredi
della
sua
pedagogia
laica
e
innovatrice;
e
per
ultimo,
l’isolamento
culturale
del
Paese
divenne
drammatico
con
la
diaspora
di
pensatori
di
caratura
internazionale
(tra
cui
i
poeti
Rafael
Alberti
e
Juan
Ramòn
Jimènez,
gli
storici
Amèrico
Castro
e
Salvador
de
Madariaga,
i
filosofi
Josè
Ortega
y
Gasset
e
Marìa
Zambiano,
i
giuristi
Luis
Jimènez
de
Asùa
e
Claudio
Sànchez
Albornoz
e
gli
scrittori
Ramòn
Sender
e
Merce
Rodoreda),
proprio
mentre
intere
esperienze
intellettuali
scomparvero
sostituite
dalla
reintroduzione
della
neoscolastica.
Franco
riteneva
che
il
liberalismo
costituisse
la
causa
dei
due
mali
principali
degli
ultimi
decenni:
la
democrazia
multipartitica
e la
lotta
di
classe
sindacalista.
Per
questo,
intervenne
subito
sul
tema
del
disciplinamento
della
forza
lavoro:
i
princìpi
di
collaborazione
delle
classi
e di
organizzazione
corporativa
ispirarono
la
compilazione
della
Fuero
del
trabajo
(Carta
del
lavoro),
promulgata
il 9
maggio
1938,
a
guerra
in
corso.
Tutte
le
forze
produttive
furono
irreggimentate
in
sindacati
verticali
diretti
dalla
Falange,
ai
quali
dipendenti
ed
imprenditori
erano
tenuti
ad
iscriversi,
e fu
proibito
lo
sciopero,
“delitto
di
lesa
patria”.
Lo
Stato,
nella
Carta,
veniva
definito
“nazionale
in
quanto
è
strumento
totalitario
al
servizio
dell’integrità
della
patria
e
sindacalista
in
quanto
rappresenta
una
reazione
contro
il
capitalismo
liberale
e il
materialismo
marxista”.
Subito
dopo,
con
varie
misure
giuridiche,
eliminò
ogni
traccia
delle
riforme
laiche
e
liberali
della
Repubblica:
il
23
settembre
del
’39
fu
abolito
il
divorzio,
il
10
marzo
’41
fu
confermato
l’obbligo
di
fatto
del
matrimonio
religioso,
e
poi
fu
reso
obbligatorio
l’insegnamento
religioso
nelle
scuole
pubbliche
e
stabilito
un
sostegno
economico
all’insegnamento
confessionale.
Lo
Stato,
che
fin’allora
era
stato
solo
un
gigantesco
accampamento,
non
acquisì
istituzioni
stabili
per
volere
dello
stesso
Caudillo,
che
sembra
aver
preferito,
almeno
in
questa
fase,
non
assumersi
impegni
nei
confronti
delle
diverse
anime
della
sua
“coalizione”,
nonostante
gli
assidui
tentativi
di
Ramòn
Serrano
Suňer,
l’avvocato
ex-cedista,
ispiratore
ed
eminenza
grigia
del
periodo
pseudo-fascista
del
regime,
noto
come
“cognatissimo”
del
generale.
Senza
scontentare
né i
“duri
e
puri”
della
Falange,
né
le
nostalgie
monarchiche,
il
dittatore
riaffermò
solo
la
propria
giurisdizione
attraverso
la
legge
dell’8
agosto
1939
sulla
Magistratura
suprema
dello
Stato
(Jefatura
del
estado),
e
soprattutto
la
legge
fondamentale
del
17
luglio
1942,
che
rimetteva
in
vigore
le
Cortes,
svuotate
di
ogni
velleità
giurisdizionale.
Ma
nonostante
fosse
scomparsa
ogni
traccia
di
opposizione
interna
(del
tutto
inesistente
fino
al
’44:
ne
risultarono
zero
scioperi,
zero
manifestazioni,
e
l’assordante
silenzio
dei
circoli
anarchici/comunisti
garantito
da
un’onnipotente
corpo
di
polizia
sostenuto
da
esperti
della
Gestapo
tedesca),
il
Regime
dovette
affrontare
da
subito
alcuni
gravi
problemi.
Il
primo
in
ordine
di
tempo
(e
d’importanza)
fu
costituito
da
una
grave
e
generalizzata
carestia,
attribuita
inizialmente
alle
distruzioni
del
conflitto,
alla
mancanza
di
fertilizzanti
e
macchinari,
alla
sferzata
inferta
dai
movimenti
di
collettivizzazione
(repubblicana)
e
decollettivizzazione
(franchista),
ed
allo
stato
disastroso
in
cui
versavano
le
vie
di
comunicazione
(nel
settore
ferroviario
e
petrolifero).
Più
tardi,
invece,
divenne
evidente
come
fosse
stata
deleteria
la
combinazione
di
interventismo
statale
e
protezionismo
autarchico,
pur
senza
sottovalutare
lo
sfondo
di
un’economia
già
depressa;
ne
fu
prova
il
clamoroso
fallimento
dell’Instituto
Nacional
de
Colonizaciòn
(creato
nell’ottobre
del
1939),
e
del
suo
piano
di
colonizzare
le
grandi
aree
(su
oltre
500.000
ettari
dichiarati
di
interesse
nazionale,
ne
furono
sfruttati
solo
10.000).
“La
produzione
agricola
crolla
da
un
numero
indice
109
nel
1935
a 70
nel
1940
e a
75
nel
1942
[…].
Nei
dintorni
di
Madrid
i
contadini
[…]
arrivano
addirittura
a
occupare
le
cappelle
funerarie
dei
cimiteri,
le
uniche
a
offrir
loro
un
asilo”
(Hermet,
op.cit.,
pag.
169),
e da
questa
situazione
uscì
foraggiata
al
solito
una
ridotta
cerchia
di
affaristi
senza
scrupoli
impegnati
nel
redditizio
settore
del
mercato
nero.
La
produzione
di
patate
dimezzò
(da
5.010.000
t
del
periodo
1931-‘35
a
2.715.000
t
negli
anni
1945-‘49),
ed
un
calo
simile
si
registrò
anche
nel
settore
del
grano
(negli
stessi
lassi
di
tempo,
da
4.364.000
t a
3.177.000
t),
dell’orzo
(da
2.394.000
t a
1.819
t) e
dell’olio
(da
349.000
t a
331.000
t).
Il
fascismo
agrario
fallì
inesorabilmente.
Ma
gli
stessi
princìpi
–
interventismo
e
autarchia
–
guidarono
anche
la
politica
industriale,
un
altro
rilevante
problema
per
il
“nuovo
Stato”.
I
danni
della
guerra
erano
stati
in
questo
campo
sensibili,
ma
non
drammatici,
specie
per
quanto
riguarda
gli
impianti
baschi
e
catalani,
consegnati
quasi
intatti
ai
nazionalisti;
tuttavia,
ancora
le
politiche
del
regime,
unite
stavolta
alla
sfavorevole
scelta
strategica
di
avvicinarsi
a
Germania
e
Italia,
determinarono
un
brusco
stop
nel
secolare
processo
di
sviluppo
iberico.
La
libertà
d’impresa
fu
severamente
limitata
a
mezzo
di
decreti
(20
agosto
1938,
8
settembre
1939),
i
piani
di
industrializzazione
furono
vincolati
alla
creazione
dell’INI
(Istituto
Nacional
de
la
Industria)
nel
settembre
del
1941,
che
trasformava
lo
Stato
nel
maggiore
imprenditore
industriale
(specie
nel
campo
delle
forniture
militari),
e i
mono/oligopoli
divennero
la
regola
nel
panorama
economico
spagnolo.
I
salari
reali
diminuirono
di
due
terzi
rispetto
all’anteguerra,
né
si
potevano
difendere
senza
sindacati
e/o
azioni
rivendicative,
e
una
mastodontica
burocrazia
costrinse
gli
imprenditori
ad
un'unica
forma
di
concorrenza,
volta
esclusivamente
a
garantirsi
appoggi
politici,
amministrativi
ed
economici.
Ne
scaturì
una
depressione
profonda,
e
fino
al
’50,
per
alcuni,
l’industria
del
Paese
non
raggiunse
i
livelli
produttivi
del
’30;
allo
stesso
modo,
il
“reddito
pro
capite
raggiunto
nel
1935
non
verrà
del
tutto
recuperato
fino
al
1954”
(Di
Febo-Julià,
op.cit.,
pag.
31).
Poiché
in
politica
interna
prevaleva
la
Falange,
e
falangisti
erano
in
larga
parte
i
membri
dell’esecutivo,
e
poiché
il
loro
aiuto
era
risultato
decisivo
durante
la
guerra
civile,
la
Spagna
privilegiò
l’Italia
e la
Germania
agli
esordi
del
conflitto,
e
con
esse
firmò
trattati
di
amicizia
e
cooperazione,
prima
di
aderire
al
Patto
anti-Comintern
e
ritirarsi
dalla
Società
delle
nazioni.
Tuttavia,
Franco
era
un
uomo
prudente,
e
non
amava
il
cambiamento;
per
questo,
e
per
le
gravi
crisi
interne,
rifiutò
di
seguire
i
consigli
bellicosi
dei
falangisti
stessi,
rinforzati
dal
rimpasto
di
governo
dell’agosto
del
’39.
Il 4
settembre
di
quell’anno,
all’alba
del
conflitto,
il
Paese
dichiarò
quindi
la
neutralità,
per
quanto
benevola
fosse
nei
confronti
dell’Asse.
Tuttavia,
la
marea
montante
dei
successi
tedeschi,
della
presa
spagnola
di
Tangeri
(approfittando
della
resa
francese,
il
12
giugno
1940),
e
del
conseguente,
accresciuto
ruolo
internazionale
del
Paese
scossero
il
Caudillo,
che
solo
a
causa
di
un
estremo
scrupolo
di
prudenza
optò
per
la
littoria
via
della
“non
belligeranza”
di
mussoliniana
memoria.
Franco
intendeva
quel
passo
come
un
avvicinamento
alla
guerra:
tuttavia,
decise
di
vendere
cara
un’eventuale
discesa
in
campo.
Come
riferito
da
Vigòn,
capo
dell’Alto
Stato
Maggiore,
ad
un
indifferente
Hitler,
pretendeva
nientemeno
che
Gibilterra,
il
Marocco
francese,
la
regione
di
Orano,
viveri
e
rifornimenti.
La
Germania,
come
ovvio,
rifiutò.
Il
problema
si
ripresentò
nel
corso
degli
incontri
con
il
Führer
di
Franco
a
Hendaye
(il
23
ottobre)
e di
Serrano
a
Berchtesgaden
(il
18
novembre),
ma
rimase
senza
soluzione:
i
tedeschi
sembravano
preoccuparsi
più
dell’amicizia
di
Vichy
che
della
smania
combattiva
del
disastrato
esercito
spagnolo.
Serrano
tentò
allora
la
carta
dei
volontari,
e
radunò
una
divisione
(“Azul”,
“azzurra”)
da
spedire
sul
fronte
russo,
per
poi
affrettarsi
a
chiarire
che
la
Spagna
non
aveva
intenzione
di
partecipare
al
conflitto
contro
la
G.B.
L’entrata
in
guerra
degli
U.S.A.
e le
prime
sconfitte
dell’Asse
modificarono
radicalmente
i
piani
del
Caudillo.
Dapprima
timidi
approcci
commerciali,
poi
accomodamenti
riguardo
i
rifornimenti
ai
sommergibili
tedeschi
ed i
piloti
alleati
abbattuti,
infine
passi
ufficiali
dei
governi
salvarono
il
regime
dall’isolamento,
e
Franco
da
un
dopoguerra
che
si
annunciava
piuttosto
complesso.
L’iniziale
intransigenza
degli
alleati
si
piegò
quindi
alle
necessità
della
guerra,
che
imponeva
di
attrarre
un
Paese
posto
in
posizione
strategica
nei
pressi
del
fondamentale
scacchiere
africano.
Il 4
dicembre
del
1942,
di
conseguenza,
Anthony
Eden
firmò
una
cambiale
in
bianco,
affermando
che
il
suo
Paese,
l’Inghilterra
di
Churchill,
non
aveva
alcuna
intenzione
di
intervenire
negli
affari
interni
della
Spagna.
Anche
se
questa
rimaneva
la
Spagna
di
Franco.
Il
Caudillo
decise
che
il
suo
debito
di
riconoscenza
verso
l’Asse
era
ormai
estinto,
e
capì
che
solo
una
prova
di
buona
volontà
poteva
relegare
nell’ombra
le
passate
simpatie
per
lo
schieramento
“sbagliato”.
Raccolse
perciò
l’invito,
con
la
consueta
cautela:
il
1°
ottobre
1943,
tre
settimane
dopo
il
crollo
dell’Italia,
abbandonò
la
non
belligeranza
e
tornò
ad
una
condizione
di
neutralità
sempre
più
favorevole
agli
alleati.
Il 3
novembre
fu
rimpatriato
il
contingente
iberico
dal
fronte
russo,
il
20
rinnovato
un
patto
difensivo
con
il
Portogallo
(alleato
dell’Inghilterra),
il 2
maggio
1944
stabilito
un
accordo
commerciale
con
gli
anglo-americani.
A
ciò
si
aggiunsero
il
diritto
di
scalo
per
aerei
“civili”
americani,
il
mancato
riconoscimento
del
governo
di
Salò,
il
blocco
alle
esportazioni
di
minerali
in
Germania,
la
rottura
delle
relazioni
diplomatiche
con
il
Giappone
(11
aprile
1945)
e la
consegna
di
Pierre
Laval
e
Abel
Bonnard
al
governo
gaullista.
Per
il
momento,
il
regime
sembrò
poter
sopravvivere
anche
ad
una
guerra
mondiale.

|
|
|
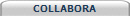
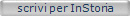
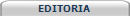
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
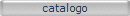
.
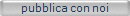
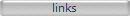
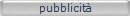
InStoria.it




|