|
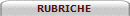

.

.

.

.
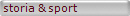
.
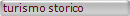
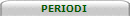
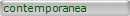
.

.
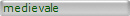
.


.
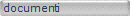
.
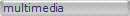
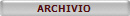


|
N. 29 - Maggio 2010
(LX)
RADICAL OR CONSERVATIVE?
OBAMA FRA LUCI E OMBRE
di Cristiano Zepponi
Negli
ultimi
tempi,
si
registrava
(e
si
registra)
un
riorientamento
della
politica
statunitense
nei
confronti
dell’America
Latina
tale,
forse,
da
permetterci
di
parlare
– al
fianco
di
un
“radical
wind”
diffuso
nel
Continente
– di
un
parallelo
e
insistente
“conservative
wind”.
Gli
Stati
Uniti
– da
cui
molto
ci
si
aspettava
dopo
l’unilateralismo
indifferente
della
precedente
amministrazione
–
sembrano
infatti
voler
riaffermare
la
propria
egemonia
e i
propri
interessi
sul
“cortile
di
casa”,
e
paiono
barcollare
tra
istanze
di
questo
genere
ed
entusiasmi
ispirati
dalla
nuova
amministrazione.
Dunque,
superato
un
periodo
iniziale
in
cui
la
maggioranza
degli
osservatori
ha
temuto
che
l’America
Latina
scivolasse
di
nuovo
in
secondo
piano
nelle
priorità
governative,
negli
ultimi
tempi
si
sono
registrati
segnali
“radicalmente”
diversi:
gli
U.S.A.
sembrerebbero
tornare
nella
regione
con
le
stesse
velleità
di
controllo
e
minaccia
potenziale,
di
“hard
power”,
di
“big
stick”
o
ancora,
per
dirla
con
Gramsci,
di
“egemonia”,
cui
ci
hanno
lungamente
abituato.
L’
“HOMO
NOVUS”
OBAMA?
Eppure,
il
nuovo
corso
dell’amministrazione
Obama
sembrava
partito
davvero,
per
una
volta,
con
un
atteggiamento
diverso
nell’area.
Nel
discorso
tenuto
in
campagna
elettorale
a
Miami
il
23
maggio
2008,
davanti
alla
Fondazione
nazionale
cubano-americana,
Obama
-
che
per
elaborare
la
sua
strategia
latino-americana
si è
avvalso
dell’esperienza
di
Frank
Sanchez,
consulente
d’impresa
di
Tampa
di
origini
spagnole,
nominato
“consigliere
per
le
relazioni
con
l’America
del
sud”
-
annunciò
il
“bisogno
di
un
cambiamento
nella
politica
verso
l’America
Latina”,
precisò
come
fosse
“ora
di
costruire
una
nuova
alleanza
per
le
Americhe”,
come
“dopo
le
ultime
due
amministrazioni
fallimentari
abbiamo
bisogno
di
rafforzare
la
leadership
per
il
futuro;
dopo
decenni
di
pressione
dall’alto
abbiamo
bisogno
di
una
agenda
che
promuova
democrazia,
sicurezza
e
pari
opportunità”
e
come
la
sua
politica
per
il
continente
sarebbe
stata
guidata
“dal
semplice
principio
secondo
cui
ciò
che
è
buono
per
i
popoli
delle
Americhe
è
buono
per
gli
Stati
Uniti”.
D’altra
parte
lo
stesso
Frank
Sanchez
assicurò
che,
con
l’elezione
di
Obama,
l’America
Latina
sarebbe
diventata
“una
priorità
nell’agenda
degli
Stati
Uniti”;
lo
stesso
Sanchez,
in
quella
sede,
attaccò
violentemente
le
amministrazioni
Bush,
colpevoli
d’essersi
“occupate
del
subcontinente
solo
per
coordinare
azioni
contro
il
narcotraffico
e
per
l’implementazione
di
Trattati
di
libero
commercio”:
e
per
quanto
riguarda
specificamente
questi
ultimi,
Obama
si
disse
disposto
a
rivedere
le
condizioni
del
Nafta
e di
altri
accordi
commerciali
bilaterali.
Sembrò
che
la
nuova
amministrazione,
spronata
anche
dalla
lettera
di
400
accademici
e
intellettuali
liberal
che
chiedevano
un
“cambio
fondamentale”
della
politica
U.S.A.
verso
l'America
Latina,
potesse
davvero
accogliere
il
grido
di
dolore
che
Edoardo
Galeano
aveva
diffuso
nel
2002,
in
un’intervista
all’
“Unità”:
Il
meccanismo
dei
prestiti
internazionali
è
come
un
cappio
stretto
intorno
al
collo
di
un
condannato
che
si
lascia
deliberatamente
in
fin
di
vita.
Il
debito
estero
di
fatto
impedisce
ai
governi
democraticamente
eletti
di
decidere
quale
tipo
di
politica
economica
e
sociale
utilizzare
per
risolvere
i
problemi
strutturali
tipici
dei
paesi
del
cosiddetto
terzo
mondo.
In
America
Latina
non
vola
una
mosca
senza
il
permesso
dell'alta
finanza
internazionale.
I
tecnici
e
gli
economisti
degli
organismi
finanziari
decidono
su
tutto.
I
nostri
paesi
non
sembrano
capaci
di
governarsi
da
soli
e
ricorrono
a
governanti
che
sono
teleguidati
dall'esterno,
come
marionette.
Ogni
volta
che
un
ministro
dell'economia
sudamericano
vuole
emettere
un
decreto,
anche
il
più
piccolo
e
insignificante,
anche
per
decidere
se
dipingere
una
porta
o
cambiare
un
citofono,
viaggia
prima
a
Washington
per
chiedere
il
permesso.
Questa
è la
regola
d'oggi:
i
creditori
possono
decidere
assolutamente
tutto
nella
vita
dei
debitori.
Arrivano
i
prestiti,
ci
strangolano
con
condizioni
che
bloccano
il
nostro
futuro,
ci
fanno
pagare
quattro
dollari
per
ogni
dollaro
che
riceviamo
e
noi
in
coro
diciamo
"che
bello",
"che
fortuna,
siamo
finalmente
incorporati
alla
cosiddetta
comunità
internazionale".
Abbiamo
bisogno
di
recuperare
la
nostra
ormai
perduta
dignità
nazionale.
Ma
non
è
facile.
Non
solo:
con
riferimento
a
Cuba,
Obama
annunciò
la
volontà
di
eliminare
molte
delle
restrizioni
sulle
rimesse
monetarie
e
sui
viaggi
verso
l’isola,
di
chiudere
al
più
presto
e in
via
definitiva
il
carcere
di
massima
sicurezza
di
Guantanamo
; e
addirittura
–
seppur
più
vagamente
–
sembrò
che
Obama
potesse
riallacciare
relazioni
diplomatiche
dirette
con
l’isola,
espletando
così
la
“precondizione”
(com’ebbe
a
definirla
la
presidentessa
argentina
Kirchner)
indispensabile
per
avviare
un
dialogo
autentico
non
solo
con
Cuba,
ma
con
tutti
gli
altri
Paesi
governati
da
forze
progressiste
e di
sinistra
con
programmi
antiliberisti
che
hanno
come
priorità
la
difesa
delle
risorse
nazionali
e la
redistribuzione
della
ricchezza.
Nel
corso
delle
elezioni,
come
sappiamo,
il
65%
degli
ispanici
americani
ha
votato
per
Obama:
evidentemente,
l’elezione
di
un
presidente
meticcio
non
ha
potuto
non
rappresentare
una
grande
speranza
nel
Continente
meticcio
per
eccellenza.
Sulle
ali
di
questo
entusiasmo,
al V
vertice
delle
Americhe
di
Trinidad
y
Tobago,
lo
stesso
Obama
si
impegnò
a
rilanciare
la
cooperazione
interamericana
su
basi
paritarie
e
solidali,
e
ripeté
che
“gli
Stati
Uniti
sono
cambiati;
non
è
stato
facile,
ma
sono
cambiati.
Ora
è
importante
ricordare
ai
miei
colleghi
latinoamericani
che
non
devono
cambiare
solo
gli
Stati
Uniti.
Tutti
abbiamo
la
responsabilità
di
guardare
al
futuro”.
Pur
rimanendo
sul
vago
sul
tema
dell’embargo
a
Cuba,
Obama
riaffermò
allora
la
sua
disponibilità
al
dialogo:
e
addirittura
gli
fu
rimproverata
un’eccessiva
cordialità
nei
confronti
di
Chàvez
(!),
tanto
che
il
Presidente
fu
costretto
a
rispondere
che
ciò
non
“pone
in
pericolo
gli
interessi
strategici
degli
Stati
Uniti”
e
che
il
suo
governo
avrebbe
badato
“ai
fatti,
non
alle
parole”.
.. O
NO?
I
segnali
che
autorizzano
le
preoccupazioni,
però,
sono
diversi.
Nessuno
si
aspettava
che
Obama
si
rivelasse
una
sorta
di
“principe
su
un
cavallo
bianco”,
come
ha
puntualizzato
la
presidentessa
Kirchner
lo
scorso
febbraio,
ma
(sempre
per
usare
le
sue
parole)
“per
i
paesi
latinoamericani
il
presidente
degli
Stati
Uniti
Barack
Obama
è
stato
una
delusione”;
sullo
stesso
tono
il
parere
del
Presidente
dell'Assemblea
Generale
delle
Nazioni
Unite,
il
nicaraguense
Miguel
D'Escoto:
"Obama
non
è il
cambio
credibile
che
stavamo
aspettando".
Tra
gli
argomenti
fondamentali
rinfacciati
alla
nuova
presidenza,
se
ne
possono
individuare
tre:
1.
LA
LOTTA
AL
NARCOTRAFFICO
Fin
dall’inizio
le
posizioni
più
retrive
della
nuova
amministrazione
apparvero
chiare
soprattutto
in
relazione
alle
politiche
di
sicurezza
e
alla
lotta
al
narcotraffico,
che
a
loro
volta
si
intrecciano
con
la
volontà
d’arginare
da
una
parte
il
frenetico
attivismo
finanziario
e
commerciale
cinese
nell’area
(commisurato
all’entità
di
prestiti
e
finanziamenti,
moltiplicatisi
negli
ultimi
anni
a
beneficio
di
Venezuela,
Ecuador,
Argentina
e
Brasile)
e
dall’altra
la
crescita
dell’influenza
iraniana
nei
Paesi
membri
dell’ALBA.
Secondo
il
Washington
Office
on
Latin
America
(Wola),
organismo
statunitense
per
i
diritti
umani
che
più
volte
ha
criticato
il
crescente
ruolo
assunto
nei
rapporti
con
la
regione
dal
Pentagono
e
del
Comando
Sud
(a
discapito
di
Congresso
e
Dipartimento
di
Stato),
“il
vuoto
lasciato
dai
politici
U.S.A.,
che
sembrano
trascurare
sempre
più
l’America
latina,
viene
occupato
dai
militari
che
ne
danno
un’immagine
distorta
fondata
sulle
minacce
alla
sicurezza”.
A
controprova
di
quanto
detto
e
sulla
base
di
suggestioni
di
questo
genere
il
neo-presidente
ha
accettato
la
continuazione
del
Plan
Colombia
e
dell’Iniziativa
Mérida
(o
Plan
México)
–
programmi
che
si
limitano,
ambedue,
al
controllo
militare
delle
zone
'a
rischio'
ed
alla
fumigazione
(con
diserbanti)
di
enormi
estensioni
e
che
costituiscono,
in
sintesi,
strumenti
più
idonei
a
giustificare
la
presenza
militare
statunitense
e a
garantire
l’apertura
totale
dei
due
Paesi
agli
investimenti
a
stelle
e
strisce
che
a
combattere
efficacemente
il
narcotraffico
.
Per
quanto
riguarda
il
Plan
Mèxico,
inoltre,
va
sottolineata
la
decisione
presidenziale
di
rimuovere
la
discriminante
relativa
ai
diritti
umani
che
precedentemente
condizionava
la
concessione
del
15%
dei
finanziamenti
U.S.A.,
lasciando
di
fatto
“campo
libero”
ai
governanti
messicani.
2.
LA
RI-MILITARIZZAZIONE
DELL’AREA
Già
nel
corso
del
2008
il
Pentagono
ha
riattivato
la
IV
Flotta
della
Marina,
sciolta
nel
1950
(dopo
aver
adempiuto
alla
sua
missione
difensiva
originaria
durante
la
seconda
guerra
mondiale)
ma
di
nuovo
incaricata
di
difendere
gli
interessi
statunitensi
nella
regione
latino-americana.
Tuttavia,
è
stata
la
decisione
del
presidente
ecuadoreño
Rafael
Correa
di
non
rinnovare
la
concessione
della
base
U.S.A.
di
Manta
ad
agitare
gli
scenari
geopolitici
sudamericani,
e a
porre
al
centro
dell’attenzione
la
rimilitarizzazione
della
regione:
l’amministrazione
statunitense
ha
infatti
risposto
allo
scacco
subìto
avvalendosi
dell’appoggio
del
presidente
colombiano
Uribe,
che
lo
scorso
14
agosto
ha
concesso
il
libero
utilizzo
di
sette
basi
militari
colombiane
e di
altri
impianti,
se
richiesto.
Obama,
internazionalmente
criticato
per
questo
massiccio
ritorno
armato
a
sud
dei
Caraibi
(tra
gli
altri,
il
Presidente
dell'Assemblea
Generale
delle
Nazioni
Unite
Miguel
D'Escoto
ha
parlato
in
proposito
di
“un
passo
indietro”),
ha
in
quell’occasione
affermato
che
“alcuni
stanno
cercando
di
utilizzare
l’accordo
come
parte
della
tradizionale
retorica
antiyankee;
noi
non
abbiamo
intenzione
di
stabilire
neppure
una
base
militare
in
Colombia”,
rifugiandosi
dietro
un
cavillo
giuridico
(in
effetti,
nominalmente,
le
nuove
basi
non
si
trovano
sotto
la
sovranità
statunitense).
E’
chiaro
a
tutti,
però,
che
la
presenza
militare
U.S.A.
sia
cresciuta
repentinamente
nell’ultimo
anno,
e
che
la
controffensiva
del
Dipartimento
proceda
senza
sosta.
Oltre
alle
basi
colombiane,
infatti,
il
governo
U.S.A.
ha
ottenuto
dalle
autorità
panamensi
l’autorizzazione
a
reinstallare
proprie
unità
militari
in
quattro
stazioni
navali
di
fondamentale
importanza
per
il
controllo
del
Canale
di
Panama
e
dei
Carabi:
oltre
alle
due
basi
navali
di
Bahía
de
Piña
e
Punta
Coca,
le
forze
armate
statunitensi
potranno
contare
sull’utilizzo
di
un’infrastruttura
aeronavale
che
sorge
nell’isola
di
Chapera,
nell’arcipelago
de
Las
Perlas,
e
della
base
di
Rambala,
nella
provincia
di
Bocas
del
Toro.
Parallelamente,
i
due
governi
hanno
concluso
un
importante
accordo
di
libero
commercio.
Al
tempo
stesso,
il
Venezuela,
nella
persona
del
presidente
Hugo
Chavez,
ha
denunciato
un
aumento
dell’aggressività
dell’asse
U.S.A.
-
Colombia
nei
confronti
del
suo
Paese
–
dimostrato
dalla
classificazione
del
Venezuela
come
Stato
“non
cooperante
nelle
operazioni
anti-droga”
(2005)
e
“non
pienamente
collaborativo
nella
guerra
contro
il
terrore”
(2006),
dalla
creazione
di
basi
militari
colombiane
alla
frontiera
e
dall’utilizzo
militare
statunitense
delle
isole
di
Aruba,
Curacao
e
Bonaire
nelle
Antille
olandesi,
al
largo
della
costa
caraibica
del
Venezuela,
oltre
che
dai
sempre
più
frequenti
voli
di
ricognizione
di
droni
UAV
sul
Paese.
Per
non
dimenticare,
infine,
che
l’arrivo
della
IV
flotta
(e
di
una
nutrita
forza
armata)
a La
Hispaniola
dopo
il
terremoto
del
12
gennaio
2010
ha
permesso
un
ulteriore
aumento
della
presenza
militare
U.S.A.
nella
regione:
ad
Haiti,
infatti,
nonostante
i
chiarimenti
del
Segretario
di
Stato
Hillary
Clinton
–
che
ha
più
volte
ribadito
l’intenzione
di
integrare
e
non
soppiantare
il
governo
locale
nell’esercizio
delle
funzioni
– è
soprattutto
l’esercito
statunitense
a
mantenere
l’ordine
in
luogo
della
polizia
e
dello
Stato
locale.
Si
riaccendono
in
un
colpo
solo
i
timori
per
la
rinascita
di
un
“imperialismo
su
invito”
(inaugurato
da
un
protettorato
light,
che
convinca
la
popolazione
del
benessere
garantito
dall’autorità
straniera
e
della
sua
incapacità
di
autogovernarsi)
e le
proteste
di
Francia
e
Brasile,
preoccupate
dall’ingerenza
statunitense
nella
gestione
dell’emergenza.
Per
quanto
abbiamo
appena
detto
il
presidente
venezuelano
Hugo
Chavez,
come
il
ministro
francese
per
la
cooperazione
Alain
Joyandet,
ha
ribadito
più
volte
che
“bisogna
aiutare
Haiti
e
non
occuparla
militarmente”.
3.
IL
GOLPE
IN
HONDURAS
L’immagine
dell’amministrazione
Obama
è
uscita
con
le
ossa
rotte
dall’affaire
Honduras.
Attirandosi
l’ostilità
della
comunità
internazionale
e di
buona
parte
dei
Paesi
sudamericani,
infatti,
gli
U.S.A.
hanno
riconosciuto
le
elezioni
del
29
novembre
2009
nel
Paese
che
pochi
mesi
prima
– a
giugno
–
aveva
subìto
un
golpe
militare
in
seguito
al
quale
il
presidente
in
carica
Manuel
Zelaya
è
stato
deportato
in
Costa
Rica
e le
violazioni
ai
diritti
umani
sono
cresciute
esponenzialmente.
Come
ha
raccontato
Greg
Grandin
“Honduran
president
Manuel
Zelaya
[...]
was
rousted
out
of
his
bed
on
Sunday
morning
by a
detachment
of
armed
soldiers
and
forced
into
exile
still
in
his
pajamas”;
e
non
si
trattava
certo
di
un
uomo
d’estrema
sinistra,
eletto
com’era
tra
le
file
del
partito
Liberale
e
solo
successivamente
sostenuto
da
altre
forze
sociali
inizialmente
avverse
–
secondo
Grandin
“unionists,
peasant
activists
and
reformers
expected
little
of
the
center-right
politician,
a
rancher
and
member
of
the
establishment
Liberal
Party.
Neither
did
the
handful
of
elite
Honduran
families
who,
bankrolled
by
foreign
finance,
control
their
country's
media,
banking,
agricultural,
manufacturing
and
narcotics
industries”.
La
proposta
di
legalizzare
alcune
droghe,
per
ovviare
alle
conseguenze
delle
“Guerre
contro
la
droga”,
“which
has
turned
Central
America
into
a
well-traversed
trans-shipment
corridor
for
narcotraficantes”;
il
discorso
al
Vertice
delle
Americhe
nel
quale
Zelaya
ha
insistito
affinché
gli
U.S.A.
normalizzassero
i
rapporti
con
Cuba;
il
sostegno
economico
venezuelano;
e,
soprattutto,
l'intenzione
di
indire
un
referendum
in
merito
alla
convocazione
di
un’Assemblea
Costituente:
questi,
i
motivi
che
hanno
scatenato
la
crisi
culminata
con
l’arresto,
la
deportazione
del
presidente
e la
sua
sostituzione
con
un
capo
di
stato
ad
interim,
“el
italiano”
Roberto
Micheletti
(opportunamente
soprannominato
“Pinochetti”
e
sostenuto,
tra
gli
altri,
dal
cardinale
Óscar
Andrés
Rodríguez
Maradiaga,
arcivescovo
di
Tegucigalpa,
presidente
della
Conferenza
episcopale
dell’Honduras),
che
garantisse
una
parvenza
di
legittimità
costituzionale
al
coup
d’etat.
Il
mondo
dell’informazione,
a
sua
volta,
ha
contribuito
a
confondere
le
acque
all’interno
del
Paese:
secondo
il
quotidiano
“El
Tiempo”
“il
golpe
è
stato
messo
in
atto
con
l’appoggio
del
nucleo
dominante
dell’imprenditoria
honduregna,
che
controlla
quasi
tutti
i
principali
mezzi
d’informazione
del
paese.
È
normale,
quindi,
che
dal
28
giugno
in
poi
la
maggior
parte
dei
quotidiani,
delle
radio
e
delle
tv
siano
diventati
strumenti
di
propaganda
nelle
mani
del
governo
de
facto”.
Tuttavia,
nonostante
la
quasi
unanime
condanna
dei
Paesi
sudamericani
(tranne
Colombia,
Costa
Rica,
Panama,
Repubblica
Dominicana,
Perù
e
Messico)
e il
parallelo,
mancato
riconoscimento
del
nuovo
governo,
nonostante
le
iniziali
parole
di
condanna
di
Obama
("We
don't
want
to
go
back
to a
dark
past.
We
always
want
to
stand
with
democracy
") e
la
lunga
battaglia
diplomatica
con
il
Brasile
(Zelaya
si
era
rifugiato
proprio
nell'ambasciata
brasiliana
a
Tegucigalpa),
come
detto,
gli
U.S.A.
hanno
riconosciuto
la
legittimità
delle
elezioni
tenutesi
in
Honduras
lo
scorso
29
novembre
e la
vittoria
del
candidato
Porfirio
Lobo.
E’
stato
Obama
a
spiegare
come
il
colpo
di
stato
in
Honduras
non
fosse
“legale",
e
come
il
presidente
Manuel
Zelaya
restasse
il
leader
legittimo;
ma
ha
prevalso
la
linea
del
Dipartimento
di
Stato,
che
non
ha
condannato
ufficialmente
il
colpo
di
stato
militare
del
giugno
precedente
e si
è
mostrato
riluttante
perfino
“to
use
the
word
‘coup’
to
describe
Zelaya's
overthrow,
since
to
do
so
would
trigger
automatic
sanctions,
including
the
suspension
of
foreign
aid
and
the
withdrawal
of
US
troops”,
applicando
solo
una
parte
delle
sanzioni
economiche
previste
dalla
legge.
Una
posizione
quantomeno
ambigua
nei
confronti
della
crisi
hondurena,
dunque,
per
la
nuova
amministrazione:
secondo
alcuni
(e
la
rivista
“Proceso”
in
primis)
sollecitata
dalla
vecchia
guardia,
tra
cui
il
Segretario
di
Stato
Hillary
Clinton.
Comunque
sia,
un’ombra
per
Obama.
CONCLUSIONI
“Basta
con
i
Trattati
di
Libero
Commercio
con
i
Paesi
dell’America
Latina”;
“Il
Trattato
di
Libero
Commercio
con
l’America
Latina
è un
modello”.
Il
presidente
Obama
ha
pronunciato
entrambe
le
frasi
nel
corso
della
stessa
campagna
elettorale,
addirittura
dello
stesso
dibattito
televisivo,
quasi
a
certificare
le
incertezze
e le
ambiguità
che
la
sua
amministrazione
avrebbe
rivelato
una
volta
giunta
al
potere.
Le
opinioni
degli
analisti
restano
comunque
discordi:
se
Ignazio
Ramonet
di
“Le
Monde
Diplomatique”
enfatizza
i
cambiamenti
rispetto
al
passato,
e
parla
di
“bilancio
positivo”,
James
Petras
(tra
gli
altri)
parla
di
un
“cambiamento
di
stile”
piuttosto
che
di
sostanza
nei
confronti
del
Sudamerica,
e
ridimensiona
di
molto
la
portata
del
cambiamento
nelle
relazioni
inter-americane.
Ad
ogni
modo,
i
più
ritengono
che,
rispetto
alle
aspettative,
l’amministrazione
Obama
abbia
cambiato
poco,
troppo
poco
a
dire
il
vero:
scarsi
i
passi
avanti
sull’embargo
di
Cuba,
la
lotta
alla
droga,
la
militarizzazione
dell’area,
i
trattati
di
libero
commercio,
i
rapporti
con
i
Paesi
tradizionalmente
meno
graditi
alle
amministrazioni
americane
(Ecuador,
Bolivia,
Venezuela).
Anche
per
questo
i 32
paesi
latino-americani
riuniti
nel
summit
di
Cancun
del
22/23
febbraio
hanno
deciso
di
creare
un
organismo
sovranazionale
americano
capace
di
comporre
le
controversie
latinoamericane
attraverso
la
negoziazione
politica
e
diplomatica,
escludendone
a
tutti
gli
effetti
il
Nord-america
(Canada
compreso).
Si è
così
creato
per
la
prima
volta
un
blocco
alternativo
all'ormai
logora
O.S.A.,
l’Organizzazione
degli
stati
americani,
da
50
anni
forum
principale
per
le
questioni
regionali,
capeggiato
e
soggiogato
in
tutto
a
Washington.
“Yes
we
can”,
a
dire
il
vero,
rischia
di
restare
uno
slogan
come
tanti,
nel
continente
delle
vene
aperte.

|
|
|
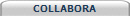
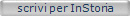
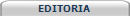
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
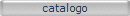
.
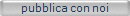
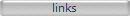
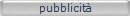
InStoria.it




|