|
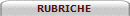

.

.

.

.
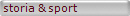
.
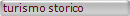
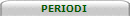
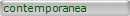
.

.
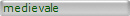
.


.
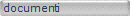
.
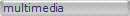
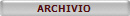

|
N. 22 - Ottobre 2009
(LIII)
L’INVASIONE FRANCESE DELL’ITALIA
Progressi, speranze, saccheggi e delusioni (aprile 1796, ottobre 1797)
di Cristiano Zepponi
Il
“Governo
del
Direttorio”
vide
la
luce
nel
1795,
fondandosi
sulla
più
durevole
delle
varie
Costituzioni
repubblicane,
quella
dell’anno
III,
che,
nonostante
la
svalutazione
di
cui
sarebbe
stato
oggetto,
seppe
realizzare
importanti
acquisizioni
legislative
(come
l’attivazione
di
un
sistema
nazionale
di
istruzione
pubblica)
e
politiche,
con
l’inizio
della
pratica
della
democrazia
rappresentativa,
incentivata
da
stampa,
voto,
gruppi
politici.
Toccò
proprio
a
questa
nascente
istituzione
il
difficile
compito
di
traghettare
il
conflitto
politico
stesso
entro
i
confini
della
legalità.
A
tutto
ciò,
inoltre,
si
deve
aggiungere
l’incombente
minaccia
di
un’invasione
straniera,
tesa
a
soffocare
l’eco
rivoluzionario
che,
com’è
noto,
si
temeva
potesse
diffondersi
nel
continente.
Contro
la
Francia
si
ergeva
allora
minacciosa
la
seconda
coalizione,
orfana
della
Prussia
(che,
esausta,
aveva
firmato
la
pace
il 5
aprile
1795),
della
Spagna
(22
luglio)
e
delle
Province
Unite
(16
maggio)
ma
comunque
temibile,
essendo
composta
da
Austria,
Napoli,
Baviera,
Regno
di
Sardegna
e da
vari
principati
italiani
e
tedeschi.
Proprio
l’Austria
aveva
sostituito
la
Spagna
nel
ruolo
di
potenza
egemone
in
Italia
(un
settore
naturalmente
molto
sensibile
per
gli
interessi
francesi),
ereditandone
i
territori
nel
1713,
in
seguito
alla
guerre
di
successione
spagnola
(con
i
conseguenti
trattati
di
Utrecht
e
Rastadt)
e in
misura
minore
polacca
(1733-1738).
In
questo
settore
fu
inviato
un
giovane
artigliere
còrso,
che
si
era
fatto
un
nome
nella
repressione
della
rivolta
di
Tolone
ed
era
stato
considerato
molto
vicino
a
Robespierre
ed
ai
giacobini:il
giovane
generale
Buonaparte
(come
ancora
si
faceva
chiamare,
all’italiana)
assunse
il
comando
dell’Armata
d’Italia
il
27
marzo
1796
succedendo
a
Schèrer,
sperimentato
ma
dimostratosi
poco
competente.
La
sua
nomina
destò
sorpresa:
non
aveva
pratica
di
alti
comandi,
e
subito
i
maligni
insinuarono
che
dovesse
il
suo
posto
ai
favori
resi
a
Robespierre
prima
(il
cui
appoggio
era
stato
conquistato
con
un
semplice
opuscolo
politico,
“Le
super
de
Beaucaire”,
che
condannava
la
disobbedienza
al
governo
giacobino
delle
zone
ostili
della
Francia
meridionale)
ed
in
seguito,
nei
fatti
del
Vendemmiaio,
a
Barras,
potente
membro
del
Direttorio,
oltre
che
alla
relazione
con
la
futura
imperatrice
Josèphine
Beauharnais,
la
bella
creola
che
tanti
contatti
altolocati
continuava
a
coltivare.
L’Armata
d’Italia
(titolo
altisonante,
che
suscitava
non
poche
ironie
negli
avversari)
aveva,
nell’ambito
della
strategia
del
Direttorio,
il
solo
scopo
di
contenere
austriaci
e
piemontesi,
mentre
il
ruolo
principale
sarebbe
spettato
a
Jourdan
e
Moreau
nell’Europa
centrale.
Anche
per
questo,
era,
nella
migliore
delle
descrizioni,
un
eterogeneo,
disordinato
e
raccogliticcio
insieme
di
uomini,
più
vicini
all’ammutinamento
che
ad
una
seppur
vaga
immagine
di
soldati.
Il
morale,
di
conseguenza,
ne
risentiva:
uomini
sporchi,
più
somiglianti
a
briganti
che
a
soldati,
privi
anche
delle
loro
misere
razioni
accumulate
da
speculatori
nelle
retrovie.
La
paga
era
in
ritardo
di
mesi,
le
divise
lacere.
La
forza
effettiva
assommava
a
38000
uomini,
quasi
tutti
sull’orlo
della
diserzione
per
la
propaganda
sotterranea
di
agenti
realisti.
A
molti
battaglioni
mancavano
scarpe
e
persino
baionette,
possedevano
solo
200
muli,
i
cavalli
erano
da
un
anno
a
mezza
razione.
Uno
sfacelo.
Lo
riconobbe
lui
stesso
nel
primo
proclama:
“Soldati,
voi
siete
nudi,
mal
nutriti.
Il
governo
vi
deve
molto,
esso
non
può
darvi
nulla”.
Capì
presto,
quindi,
che
l’offensiva
sarebbe
stato
l’unico
modo
per
evitare
la
disgregazione
dell’armata.
Gli
argomenti
che
usò
per
animare
la
truppa
ne
indicano
il
morale:
“Voglio
condurvi
nelle
più
fertili
pianure
del
mondo;
ricche
province,
grandi
città
saranno
in
vostro
potere”.
Gli
rispose
un’acclamazione
ammirata:
la
prima
manifestazione
di
un
rapporto
destinato
a
diventare
magnetico.
Si
avvalse
di
subordinati
sperimentati
e un
po’
invidiosi,
che
ritenevano,
ognuno,
di
meritare
il
posto
del
piccolo
ventisettenne.
Tra
questi
il
parigino
Augerau
e
Massèna
di
Nizza,
un
ex-contrabbandiere,
e
Victor,
già
conosciuto
all’assedio
di
Tolone.
La
sua
“eminenza
grigia”,
come
la
definisce
Chandler,
era
Berthier,
un
uomo
poco
fantasioso
ma
eccezionale
nel
lavoro
direttivo.
E
poi
un
gruppo
di
talenti
giovanissimi:
Murat
alla
cavalleria,
che
suppliva
ad
una
certa
debolezza
intellettuale
con
slancio
e
coraggio,
e
Junot,
artigliere
e
amico
di
vecchia
data.
Dovevano
affrontare
Jean-Pierre
Beaulieu,
vecchio
generale
austriaco
di
45
anni
più
anziano
di
Bonaparte,
e
sotto
di
lui
Argentau,
Melas,
Wukassovich,
Liptay,
Sebottendorf,
comandanti
di
un’armata
asburgica
inevitabilmente
di
composizione
multinazionale,
comprendente
elementi
serbi,
croati,
austriaci,
ungheresi.
Ad
affiancarli,
le
forze
del
Regno
di
Sardegna,
addestrate
secondo
i
canoni
austriaci
da
apposite
missioni
imperiali,
e
guidate
proprio
da
un
austriaco,
Colli,
e
dal
principe
di
Carignano.
Questi
comandanti,
in
futuro
molto
criticati,
erano
inoltre
figli
di
un’altra
generazione,
dell’700,
di
Federico
il
Grande,
di
un
mondo
che
non
capì,
né
poteva,
le
forze
scaturite
dalla
Rivoluzione.
“Le
petit
caporal”
(come
sarà
affettuosamente
apostrofato),
come
detto,
doveva
attaccare.
Per
il
morale,
per
la
fiducia,
per
mangiare
e
vestirsi.
E
poi
i
coalizzati
apparivano
diffidenti
l’uno
con
l’altro,
divisi,
pieni
di
mutua
sfiducia.
La
campagna,
prevista
per
il
15
aprile,
dovette
essere
inaugurata
con
quattro
giorni
d’anticipo
per
l’inatteso
attacco
austriaco
contro
Voltri.
Torino
era
stanca
della
guerra,
si
sapeva,
e
quindi,
nonostante
il
parere
contrario
del
Direttorio,
i
Francesi
attaccarono
proprio
in
quella
direzione.
Il
12
aprile
a
Montenotte
gli
austriaci
furono
battuti.
Fu
la
prima
vittoria
del
giovane
Bonaparte
nella
campagna:
i
soldati
imperiali
si
videro
piombare
addosso
da
ogni
parte
le
truppe
di
Massèna,
forti
di
baldanza
ed
entusiasmo;
e
così
avvenne
a
Dego
due
giorni
dopo
portando
alla
morte
del
generale
Causse
e
alla
promozione
di
Lannes,
che
un
giorno
sarà
maresciallo
dell’Impero.
Il
21
Sèrurier
trionfò
a
Mondovì,
caricando
coraggiosamente
davanti
alle
sue
colonne,
il
23
cominciò
l’avanzata
su
Torino,
con
i
vari
elementi
dell’armata
a un
giorno
di
marcia
l’uno
dall’
altro.
Quella
stessa
sera
Colli,
alla
guida
dei
Piemontesi,
dopo
aver
perso
5000
uomini,
i
cannoni
e le
bandiere,
ed
aver
capito
che
i
soldati
col
tricolore
tenevano
la
posizione
centrale
tra
lui
e
gli
austriaci,
chiese
una
tregua,
che
sarebbe
passata
alla
storia
con
la
denominazione
di
“armistizio
di
Cherasco”.
Il
re
di
Sardegna,
Vittorio
Amedeo
III,
lo
approvò
ufficialmente
il
28,
e,
subito,
Murat
corse
a
riferirlo
al
Direttorio.
In
dieci
giorni
il
Piemonte
fu
piegato.
Torino,
peraltro,
piacque
al
conquistatore
al
punto
tale
che
ordinò
la
costruzione
di
un
nuovo
ponte
a
cinque
arcate
e di
numerose
strade,
nelle
vicinanze.
”Annibale”
disse
in
quei
giorni
”ha
attraversato
le
Alpi.
Noi
le
abbiamo
aggirate.”
Prendeva,
rapidamente,
coscienza
di
se’.
E
presuntuoso,
quello,
lo
era
anche
col
Direttorio:
”L’esercito
ha
approvato
il
trattato
di
pace”,
affermò,
con
spaventoso
abuso
di
potere.
Nessuno
aveva
mai
parlato
in
modo
tanto
spavaldo
al
suo
governo;
avrebbero
voluto
fucilarlo,
all’interno
del
governo,
né
lo
nascosero:
nelle
reazioni
alle
sue
vittorie
lo
spavento
per
l’ardimento
del
ragazzo
fu
sempre
superiore
alla
gioia.
Lui
si
concentrò
sul
suo
mestiere:
Beaulieu
evacuò
Alessandria,
ai
primi
di
maggio
passò
il
Po e
lì
lo
attese,
il
quale,
basandosi
su
una
clausola
del
trattato
col
Piemonte,
credeva
che
i
Francesi
sarebbero
passati
a
Valenza.
Massèna
glie
lo
fece
credere.
Scrisse
il
giovane
isolano:
”Beaulieu
casca
continuamente
nelle
trappole
che
gli
tendiamo”.
I
francesi
passarono
il
Po a
Piacenza
il 7
e 8
maggio,
sul
lato
nord.
Qui
fu
firmata
una
tregua
col
duca
di
Parma,
che
fruttò
quadri
e
milioni
per
la
traballante
economia
d’oltralpe.
Importante
è
notare,
con
radici
che
affondano
nella
perenne
crisi
economica
in
cui
si
dibatteva
la
Francia
(la
quale
spiega,
in
parte,
la
stessa
Rivoluzione),
che
non
era
il
Paese
a
nutrire
l’armata,
ma
il
contrario,
e
non
per
l’ultima
volta:
anche
il
duca
di
Modena
ne
sarebbe
stato
presto
vittima.
L’armata
francese
mosse
allora
compatta
alla
caccia
degli
imperiali,
schierati
ora
lungo
la
riva
sinistra
dell’Adda.
Bonaparte
(come
si
nota
è
cambiata
anche
la
firma;
ora
che
si
trovava
in
guerra
con
l’Italia,
non
voleva
nulla
che
lo
riportasse
al
suo
paese
d’origine),
ebbe
allora
un’idea
che
rasentava
la
follia:
forzare
il
passaggio
del
ponte
di
Lodi.
Lo
difendevano
diecimila
moschetti
e
trenta
cannoni,
tutto
quello
che
si
riuscì
a
trovare
nelle
ultime,
concitate
ore.
I
granatieri,
contro
ogni
previsione,
attraversarono
il
ponte
urlando
e
rovesciarono
la
prima
linea
nemica.
Lodi
non
fu
una
vittoria,
fu
un
simbolo.
In
quella
carica,
l’Europa
vide
la
Rivoluzione.
Conclusa
quella
giornata
memorabile
(era
il
10
maggio
1796)
disse
al
suo
aiutante
Marmont:
”Sento
che
mi
sono
predestinate
azioni
di
cui
questa
generazione
non
ha
presagio”.
Si
era,
definitivamente,
convinto
della
propria
grandezza.
Non
dovette
certo
difendersi
solo
dagli
austriaci:
il
suo
governo
voleva
dividere
l’Armata
e
affiancargli
Kellermann.
Ne
avevano
capito
l’ascendente
sulla
truppa;
ma
lui
rifiutò,
trattando
da
pari
a
pari
con
tutti,
definendo
“impolitico”
dividere
il
suo
esercito,
e la
spuntò.
Anche
il
duca
di
Parma
aveva,
il 9
maggio,
ceduto
ad
un
armistizio
che
lo
vedeva
costretto
a
pagare
un’alta
indennità
di
guerra,
a
consegnare
grano,
cavalli,
bestiame
e
numerose
opere
di
celebri
personalità
artistiche,
tra
cui
un
Correggio,
un
Raffaello,
un
Tiziano
(“l’incoronazione
di
spine”)
e un
Salvator
Rosa;
lo
stesso
accadde
al
ducato
di
Modena,
costretto
a
versare
circa
altri
venti
capolavori.
Lunghi
convogli
li
trasportarono
oltralpe,
tra
la
silenziosa
rabbia
delle
popolazioni,
e la
denuncia,
da
parte
di
alcuni
intellettuali
–
tra
cui
Pietro
Verri
–
della
rapacità
dell’Armata.
”Il
15
maggio
1796
il
general
Bonaparte
entrò
in
Milano
alla
testa
del
giovane
esercito
che
aveva
varcato
il
ponte
di
Lodi
e
mostrava
al
mondo
come
dopo
tanti
secoli
Alessandro
e
Cesare
avessero
un
successore”,
scrisse
Stendhal,
nella
Certosa
di
Pavia,
al
culmine
dell’entusiasmo.
Con
buona
dose
di
esibizionismo,
furono
mandati
avanti
i
prigionieri,
secondo
l’uso
degli
imperatori
romani;
poi
promesse
di
libertà,
indipendenza,
protezione:
magari
le
parole
costano
poco,
o
magari,
come
qualcuno
ha
suggerito,
vi
era
ancora
idealismo,
in
lui.
Chissà.
Lo
stesso
giorno,
col
trattato
di
Parigi,
il
re
di
Sardegna
riconobbe
la
cessione
di
Nizza
e
della
Savoia.
A
Milano
i
giovani
ufficiali
dell’esercito
rivoluzionario
toccarono
l’apice
della
gioia.
Scrisse
ancora
Stendhal:
“Se
i
milanesi
erano
pazzi
di
entusiasmo,
i
francesi
erano
pazzi
di
felicità”.
Dopo
allora,
l’entusiasmo
dei
“liberati”,
già
scarso,
per
la
verità,
agli
esordi,
diminuì
sensibilmente:
al
punto
che
appena
lasciata
la
città
dai
conquistatori
(il
22
maggio),
questa
e
Pavia
si
ribellarono,
provocando
la
resa
della
guarnigione
nella
seconda.
La
posta
era
politica:
se i
due
centri
avessero
resistito,
si
sarebbe
detto
che
l’Italia
fosse
con
gli
austriaci.
La
prospettiva
fu
però
presto
scongiurata,
pur
continuando
nel
contempo
l’inseguimento
degli
avversari.
Il
giovane
generale
rischiò
nel
periodo
la
vita
più
volte
(al
punto
di
creare
le
Guide,
la
sua
scorta
personale
che
un
giorno
diverranno
gli
chasseurs-à-cheval
della
Guardia
Imperiale),
senza
risparmiarsi,
continuando
a
mostrarsi
in
prima
linea
per
spronare
i
soldati,
che
attraversavano
un
periodo
particolarmente
duro.
La
guarnigione
di
Mantova
continuò
a
resistere
testardamente
per
otto
mesi
(l’assedio
comincia
il 3
giugno),
e
gli
eserciti
austriaci
tentarono
più
volte
di
soccorrerla.
Venezia,
nel
frattempo,
fu
costretta
ad
accettare
un
diktat
pesante,
dovendo
fornire
ai
francesi
viveri
e
vettovaglie.
Profetizzando,
i
due
inviati
della
Serenissima
scrissero
al
governo
il 5
giugno:
“Quest’
uomo
avrà
un
giorno
grande
influenza
sulla
sua
patria”.
In
luglio
altre
due
armate
sotto
il
comando
di
Quasdanovich
e
Wurmser
sbucarono
dalle
Alpi
per
soccorrere
Mantova
con
50000
uomini:
quest’ultimo
era
un
vecchio
sordo,
lento,
prevedibile.
Ma i
suoi
uomini
costituivano
l’elite
imperiale.
E un
prete
italiano
si
stupì,
al
punto
da
scrivere:
“È
sorprendente
come
questi
uomini
morenti
di
fame,
pochi,
piccoli,
deboli,
logorati
da
fatiche
e
privazioni,
senza
vestiti
né
scarpe
–
uomini
che
si
prenderebbero
per
i
relitti
di
una
popolazione
decimata
–
possano
distruggere
l’esercito
austriaco,
composto
di
veterani
di
grande
altezza,
robusti
e
rotti
alla
guerra”.
I
francesi,
frattanto,
si
occuparono
anche
del
Papa,
assaltando
il
forte
Urbano
nei
pressi
di
Castelfranco
Emilia
e
mettendo
in
subbuglio
la
Toscana.
Il
29
giugno,
almeno,
cade
il
Castello
Sforzesco
di
Milano:
una
preoccupazione
in
meno.
L’assedio
di
Mantova
fu
interrotto
per
contrastare
la
poderosa
calata
austriaca
il
31
luglio.
Ma
Wurmser
era
lento,
troppo
lento,
e
pur
in
superiorità
di 2
a 1
permise
al
còrso
di
recuperare
la
prediletta
posizione
centrale
tra
le
due
armate
austriache
e di
combattere,
come
scrive
Gerosa
(“Napoleone”,
pag.
107),
la
lotta
di
“Orazio
contro
i
Curiazi”.
Prima
se
la
prende
con
Quasdanovich,
sconfitto
a
Lonato,
mentre
Augerau
tenne
a
bada
Wurmser
presso
Castiglione
(di
cui
sarà
fatto
duca:
ma
non
da
Napoleone,
beansi
da
Luigi
XVIII).
Poi,
il 4
agosto,
solo,
fu
costretto
a
decidere
se
ritirarsi
verso
Milano
o
rischiare
l’azzardo.
Prevalse
il
secondo:
il 5
agosto
l’esercito
francese
si
schierò
a
Castiglione.
Allora
Wurmser,
attaccato
di
fronte
da
Augerau
e
sul
fianco
da
Sèrurier,
si
ritirò.
Morivano
così
le
speranze
di
Venezia
e
dell’Italia
in
genere,
che
avevano
vissuto
la
calata
imperiale
come
una
liberazione.
Gli
orgogliosi
soldati
dell’imperatore
fuggirono
verso
Trento.
Il
secondo
blocco
di
Mantova
cominciò
così
il
24
agosto.
A
settembre,
per
l’ennesima
volta,
Wurmser
calò
in
Italia
e,
ancora,
divise
l’esercito.
Il 4
l’Armata
d’Italia
affrontò
Davidovich,
cui
era
stata
affidata
una
delle
due
ali,
a
Rovereto,
e
dopo
averlo
sconfitto
entrò
a
Trento,
e
poi
a
Bassano,
dove
si
rifugiava
Wurmser.
Lento
ma
indomito,
l’austriaco:
si
chiuse
alfine
a
Mantova,
dove
rimase
bloccato
dal
primo
ottobre.
Marmont
corse
allora
a
Parigi
a
portare
le
bandiere
catturate.
E
Bonaparte,
nominato
con
affetto
sergente
dai
suoi
fanti,
pensava
(o
fingeva
di
pensare…)
all’unità
d’Italia,
ad
un
congresso
da
tenersi
“a
Modena
e a
Bologna”per
“decidere
una
federazione
tra
i
comuni,
l’organizzazione
di
una
Legione
Italiana,
l’invio
di
deputati
locali
a
Parigi
per
chiedere
libertà
ed
indipendenza”.
Il
Direttorio
era,
e
rimase,
sordo
all’argomento,
ma i
patrioti
fondatori
le
neonate
Repubbliche
Cispadana
e
Transpadana
erano,
comunque,
incoraggiati.
Era
questo
solo
un
pensiero,
però.
Le
sue
Repubbliche
lo
furono
solo
di
nome,
e
per
breve
tempo.
Ora
le
preoccupazioni
erano
altre.
La
guerra
in
Germania
andava
male,
Moreau
e
Jourdan
erano
l’uno
in
ritirata
e
l’altro
sconfitto
a
Würzburg.
In
più,
Alvinczy
si
staccò
dall’armata
vittoriosa
dell’arciduca
Carlo
per
raccogliere
i
resti
delle
armate
sconfitte
precedentemente
e
insieme
liberare
Mantova.
Massèna
lo
ributtò
sulla
riva
sinistra
del
Brenta,
poi
sorsero
difficoltà.
L’ultima,
disperata
mossa
francese
fu
di
passare
attraverso
le
paludi
dell’Adige
e
attaccare
Alvinczy
alle
spalle,
ma
per
farlo
c’era
prima
un
altro
ponte
che
sarebbe
passato
alla
storia:
quello
di
Arcole,
dove
il
futuro
imperatore
guidò
i
suoi
ad
infruttuosi,
ma
epici
assalti
(durante
i
quali,
con
poco
eroismo
cadde
dentro
la
palude
sottostante).
Dirà
poi:
“Era
un
canto
dell’Iliade!”
ripensando
alla
giornata.
In
quei
giorni
di
novembre
arrivò
anche
a
inventare
espedienti
fantasiosi
per
ingannare
l’avversario:
un
ufficiale
nero
(che,
guarda
caso,
si
chiamava
Ercole)
con
25
Guide
e 4
trombe
finse,
inscenando
un
fracasso
infernale,
un
attacco
sul
fianco
e
ottenne
il
risultato
voluto;
gli
austriaci
sbandarono
e si
ritirarono
verso
Vicenza.
Anche
Davidovich
rinunciò
all’impresa,
mentre
la
consapevolezza
della
catastrofe
si
diffondeva
lentamente
anche
in
Austria.
Dopo
il
riposo
milanese
che
accompagnò
la
fine
di
quel
lungo
anno
Alvinczy
ci
riprovò:
ma a
Rivoli
le
cariche
di
Leclerc
e
Vassalle,
e i
rinforzi
di
Massèna,
lo
punirono
di
nuovo.
Merezkovskij
annotò
che,
stavolta,
solo
per
il
sangue
freddo
del
piccolo
caporale
una
sconfitta
divenne
vittoria.
E
Provera,
ultimo
spiraglio
di
luce
per
Mantova
assediata,
fu
raggiunto
a
San
Giorgio
(dopo
una
marcia
inumana
di
24
ore)
e
sconfitto.
Furono
venti,
terribili
giorni
del
gennaio
1797.
Wurmser,
ancora
asserragliato
a
Mantova,
offrì
la
resa
a
Sèrurier:
e,
favorendo
la
nascita
di
un’aneddotica
assai
diffusa,
Bonaparte
partecipò
al
colloquio
con
l’emissario
imperiale
incaricato
di
trattarlo
fingendosi
un
ufficiale
qualsiasi,
per
poi
rivelarsi
e
dettare
le
sue
condizioni.
Mantova
capitolò
il 2
febbraio
1797,
e il
giovane
vincitore
si
rivelò
magnanimo
con
lo
sconfitto.
Per
riguardo
all’anzianità,
si
direbbe.
E
col
suo
operato
conquistò
tutti,
anche
Wurmser
stesso,
che
gli
svelò
un
attentato
in
preparazione
ad
opera
del
Papa;
il
casus
belli
col
papato
fu
un
malaccorto
tentativo
di
alleanza
antifrancese
con
l’imperatore.
La
guerra
fu
breve,
e
anche
la
S.ta
Sede
fu
presto
costretta
alla
pace
(firmata
a
Tolentino
il
19
febbraio
1797),
dopo
aver
rinunciato
alle
Legazioni
Pontificie
di
Bologna
e
Ferrara
e le
Romagne.
Ma
lui
evitò
di
entrare
in
Roma
(né
la
vide
mai),
ma
ottenne
soldi,
manoscritti,
la
Trasfigurazione,
L’Apollo
del
Belvedere,
il
Lacoonte.
Disse
bene
affermando
che
“un’opera
d’arte
resta
nei
secoli,
un
milione
è
presto
speso”.
Paul-Luis
Courier
scrisse,
nelle
“Lettres
de
Rome”:
“Tutto
ciò
che
apparteneva
ai
Certosini,
a
Villa
Albani,
ai
Farnese,
agli
Onesti,
al
museo
Clementino,
al
Campidoglio
è
stato
portato
via,
saccheggiato,
perduto
o
venduto.
Una
squadra
di
soldati,
entrati
nella
Biblioteca
Vaticana,
ha,
fra
le
altre
rarità,
distrutto
il
famoso
“Terenzio”
del
Bembo,
per
prendere
le
poche
dorature
di
cui
il
manoscritto
era
adorno.
La
“Venere”
di
Villa
Borghese
è
stata
colpita
ad
una
mano;
all’Ermafrodito
hanno
rotto
un
piede”.
A
marzo
fu
inviato
a
sbarrare
la
strada
alla
marcia
francese
l’arciduca
Carlo,
anch’egli
giovane
e
promettente,
ma
invano;
la
sua
era
una
truppa
raccogliticcia
e
sfiduciata.
Il
Tagliamento
fu
passato
il
16,
il
30
l’Armata
era
già
a
Klagenfurt,
sulla
via
di
Vienna,
il
31
offrì
la
pace:
il
suo
fu
un
proclama
molto
ben
riuscito,
ma
questa
venne
però
rifiutata
dall’imperatore.
Era,
per
dirla
come
Norvins,
“condannato
a
vincere”.
A
Judenburg,
90
leghe
dalla
capitale,
si
mostrò
duro
con
gli
emissari
imperiali,
affermando:
“Il
vostro
governo
mi
ha
mandato
contro
quattro
armate
senza
generali
e
stavolta
un
generale
senza
armata”,
con
freddezza
e
ironia.
Ma
quando
essi
si
accorsero
che
l’armistizio
fosse
l’unica
soluzione
per
salvare
la
monarchia,
e,
soprattutto,
che
il
golpe
di
Barras,
Rewball
e La
Revellière-Lèpeaux
(il
“secondo
Direttorio”
per
gli
storici)
aveva
prevenuto
quello
di
Pichegru,
Carnet
e
Francois
Barthèlemy
e
portato
alla
distruzione
della
destra
realista
in
Francia,
sondarono
il
terreno
per
la
sospensione
delle
ostilità.
Fu
una
pace
particolare,
in
cui
entrambi
i
contraenti
si
sforzarono
di
non
tirare
troppo
la
corda.
Le
condizioni
preliminari
furono
firmate
il
18
aprile.
Il
15
maggio,
intanto,
dopo
vari
massacri
e
scaramucce,
era
caduta
la
Serenissima,
rimpiazzata
da
una
municipalità
repubblicana.
Pesaro,
capo
del
governo,
che
aveva
precedentemente
invitato
tutti
a
massacrare
gli
“invasori”
(che
caddero,
in
effetti,
a
centinaia),
fu
ora
punito.
”Vogliamo
sangue”,
scriveva
infuriato
Napoleone
al
Direttorio.
Soliti
indennizzi
artistici
per
i
vincitori:
è la
regola,
in
Italia.
Tiziano,
Tintoretto,
persino
i
leoni
di
bronzo
di
S.
Marco,
e
poi
la
flotta
e
Corfù,
l’isola,
secondo
Omero,
di
Nausicaa,
passarono
ai
transalpini.
Genova,
altra
città
dal
passato
marinaro,
insorse
il
31
maggio
e fu
subito
occupata.
La
Repubblica
Ligure
sorse
dove
moriva
il
governo
della
nobiltà,
e
successivamente,
il 9
luglio,
fu
creata
la
Repubblica
Cisalpina,
fondendo
la
Transpadana
e la
Cispadana,
cui
il
24
si
aggiunse
la
Romagna
grazie
al
trattato
di
Tolentino.
A
Milano
in
settembre
l’Amministrazione
Generale
della
Lombardia,
istituita
alla
fine
dell’agosto
1796,
dietro
invito
dei
conquistatori
bandì
un
concorso
in
cui
i
patrioti
italiani
furono
invitati
ad
esprimersi
su
“Quale
dei
governi
liberi
meglio
convenga
all’Italia”:
e
l’esito
fu
la
generale
richiesta,
da
ogni
parte
della
penisola,
di
un
governo
repubblicano
indipendente,
in
forme
unitarie.
Ma i
“giacobini”,
appellativo
dei
patrioti
rifugiati
a
Milano,
per
perseguire
l’obiettivo
unirono
alle
forme
legali
anche
attività
cospirative;
fu
proprio
per
questo
che
dai
francesi
furono
invece
appoggiati
in
seguito
i
“moderati”,
reclutati
tra
i
ricchi
borghesi
e le
vecchie
aristocrazie,
favorevoli
all’uguaglianza
giuridica
ma
terrorizzati
dalle
idee
di
uguaglianza
sociale
e di
regolamentazione
dell’attività
economica.
Il
“triennio
giacobino”
(1796-1799),
e il
suo
tentativo
di
applicare
i
principi
più
genuini
dell’”’89”
francese,
costituì
comunque
un’esperienza
importante,
rompendo
col
clima
politico
riformista
degli
anni
’80
e
favorendo
la
nascita
di
una
generazione
imbevuta
di
ideali
unitari,
purtroppo
destinata
a
delle
cocenti,
profonde
delusioni
politiche.
Quella
che
sarebbe
divenuta
nota
col
nome
di
Pace
di
Campoformio
aveva
nel
frattempo
avuto
una
lenta
gestazione,
per
essere
poi
definitivamente
ratificata
il
17
ottobre
1797.
L’Imperatore
d’Austria
cedette
i
Paesi
Bassi
austriaci
(Belgio),
l’occupazione
della
riva
sinistra
del
Reno
e
delle
Isole
Ionie
e
riconosceva
la
nuova
Repubblica
Cisalpina.
In
cambio,
ricevette
l’appena
occupata
Repubblica
di
Venezia,
con
le
sue
basi
e
dipendenze
in
Istria,
Dalmazia
e
Friuli
e
nel
Levante.
Come
si
disse,
il
trattato
lasciò
“..indifferenti
i
francesi,
felici
gli
austriaci
e
disperati
gli
italiani..”.
La
Francia
aveva
riscosso
un
successo
dove
nessuno
se
lo
sarebbe
aspettato.
Ma,
di
riflesso,
la
forza
militare
diventava
essenziale
per
il
potere
politico,
che
dimostrava
l’incapacità
di
risolvere
i
suoi
conflitti
interni
nel
quadro
della
legalità
costituzionale.
Si
lasciò
però,
con
rara
miopia
politica,
che
l’Impero
tenesse
un
piede
in
Italia,
a
garanzia
di
futuri,
ulteriori
scontri.
Si
sacrificava
Venezia,
con
un
trattamento
tanto
doloroso
da
riflettersi
nella
letteratura
contemporanea,
con
le
“Ultime
lettere
di
Jacopo
Ortis”
di
Ugo
Foscolo,
che,
con
tono
amaro
e
disilluso
(“il
sacrificio
della
Patria
nostra
è
consumato..”),
denunciano
l’inganno
vero,
le
elites
patriottiche
italiane.
E
poi
con
Vittorio
Balzoni
(“Rapporto
sullo
stato
attuale
dei
paesi
liberi
d’Italia
e
sulla
necessità
ch’essi
siano
fusi
in
una
sola
Repubblica”)
ed
anche
Vittorio
Alfieri
(“Misogallo”),
che
arrivò
a
scrivere
“..infami
al
pari
dei
vincitori
i
vinti”.
Inoltre,
le
promesse
unioni
fra
i
diversi
popoli
che
componevano
le
varie
entità
politiche
della
penisola
furono
osteggiate
dal
Direttorio,
e
rapidamente
dimenticate.
Presto,
quindi,
si
verificarono
ovunque
i
primi,
infruttuosi
attentati
alla
vita
del
“petit
caporàl”
(che
comunque
abbandonò
l’Italia,
nel
novembre
1797,
per
lanciarsi
in
una
nuova
ed
esaltante
avventura
in
Egitto),
e
soprattutto
le
prime
rivolte
popolari,
spiegate
anche
dal
proseguimento
di
un
continuo,
crescente
saccheggio
del
patrimonio,
soprattutto
artistico,
della
penisola;
politica
peraltro
caldeggiata
sempre
dal
Direttorio,
che
ordinava
di
“fare
piazza
pulita
dell’Italia”,
senza
essere
peraltro
soddisfatto
dell’espropriazione
fiscale
che
si
dimostrava,
comunque,
propedeutica
all’asfissiante
situazione
delle
casse
francesi.
Per
la
prima
volta,
dunque,
l’esercito
nutriva
il
paese,
oltre
che
sé
stesso.
Le
Repubbliche
“sorelle”,
peraltro,
avviarono,
in
questi
anni
e
nei
successivi,
un
mutamento
radicale
nelle
vecchie
strutture:
furono
aboliti
i
diritti
feudale
ed i
titoli
nobiliari,
incamerati
i
beni
della
Chiesa,
riformati
gli
apparati
giudiziari;
si
diffusero
la
stampa
periodica
e i
club,
consentendo
una,
seppur
limitatissima,
attività
democratica.
Ma
l’instabilità
politica
ereditata
dal
paese-guida,
la
crisi
economica,
aggravata
dalle
requisizioni
forzate,
ed
anche
la
coscrizione
obbligatoria
decretata
dalla
“riforma
Jourdan”
del
’98,
annullarono
in
buona
misura
queste
novità
indubbiamente
positive.
In
conclusione,
possiamo
ritenere
che
il
periodo
debba
essere
considerato,
per
l’Italia,
in
modo
ambivalente:
la
stessa
nascita
del
tricolore,
derivato
direttamente
dalla
bandiera
francese,
dimostra
lo
stimolo
portato,
anche
se
forse
senza
una
volontà
precisa
in
merito,
al
sentimento
unitario
italiano.
Nonostante
dalla
patria
della
Rivoluzione,
ad
esempio,
i
rivoluzionari
di
Alba,
Cuneo
e
Asti
fossero
abbandonati
alla
feroce
repressione
sabauda
nella
prima
fase
della
campagna,
da
questo
momento
l’unità
d’Italia
parve
chiaramente
conseguibile.
Nonostante
la
dura
disillusione
dei
giacobini,
rimpiazzati
nel
ruolo
di
classe
dirigente
dai
moderati,
o la
triste
fine
dell’indipendenza
veneziana,
o la
momentanea
perdita
di
tanta
parte
del
nostro
patrimonio
artistico,
infatti,
la
parabola
della
Rivoluzione
toccò,
con
conseguenze
importanti,
il
Paese
intero,
influenzandolo
sensibilmente
dal
punto
di
vista
sociale
culturale.
Se
si
può
parlare,
a
buon
diritto,
dell’ennesima
occasione
persa
per
stimolare
una
rinascita
socio-economica
(uniforme
e
costante)
della
penisola,
le
nuove
strutture
amministrative
permisero
quantomeno
di
superare
il
vecchio
sistema
feudale,
l’”ancièn
regime”
nostrano.
Nonostante
i
patrioti
avessero
subito
un’altra
delusione
storica
di
proporzioni
incalcolabili,
fu
proprio
quella
delusione
a
contribuire
alla
formazione
delle
future,
moderne
classi
dirigenti.
Gli
alberi
della
libertà,
innalzati
idealmente
in
tutta
la
penisola,
piantarono
le
loro
radici
in
profondità
nel
tessuto
collettivo,
e
non
furono
abbattuti,
né
dalle
scuri
né
dalla
Restaurazione.

|
|
|
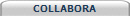
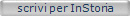
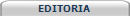
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
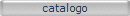
.
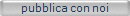
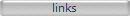
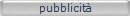
InStoria.it



|