|
moderna
LA CRUZ DEL QUEMADERO
LA MEMORIA DELL’INQUISIZIONE A MADRID
di Valeria La Donna
Il 12 aprile del 1869, il
Boletín Oficial del Ayuntamiento,
quotidiano locale della città di Madrid,
informava i propri lettori di un
ritrovamento agghiacciante avvenuto nel
nuovo Ensanche urbano. Era,
questo, un terreno nella zona nord e
nord-est del centro abitato che,
all’epoca, era in pieno processo di
espansione e i cui lavori febbrili di
ampliamento miravano a un incremento
della popolazione di circa 150.000
abitanti.
La straordinaria scoperta, effettuata
durante lo scavo di un grosso
appezzamento di terreno, venne
preannunciata dal
Boletín
con un titolo in latino che i lettori
dell’epoca erano ancora capaci di
riconoscere alla perfezione, il vecchio
lemma dell’Inquisizione spagnola:
«EXURGE DOMINE ET JUDICA CAUSAM TUAM
(“Alzati, Signore, e giudica la tua
causa”). Il caso ha appena
rivelato un’orribile impronta
dell’oscuro tribunale che aveva questo
terribile motto. Ai margini della calle
Ancha de San Bernardo […], in un luogo
conosciuto come la Cruz del Quemadero,
ed indicato in antiche opere e scritture
come il braciere degli Autodafé, nel
creare delle radure per regolarizzare la
pendenza e allineare la Ronda a quella
che era la porta di Bilbao, sono apparsi
grandi strati neri di terreno,
orizzontali, irregolari, fino a 150
piedi di longitudine. […] È, in poche
parole, l’archivio geologico delle
fiamme dell’Inquisizione, sotto forma di
strati sedimentari che dimostrano la
crescita, l’apogeo e il decadimento dei
roghi, a seconda delle loro dimensioni.
Questi sono di carbone polverizzato,
untuoso, e tra di essi vi si trovano
anche ossa e pezzi di corda
carbonizzata» [Boletín Oficial
del Ayuntamiento, 1869].
Le ricerche effettuate nei giorni
successivi portarono alla luce ulteriori
resti di quello che era stato
chiaramente un incendio di proporzioni
considerevoli: pezzi di legno, anelli di
ferro, un cranio, un bavaglio. Tutto più
o meno carbonizzato. Vennero inoltre
dissotterrati un lungo ciuffo di
capelli, di appartenenza femminile,
nonché piccole porzioni di materiale
adiposo che cedevano al tatto come se
fossero burro.
Quanto ipotizzato a prima vista,
pertanto, trovò ben presto conferma
certa: i macabri ritrovamenti tra gli
scavi altro non erano che il frutto
della combustione di decine di corpi
carbonizzati dal fuoco dei roghi
purificatori della Santa Inquisizione; e
il campo de la Cruz del Quemadero,
il luogo principale in cui essa ne
dispose lo smaltimento.
A partire dal 1624, anno in cui venne
realizzato il primo autodafé a Madrid,
infatti, furono molte le persone
consegnate alla giustizia secolare in
città, per poi essere condannate a
morte. Prima di quella data, le
proclamazioni solenni delle sentenze
dell’Inquisitore, seguite dalle condanne
al rogo degli eretici, venivano eseguite
nella vicina Toledo, l’unica tra le due
a essere provvista di un Tribunale del
Sant’Uffizio.
Il fatto che la Corte avesse stabilito
la sua sede a Madrid fu una circostanza
che risultò essenziale per la formazione
di un nuovo Tribunale con giurisdizione
sulla città e, ben presto, durante il
regno di Filippo IV – in pieno Siglo
de Oro – esso divenne il quartier
generale del Sant’Uffizio, incaricato di
riesaminare i casi e di dare istruzioni
a tutti gli altri tribunali
inquisitoriali della penisola.
Fu anche il momento in cui la capitale
iberica entrò nel suo periodo più
oscuro, diventando lo scenario di
violenze, crimini e orrori che si
sarebbero perpetrati per oltre 200 anni,
fino alla scomparsa definitiva
dell’Inquisizione nel 1834, durante la
reggenza di Maria Cristina di Borbone.
Ovvero, appena 30 anni prima dei macabri
ritrovamenti presso la Cruz del
Quemadero.
Tra i vari autodafé svolti a Madrid nel
corso dei secoli, ve n’è uno in
particolar modo a cui, secondo gli
storici, si possono attribuire i resti
recuperati nel 1869. Si tratta di una
delle cerimonie più conosciute e più
spettacolari mai eseguite, coram
populo, nella Spagna dell’età
moderna, durante la quale vennero
condannati ben 120 rei provenienti da
ogni angolo del paese: l’autodafé del 30
giugno 1680, sotto il regno di Carlo II.
Fu, questo, un doppio catechismo
politico e religioso che permise alla
monarchia ispanica, da un lato, di
recuperare l’antico splendore dopo un
periodo di ineluttabile decadenza e al
cattolicesimo, dall’altro, di
presentarsi come nemico del
protestantesimo, dell’islamismo e
dell’ebraismo, personificati nei 120
imputati condannati.
L’autodafé doveva diffondere
l’insegnamento religioso e propagare gli
ideali della Controriforma elaborati
durante il Concilio di Trento nella
seconda metà del XVI secolo, diventando
così luogo di protezione e difesa dei
contenuti della fede e delle forme di
culto attaccate dai seguaci del
luteranesimo. E Carlo II, investito di
una missione provvidenziale, doveva
essere un nuovo Cesare, forte e
valoroso, cui spettava addomesticare i
mostri dell’infedeltà e riparare i torti
fatti a Dio e alla Chiesa cattolica.
Attraverso questo atto solenne,
l’Inquisizione contava quindi di
esaltare la missione provvidenziale del
Sant’Uffizio all’interno dell’apparato
statale. Ma non solo. Con il tempo aveva
finito per perseguire anche altri tipi
di condotte, come i delitti contro la
morale sessuale, la stregoneria, la
sodomia, le arti magiche e divinatorie.
Oltre a essere un discorso politico e
religioso, però, l’autodafé era anche
una questione culturale. Formava parte
delle grandi feste classiche spagnole,
così come le cerimonie di ingresso dei
principi, le sfilate del Corpus
Domini, le processioni votive, ecc.
Era spettacolo, rappresentazione,
teatro, divertimento, un misto di festa
liturgica e festa civile che creava
grandi aspettative tra la popolazione.
Motivi per cui era necessario
organizzare qualcosa di grandioso,
eclatante, memorabile.
Lo spettacolo, di cui si conoscono tutti
i particolari grazie al resoconto
dettagliato che
José
de Olmo scrisse nella sua
Relación histórica del auto general de
fe que se celebró en Madrid este año de
1680,
venne preannunciato già un mese prima
attraverso la pubblicazione di un bando
e del vessillo del Sant’Uffizio che
rimase appeso al balcone
dell’inquisitore generale fino al giorno
dell’esecuzione.
Tre anni più tardi, il pittore Francisco
Rizi volle darci ulteriore testimonianza
dell’evento dipingendo il famoso quadro
Auto de fe del 30 de junio de 1680,
en la plaza Mayor de Madrid,
conservato oggi al Museo del Prado, che
riproduce, fedelmente e con precisione
storica, la disposizione di autorità,
assistenti e detenuti durante la
luttuosa commemorazione.
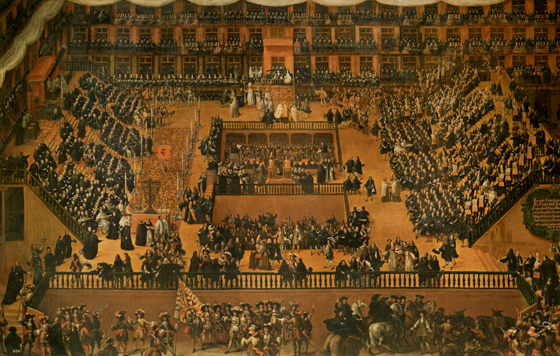
È proprio grazie al racconto di de Olmo
se siamo venuti a conoscenza
dell’ubicazione del brasero che,
200 anni dopo, avrebbe rivisto la luce
durante gli scavi del nuovo Ensanche
urbano. Ed è sempre grazie al racconto
di de Olmo, e alla sua grande dovizia di
dettagli, se ci è possibile ricostruire
tutti gli accadimenti di quel giorno
funereo come se fossimo stati testimoni
attivi dell’evento.
30 giugno 1680. Non un giorno qualsiasi
a Madrid. La città e la Corte erano in
agitazione perché quel giorno si sarebbe
celebrato uno dei più grandi autodafé
mai realizzati prima in Spagna. A
presiederlo, il sovrano Carlo II, che
avrebbe assistito alla cerimonia dalla
tribuna appositamente costruita per
l’occasione in Plaza Mayor. Lo
spettacolo che stava per svolgersi
suscitava in parti uguali rifiuto ed
esaltazione tra gli abitanti della Villa
che, in trepidante attesa, urlavano
“Viva la fede di Cristo!” per le strade
affollate della città.
Tutto era pronto. Il giorno prima, al
crepuscolo, seguendo il rigoroso
protocollo che vigeva per l’occasione,
si erano svolte le processioni della
Cruz Verde (simbolo di misericordia)
e della Cruz Blanca
(simbolo di giustizia e castigo), la
prima diretta a Plaza Mayor, la seconda
verso il quemadero di San
Bernardo.
I condannati si trovavano da giorni
nelle carceri del Tribunale, presidiati
dalla Compagnia dei Soldati della Fede:
250 uomini appartenenti ai diversi
ordini militari, con il compito di
accompagnare i detenuti al loro processo
e consegnarli al braccio secolare per
l’esecuzione delle sentenze. Ad
assisterli spiritualmente, due religiosi
con l’obiettivo primario di raggiungere
il loro pentimento e farli abiurare.
Dei 120 condannati, 86 erano presenti in
carne e ossa. I restanti 34, invece,
erano raffigurati in effigie, sotto
forma di fantocci dalle fattezze umane
che avrebbero sostituito i colpevoli
fuggiti o morti prima del processo
affinché le loro anime potessero
ricevere il castigo del Sant’Uffizio.
Tra i rei presenti, uomini, donne,
bambini e famiglie intere con età
comprese tra i 13 e i 76 anni, che
avrebbero affrontato il processo con
l’accusa di ebraismo e, in percentuali
minori, di frode, stregoneria, bigamia e
altre colpe più leggere.
La notte fu lunga e tutti rimasero
svegli, tra singhiozzi e preghiere. Alle
tre del mattino furono distribuiti gli
abiti penitenziali – principalmente
corozas e sanbenitos – che
erano differenziati a seconda della
sentenza emessa. Il sanbenito era
una tunica di tela gialla lunga fino
alle ginocchia, sulla quale era dipinto
il ritratto del condannato che la
indossava in mezzo a fiamme, draghi e
diavoli. Questo costume – destinato ai
cosiddetti pertinaces – indicava
che chi lo portava sarebbe stato
bruciato vivo, poiché eretico
incorreggibile. Diverso era invece il
sanbenito per i penitenti
convertiti, con fiamme rivolte verso il
basso, e quello dei condannati a una
semplice penitenza, su cui era
raffigurata una croce. La coroza
era infine un cappello di cartone a
forma conica, lungo quasi un metro, su
cui, analogamente al sanbenito,
erano rappresentati croci, fiamme o
draghi, in base al verdetto emanato.
Alle sette del mattino ebbe inizio la
processione che dalle carceri condusse i
condannati lungo le vie principali della
città per fare pubblica ammenda. Con le
loro vesti penitenziali indosso e con in
mano delle candele gialle spente, a
simboleggiare la loro anima impura,
ricorsero le strade tra lanci di pietre
e offese, per giungere infine a Plaza
Mayor:
«I primi trentaquattro rei sotto forma
di fantocci, perché già morti o
fuggitivi, dei quali trentadue erano
relajados (cioè consegnati al braccio
secolare, ovvero alla giustizia civile,
per l’esecuzione delle sentenze
pronunciate dagli inquisitori),
indossavano corozas con fiamme […]. Tra
i colpevoli che uscirono a piedi, undici
erano stati incarcerati con abiura de
levi, alcuni per essersi sposati due
volte, altri per superstizione, altri
per essere ipocriti imbroglioni, e tutti
con candele gialle spente in mano. Gli
imbroglioni e i bigami portavano
corozas, qualcuno tra di loro anche una
corda alla gola, con tanti nodi quante
erano le frustate a cui erano stati
condannati […]. C’erano poi
cinquantaquattro rei giudaizzanti, tutti
con sanbenitos con croce a metà o
intera, e con candele come i precedenti.
Infine uscirono i ventuno rei condannati
al rogo, tutti con coroza e sanbenito
con le fiamme, con draghi tra di esse
per i pertinaces, e dodici tra di loro
con i bavagli alla bocca e le mani
legate (per evitare che, durante la loro
marcia pubblica, diventassero violenti,
proferissero blasfemie o insultassero il
tribunale)»
[De Olmo 55-56].
Una volta a Plaza Mayor, i condannati
furono condotti in fila fino
all’imponente pedana su cui svettava la
monumentale Croce Verde, emblema
dell’Inquisizione spagnola. A presiedere
il processo dal balcone reale, il
sovrano Carlo II, la consorte Maria
Luisa d’Orléans e la regina madre,
attorniati da gentiluomini e dame della
corte, nobili ed ecclesiastici che
trovarono sistemazione sui balconi
vicini. Il rumore era assordante. La
piazza era gremita di gente comune che,
eccitata, non smetteva di insultare gli
imputati e invocare giustizia.
Una volta cominciata la messa e
pronunciato il sermone, il silenzio calò
tra la folla. Il Sovrano fece il suo
giuramento, promettendo sulla sua parola
reale che avrebbe difeso strenuamente la
fede cattolica, perseguitando gli
eretici e castigando, conformemente ai
diritti e ai sacri canoni, chiunque le
si fosse opposto.
A questo punto, l’Inquisitore generale,
Don Diego Sarmiento de Valladares, diede
inizio alla parte più lunga della
cerimonia: la lettura delle cause e
delle pene. Uno alla volta, i detenuti,
o la loro effigie, vennero condotti
nelle gabbie poste al centro del palco
dove, dopo un’accurata disamina delle
colpe, sarebbero stati poi consegnati
alle autorità civili per l’applicazione
delle punizioni.
Alle quattro del pomeriggio, dopo otto
ore di processo, si conclusero le
sentenze dei condannati a morte che
vennero quindi condotti al quemadero,
nella periferia nord della città. Le
facce sconvolte dei prigionieri mentre
scendevano dalla tribuna riflettevano
l’inevitabilità del loro destino; con
una differenziazione, secondo de Olmo,
molto marcata tra pentiti e non:
«E veramente, se si fa attenzione ai
segni esteriori, a cui lì tutti fecero
caso, [...] si può notare la profonda
differenza riscontrata tra reducidos e
pertinaces, come quella che vi è tra
prescelti e reprobi. Questi ultimi
avevano un colorito orribile, con occhi
sconvolti dai quali sembrava sgorgassero
fiamme, e la fisionomia dei volti
stravolta, come se fossero posseduti dal
demonio. I convertiti, invece,
camminavano con umiltà, conforto,
obbedienza e gioia spirituale tali da
sembrare benedetti dalla grazia di Dio.
Si può credere che siano già in cielo
per le tante preghiere e suffragi che i
devoti hanno fatto per le loro anime»
[De Olmo 75-76].
Da anni i roghi si tenevano nella zona
nord della Villa, al di là delle nuove
mura fatte costruire nel 1625 da Filippo
IV, con il fine di evitare che l’odore
insopportabile si propagasse per il
centro cittadino. La pira, una catasta
di legna di 16 metri di lunghezza e due
di altezza su cui si ergevano i pali a
cui sarebbero stati legati i condannati,
era già pronta dalla sera prima. Intorno
a essa, i soldati della fede cercavano
di assicurarsi che tutto si svolgesse
senza problemi e senza scontri, seppure
invano. Tanta era infatti la calca
formatasi, da non riuscire a impedire il
lancio ripetuto di sassi e verdure marce
ai prigionieri, che rischiarono in più
occasioni di soccombere a tanta ferocia.
I reducidos, in quanto pentiti
delle loro colpe, e pertanto meritevoli
di ricevere un alleggerimento della
pena, vennero previamente strangolati
tramite garrota e soltanto in seguito
lanciati sul rogo. Diversa fu la sorte
dei pertinaces – gli impenitenti
– poiché affrontarono le fiamme del
Sant’Uffizio da vivi.
Il coraggio dei ventuno, uomini e donne,
nel sopportare questa morte orrenda fu
ammirabile; tutti si abbandonarono al
proprio destino con una tale
determinazione che alcuni degli
spettatori, sorpresi, si rammaricarono
del fatto che simili anime eroiche non
fossero più illuminate. Le strazianti
grida di dolore che si udirono non
appena le lingue di fuoco cominciano a
lambire le loro membra, cessarono in
pochi minuti, al sopraggiungere della
morte per collasso o asfissia: «Si
eseguirono i supplizi, dapprima
strangolando i reducidos con una
garrota, poi appiccando il fuoco ai
pertinaces, che furono arsi vivi con non
pochi segni di dolore, angoscia e
disperazione. E gettati tutti i cadaveri
nel fuoco, i boia continuarono ad
alimentarlo durante tutta la notte fino
a che non li ebbe ridotti in cenere,
all’incirca verso le nove del mattino»
[De Olmo 76].
Fu così che volse al termine una delle
cerimonie più violente ed efferate di
tutti i tempi. Nei giorni successivi
vennero effettuate le punizioni per i
rei rimasti, che furono tolti nuovamente
dalle carceri per essere fustigati e
condannati alla pubblica vergogna, salvo
poi ritornarvi, a Madrid o dislocati a
Toledo, per scontare la propria pena.
Ciò che rimaneva invece delle ventuno
vite umane arse sul rogo era soltanto un
mucchio di cenere calda che qualcuno, da
lì a poco, avrebbe raccolto per farne
poi liscivia da utilizzare nei
lavaderos presso il fiume
Manzanarre. Il loro ricordo cadde
nell’oblio.
I ritrovamenti del 1869, che tanto
sconvolsero i madrileni dell’epoca, si
risolsero alla fine in un nulla di
fatto. I resti, umani e non, vennero
dimenticati e la costruzione del nuovo
Ensanche urbano riprese il suo
corso.
Ciò che si può osservare oggigiorno, in
quella che è attualmente la glorieta
de Ruiz Jiménez, è soltanto una
moltitudine di persone che passeggiano
distratte, bambini che corrono in bici e
coppiette di adolescenti che si
scambiano effusioni sulle panchine.
Nessuno di loro è consapevole che, sotto
i loro piedi, si nascondono le fiamme di
una delle più spaventose e
raccapriccianti storie della città di
Madrid; il luogo in cui, durante secoli,
centinaia di innocenti persero la vita,
inutilmente, nel nome del Signore.
Riferimenti bibliografici:
Bernat G., El Auto de Fe en la Plaza
Mayor de Madrid (1680).
Del Olmo J. V., Relación histórica
del Auto general de Fe que se celebró en
Madrid en el año de 1680 con asistencia
del Rey don Carlos II, Imprenta de
Cano, Madrid 1820.
Exurge domine et judica causam tuam,
in Boletín Oficial del Ayuntamiento, año
I, n° 6, 1869, p. 4.
La Cruz del Quemadero y la memoria de la
inquisición en Madrid,
Centros de estudio sobre el Madrid
islámico.
Parello V., Una fiesta barroca en
tiempos de Carlos II: el auto de fe
madrileño de 1680, in OpenEdition
Journals, 8, 2011. |