|
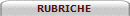

.

.

.

.
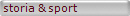
.
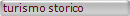
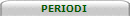
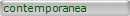
.

.
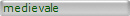
.


.
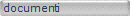
.
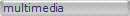
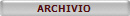


|
N. 25 - Gennaio 2010
(LVI)
quando il diavolo entra duro
Destino e mito di due squadre di calcio
di Giuseppe Tramontana
Il
ballo
prende
avvio
allo
Stadio
Mu
Dung
di
Gwangju,
Corea
del
Sud,
esattamente
alle
ore
17
locali
del
19
settembre
1988,
San
Gennaro.
Per
l’esattezza,
a
ballare
cominciano
gli
undici
giocatori
in
maglia
arancione,
mentre
gli
altri
undici,
in
maglia
azzurra,
hanno
deciso
di
assistere
svogliatamente
allo
spettacolo.
Un
po’
come
i
9800
spettatori
sugli
spalti,
autoinvitatisi
alla
festa
di
quel
pomeriggio.
Spettatori
che,
ad
occhio
e
croce,
appaiono
più
interessati
degli
azzurri
a
quanto
sta
per
accadere
sul
tappeto
verde.
Fin
da
subito
si
capisce
come
sarebbero
andate
le
cose.
Gli
arancioni
danzano
sulla
palla,
la
fanno
circolare,
fluida,
come
una
canna
attorno
ad
un
falò.
Agili,
svelti,
scattanti,
ottimo
palleggio,
buonissimo
controllo.
E
poi
dribblig
e
controdribblig,
funambolici
disimpegni,
supremazia
in
tutte
le
parti
del
campo.
Quelli
in
maglia
azzurra
arrancano,
sbuffano,
sudano,
si
dannano
l’anima.
Non
riescono
ad
indovinarne
manco
una.
E
dài
al
centro.
Ma
la
prendono
gli
altri.
E
crossa
lungo
che
ci
arrivano
i
difensori
avversari.
E
tenta
un
affondo
che
ti
chiudono
in
fallo
laterale.
E
poi
gli
arancioni
ripartono.
Tac
tac,
due
passaggi
e
sono
in
area
di
rigore.
E
una
volta,
gli
azzurri
si
salvano.
E
due
volte,
si
salvano.
Il
filtro
a
centrocampo
non
funziona.
Ma,
perché,
la
difesa
va
invece?
No,
certo
che
no.
E
l’attacco?
Una
lagna.
Gli
azzurri,
ovviamente
sono
gli
italiani.
Ma
gli
arancioni
non
sono
l’Olanda.
Indossano
questa
casacca
solo
per
l’occasione.
E
benché
pressino
a
tutto
campo
e
siano
capaci
di
far
sparire
la
palla
alla
vista
degli
avversari
per
farla
ricomparire
a
limite
dell’area
di
rigore
che
manco
il
teletrasporto,
loro
sono
solo
lo
Zambia,
i
Chipolopolo,
che
abitualmente
indossano
la
maglia
verde.
Verde
acceso,
come
la
speranza,
il
sogno,
il
raggio
di
Rohmer.
Gli
italiani
sono
balbettanti.
Camminano
e
corrono
con
la
corrente
alternata.
Sarà
il
caldo?
Certo,
30
gradi
non
sono
pochi,
ma
neanche
la
fine
del
mondo.
Intontiti,
confusi,
con
i
cubetti
di
porfido
in
testa.
Non
capiscono,
ma
si
adeguano.
Al
gioco
altrui.
Gli
africani
dominano,
controllano,
non
li
lasciano
respirare
manco
con
la
maschera
d’ossigeno.
Gli
zombie
in
azzurro,
tramortiti,
si
guardano
e
non
si
vedono.
Il
cittì
Francesco
Rocca,
Kawasaki,
si
dimena,
cerca
soluzioni,
trova
un
muro
di
cemento
armato
alto
alto.
Rivestito
di
gomma
insonorizzante.
L’Italia
schiera
gente,
campioni,
come
Stefano
Tacconi
in
porta,
Pietro
Paolo
Virdis
ed
Andrea
Carnevale
in
attacco,
Massimo
Mauro
come
regista,
Ciro
Ferrara,
Mauro
Tassotti,
Roberto
Cravero
e
Roberto
Galia
in
difesa,
Giuseppe
Iachini,
Luigi
De
Agostini
a
centrocampo,
supportati
da
Angelo
Colombo
come
esterno
destro.
In
panchina
gente
come
Pagliuca,
Rizzitelli,
Evani,
Desideri,
Massimo
Crippa
ed i
meno
conosciuti
Brambati,
Pellegrini
Carobbi
e
Giuliani
(terzo
portiere).
Ma
non
necessariamente
tanti
buoni
calciatori,
o
persino
campioni,
fanno
una
squadra.
Due
giorni
prima
gli
italiani
avevano
affondato
sotto
cinque
gol
i
malcapitati
guatemaltechi.
5-2.
Lo
Zambia
aveva
pareggiato
per
2-2-
con
l’Iraq.
Il
gruppo
B ci
sembra
Disneyland.
Si
assapora
una
finale
e,
chissà,
se
la
fortuna
ci
aiuta…
Ma
al
40°
della
partita
del
19
settembre,
arriva
la
prima
bastonata.
Non
proprio
inattesa.
Pallone
recuperato
a
centrocampo
dalla
difesa
africana,
in
chiusura
su
Colombo,
passaggio
a
Musonda
che
dall’inizio
del
match
fa
su e
giù
con
la
precisione
implacabile
di
un
pistone
nel
cilindro.
Bene,
Musonda,
non
guarda
nemmeno.
Sa
che
lì
davanti
c’è
Kalusha
Bwalya.
Dritto
per
dritto
per
il
compagno.
Scatto
dell’attaccante,
mentre
la
difesa
pettina
le
bambole
e
sinistro
in
corsa.
Tacconi
che
gli
è
andato
incontro,
in
tuffo,
riesce
solo
a
smorzare
il
tiro.
Ma
il
pallone,
lentamente,
lo
supera,
calamitato
beffardamente
in
fondo
alla
rete.
1-0
e
Italia
a
bocca
aperta
e
testa
in
ampolla.
Si
va
al
riposo
sul
vantaggio
verde.
Durante
l’intervallo,
Kawasaki
Rocca
deve
essere
andato
giù
duro
di
striglia,
se
la
squadra
torna
in
campo
un
po’
più
compatta,
determinata.
Ma
dura
poco.
Appena
dieci
minuti.
Al
55°,
l’arbitro
inglese
Hackett
punisce
con
un
calcio
di
punizione
dal
limite
un’entrata
neanche
troppo
assassina
di
Ciro
Ferrara
su
Nyirenda.
Siamo
al
vertice
sinistro
alto
dell’area
di
rigore.
Al
centro
poca
ressa.
Solo
due
giocatori
in
maglia
arancione.
Tacconi
fuori
dai
pali,
pronto
all’uscita.
Ma
Kalusha
Bwalya
non
ha
nessuna
intenzione
di
crossare
al
centro.
Anzi.
Di
sinistro
scavalca
la
barriera
e
insacca
direttamente,
sotto
lo
sguardo
di
pongo
di
Tacconi
e di
tutti
gli
italiani.
Una
beffa.
Si
corre
dall’arbitro
chiedendo
l’annullamento:
era
di
seconda.
Ma
Hackett
non
ne
vuol
sapere:
era
di
prima
e il
gol
è
valido.
2-0
e
azzurri
con
il
morale
di
uno
stercorario.
Rocca
corre
ai
ripari.
Al
61°
richiama
in
panchina
Cravero
e
Colombo
e
getta
nella
mischia
Luca
Pellegrini
e
Massimo
Crippa.
Due
minuti
dopo,
lo
Zambia
va
sul
3-0.
Bastonata
da
lontano,
a
pallonetto
leggermente
deviato
da
Pellegrini,
del
numero
7,
Johnson
Bwalya
(neanche
parente
dell’altro
Bwalya,
Kalusha)
e
Tacconi
è di
nuovo
sorpreso.
Una
statua
di
sale.
Sale
e
bile.
Ma
il
bello
è
che
i
verdi
non
la
smettono.
Corrono,
pressano,
palleggiano,
dribblano.
Sembra
che
siano
appena
scesi
in
campo.
Freschi
come
una
rosa.
Gli
italiani,
in
campo,
mostrano
la
leggiadria
di
un
monumento
sovietico
degli
anni
cinquanta.
Dopo
un
altro
paio
di
occasioni
–
una
in
particolare
porta
Johnson
Bwalya
a tu
per
tu
con
Tacconi
-
gli
africani
calano
il
poker.
Improvvisa
verticalizzazione
di
Melu
per
il
solito
Kalusha
Bwalya
che
si
ritrova
davanti
al
portiere
azzurro
assolutamente
indifeso.
Sinistro
rasoterra
e
gol.
4-0.
Una
delle
più
atroci
disfatte
dell’Italia
calcistica.
Paragonabile
alla
Corea
del
’66.
Ma
il
cammino
non
sarà
pregiudicato.
In
quel
girone,
lo
Zambia,
che
sconfiggerà
anche
il
Guatemala
con
lo
stesso
punteggio
di
4-0,
arriverà
primo,
mentre
l’Italia,
sconfitto
due
giorni
dopo
l’Iraq
per
2-0,
arriverà
seconda.
Nei
quarti
ai
Chipolopolo
toccherà
la
Germania
di
Jurgen
Klinsmann,
Karl-Heinz
Riedler
e
Thomas
Hassler.
Perderanno
4-0.
L’Italia
andrà
un
po’
più
avanti.
Eliminerà
ai
supplementari
–
grazie
ad
un
gol
di
Crippa
al
98°,
dopo
che
i
tempi
regolamentari
si
erano
chiusi
sull’1-1
– la
Svezia.
In
semifinale
incontrerà
l’URSS
di
Michailychenko
e
Dobrovolsky.
Perderà,
sempre
ai
supplementari,
per
3-2.
E
perderà
anche
la
finale
per
il
terzo
posto
con
la
Germania:
3-0.
In
finale,
invece,
i
sovietici
sconfiggeranno
il
Brasile
di
Romario,
Bebeto
e
compagnia
cantante:
2-1
e
medaglia
d’oro.
Solita
tragica
disperazione
in
Brasile.
E i
verdi
dello
Zambia?
I
pronostici
e il
futuro
sono
tutti
per
loro.
Quella
performance
contro
l’Italia
da’
credito
alle
previsioni
degli
esperti
che,
fin
dal
1982,
con
il
Camerun
e
l’Algeria,
paventa
la
grande
crescita
del
calcio
africano.
Il
calcio
del
duemila:
corsa,
tecnica,
resistenza,
palleggio,
dribbli.
Solo
il
senso
tattico
era
da
migliorare.
A
volte
erano
un
po’
poco
smaliziati,
ingenui.
Ma
questo
si
può
migliorare,
anche
grazie
agli
apporti
dei
giocatori
che
calcano
i
campi
esteri.
Sarebbe
andato
lontano,
quello
Zambia,
dicono
i
più,
e
tra
qualche
anno
ce
lo
ritroviamo
ai
vertici
del
calcio
mondiale.
Con
buona
pace
di
europei
e
sudamericani.
Il
futuro
sorride.
Basta
aspettare
e
lavorare,
lavorare
e
aspettare.
E
crederci,
naturalmente.
Ma
il
futuro
dei
Chipolopolo
non
si
rivelerà
così
roseo.
Il
27
aprile
1993,
un
martedì,
un
cargo
militare,
un
Buffalo
DHC-5D,
decolla
dall’aeroporto
di
Libreville,
in
Gabon.
Su
quell’aereo
siedono
18
giocatori
della
nazionale
zambiana
e 12
tra
tecnici,
dirigenti
dello
staff
e
uomini
dell’equipaggio.
Sono
diretti
a
Dakar,
Senegal,
dove
è in
programma
la
partita
contro
la
nazionale
locale
per
le
qualificazioni
ai
mondiali
americani
dell’anno
dopo.
Ma
quel
cargo
non
arriverà
mai
a
destinazione.
Si
inabissa
senza
apparenti
spiegazioni
nelle
acque
al
largo
del
Gabon.
Tutti
morti
i
passeggeri.
Dopo
tensioni
durate
parecchi
anni
tra
Zambia
e
Gabon,
nel
2003
il
ministero
della
difesa
gabonese
ha
chiarito
la
vicenda.
Il
piano
di
volo
del
Buffalo
prevedeva
la
partenza
da
Lusaka,
capitale
zambiana,
tre
soste
per
rifornimento
rispettivamente
nella
Repubblica
del
Congo,
in
Gabon
e in
Costa
d’Avorio
ed
infine
l’arrivo
a
Dakar.
Però,
subito
dopo
il
primo
atterraggio
vennero
riscontrati
alcuni
problemi
tecnici
ai
motori
dell’aereo.
Ciononostante
il
velivolo,
dopo
sommari
controlli,
venne
fatto
decollare.
Pochi
minuti
dopo
la
partenza
un
motore
si
incendiò.
Il
pilota,
stanco
per
un
volo
di
ritorno
dalle
Mauritius
appena
effettuato,
per
un
errore
staccò
il
motore
funzionante
al
posto
di
quello
che
aveva
preso
fuoco.
Fu
così
che
per
alcuni
interminabili
secondi
una
palla
di
fuoco
solcò
il
cielo
gabonese,
andando
a
tramontare
nell’azzurro
dell’Oceano
Atlantico,
poco
lontano
dalle
coste
africane.
I
Chipolopolo
spariscono.
Tra
gli
eroi
di
Seul,
periscono
il
portiere
e
capitano
David
Chabala,
il
secondo
portiere
Richard
Mwanza,
i
difensori
Edmon
Mumba,
Derby
Makinka,
Peter
Mwanza,
i
centrocampisti
Wisdom
Chansa
ed
Eston
Mulenga.
Sopravvissuti
alla
tragedia,
autentici
morti
viventi,
furono
il
goleador
Kalusha
Bwalya,
il
fratello
Joel,
Johson
Bwalya
e
Charles
Musonda.
Giocavano
tutti
all’estero
(Kalusha
in
Olanda,
nel
PSV
Eindhoven;
Johnson
in
Svizzera,
nel
Lucerna)
ed
avrebbero
raggiunto
la
nazionale
direttamente
in
Senegal.
Ma a
Dakar
non
arrivò
mai
nessuno.
Son
giovani
e
forti.
Si
può
fermarli
solo
così.
Il
destino
fischiò
in
anticipo
quella
volta.
Ma
non
è
stata
l’unica
volta.
Lasciando
da
parte
i
drammi
personali,
di
singoli
calciatori,
e
limitandosi
a
quelli
collettivi
(non
spingendosi
peraltro
fino
alla
vicenda
del
Grande
Torino
perito
a
Superga,
su
cui
è
abbondantissima
la
letteratura),
un’altra
tragedia
ci
porta
a
trentacinque
anni
prima,
al
1958.
In
Europa
c’è
ancora
il
gelo.
Cinque
anni
prima
è
morto
Stalin.
Nel
febbraio
del
’56
Kruscev,
al
XX
Congresso
del
PCUS,
denuncia
i
crimini
stalinisti,
ma
ciò
non
impedirà
alle
truppe
sovietiche
di
fare
una
capatina
in
Ungheria,
a
fine
ottobre-inizi
novembre,
per
‘ristabilire
l’ordine
socialista
minacciato’.
Nel
frattempo,
un’altra
crisi
internazionale
tiene
con
il
fiato
sospeso
il
mondo:
Suez.
L’anno
successivo,
tra
l’altro,
aveva
visto
la
nascita
di
Carosello,
il 3
febbraio,
l’indipendenza
della
prima
nazione
africana,
il
Ghana,
il 6
marzo,
la
stipula
del
Trattato
di
Roma,
il
24
marzo,
grazie
alla
quale
nascevano
la
CEE
e
l’EURATOM,
il
lancio
dello
Sputnik
1,
il 4
ottobre
(lo
Sputnik
2,
con
a
bordo
la
cagnetta
Laika
decollerà
il 3
novembre),
e
persino
un
colpo
di
stato
anticomunista
a
San
Marino,
il
30
settembre.
In
quello
scorcio
del
1958,
in
Italia
si
discute
della
Legge
Merlin,
in
Francia
su
cosa
fare
dell’Algeria,
in
URSS
su
come
eliminare
Nagy
e
Malater,
in
USA
su
come
rapportarsi
con
Fidel
Castro,
in
Brasile
su
chi
portare
ai
Mondiali
svedesi
di
luglio.
Il 5
febbraio
1958
si
svolge
la
partita
di
ritorno
dei
quarti
di
finale
della
Coppa
dei
Campioni
tra
gli
inglesi
del
Manchester
United,
allenati
da
Matt
Busby
e
per
ciò
chiamati
i
Busby’s
Boys,
e i
campioni
jugoslavi
della
Stella
Rossa
di
Belgrado.
All’andata,
in
Inghilterra,
i
Red
Devils
aveva
vinto
per
2-1.
Al
ritorno,
in
Jugoslavia,
nel
primo
tempo
sono
avanti
per
3-0
grazie
a
una
rete
di
Viollet
ed
una
doppietta
di
Bobby
Charlton.
Evidentemente
sono
rilassati.
Fatto
sta
che,
nella
ripresa,
i
belgradesi
riescono
a
pareggiare:
3-3.
Nulla
di
allarmante.
Il
computo
totale
è di
5-4
per
gli
inglesi.
In
semifinale
troveranno
il
Milan.
Lo
sanno,
non
lo
temono.
Si
sentono
forti.
Sono
forti.
Giovani
e
forti.
L’obiettivo
è la
finale
contro
il
Real
Madrid,
i
campioni
uscenti,
che
in
semifinale
se
la
vedranno
con
gli
ungheresi
del
Vasas
Budapest.
Sono
giovani,
dicevamo.
Matt
Busby
li
ha
cercati
uno
per
uno,
ha
soppesato
i
talenti,
li
ha
plasmati.
E’
uno
che
ne
capisce
di
calcio,
Sir
Matt.
Li
sceglie
giovani,
aitanti,
vogliosi,
ambiziosi.
E
dagli
ottimi
piedi.
Faranno
molta
strada,
si
dice
dappertutto.
E’
una
meraviglia
vedere
i
colpi
di
Charlton,
Pegg
o
Taylor
o le
scorribande
di
Duncan
Edwards,
la
tostaggine
di
Mark
Jones
ed
Eddie
Colman.
Giovanissimi
e
dotatissimi.
Per
tornare
presto
a
Manchester
usano
un
volo
charter,
allora
non
molto
utilizzato.
Si
tratta
di
un
volo
gestito
dalla
British
European
Airways
(BEA)
utilizzando
un
Elizabethan
class
Airspeed
Ambassador
aircraft
G-ALZU
Lord
Burghley.
Già
alla
partenza
c’è
un
piccolo
intoppo:
il
calciatore
John
Berry
dimentica
il
passaporto
e
l’aereo
è
costretto
a
decollare
con
un’ora
di
ritardo.
Deve
fare
scalo
tecnico
per
il
rifornimento
a
Monaco
di
Baviera,
in
Germania
Ovest.
E
fin
lì
ci
arriva.
La
pista
è
ghiacciata,
cumuli
di
neve
si
addensano
qua
e
là.
Il
pilota,
il
capitano
James
Thain,
tenta
per
ben
due
volte
di
decollare,
ma
il
motore
va
in
surriscaldamento.
Niente
da
fare.
Infine,
alle
15,04,
ci
riprova.
L'aereo
non
riesce
a
prendere
quota
e si
schianta
sulla
recinzione
che
circonda
l'aeroporto,
poi
carambola
contro
una
casa,
in
quel
momento
vuota.
Parte
dell'ala
e
mezza
coda
vengono
strappate.
Il
velivolo
prende
fuoco
come
un
cerino.
Il
lato
sinistro
della
cabina
di
pilotaggio
colpisce
un
albero.
Il
lato
destro
della
fusoliera
sventra
un
capanno
di
legno,
all'interno
del
quale
c'è
un
camion
carico
di
pneumatici
e
carburante,
che
esplode
tramutando
il
tutto
in
una
santabarbara.
A
causa
di
un
cumulo
di
neve
e
ghiaccio
incontrato
lungo
la
via
di
fuga,
l’aereo
ha
perso
velocità,
non
riuscendo
a
decollare.
E
neanche
a
frenare,
vista
la
pista
ghiacciata.
Nel
disastro
perdono
la
vita
otto
giovani
promesse
del
calcio
mondiale.
Sette
sul
colpo:
i
terzini
Roger
Byrne
e
Geoff
Bent
, il
mediano
Eddie
Colman,
il
centromediano
Mark
Jones,
gli
attaccanti
Billy
Whelan,
Tommy
Taylor
e
David
Pegg.
Muoiono
anche
tre
membri
dello
staff
del
Manchester
(Walter
Crickmer,
Bert
Whalley
e
Tom
Curry)
,
otto
giornalisti,
tra
i
quali
Don
Davie
del
Manchester
Guardian,
Archie
Ledbrooke
del
Daily
Mirror
e
Frank
Swift,
che,
oltre
ad
essere
giornalista
del
News
of
the
World,
è
anche
preparatore
dei
portieri
dell’Inghilterra
e
del
Manchester
City
e
quattro
tra
membri
dell’equipaggio
e
passeggeri
(perde
la
vita
anche
il
tifoso
e
amico
personale
di
Matt
Busby,
Willie
Satinoff).
Se
la
cavano
gli
altri.
Da
Johnny
Berry
(morto
poi
nel
1994)
a
Bobby
Charlton,
da
Jackie
Blanchflower
(morto
nel
’98)
a
Dennis
Violett
(andato
nel
’99).
Si
salvano
anche
Matt
Busby
e il
pilota
James
Thain.
Viene
estratto
ancora
dal
groviglio
infuocato
delle
lamiere
Duncan
Edwards.
Ha
lesioni
spaventose
alle
gambe
e
gravissimi
danni
interni.
I
medici
lo
tengono
in
vita
per
due
settimane
con
l’aiuto
di
un
rene
artificiale.
Il
fisico
di
Duncan
lotta
fino
al
21
febbraio,
poi
si
arrende.
Edwards
è la
grande
promessa
del
calcio
inglese.,
Nato
a
Dudley,
nelle
Midlands,
nel
1936,
era
stato
fatto
seguire
da
Matt
Busby
da
quando
aveva
14
anni.
14
anni,
sì,
ma
giocava
da
veterano.
Lo
aveva
convocato
a
Manchester
e il
giorno
del
suo
sedicesimo
compleanno,
Duncan
aveva
firmato
per
lo
United.
Il 4
aprile
dell’anno
dopo
aveva
esordito
contro
il
Cardiff
City,
diventando
il
più
giovane
calciatore
ad
esordire
nel
campionato
inglese.
Edwards
era
un
centrocampista
di
incredibile
qualità
e
potenza.
Oggi
si
direbbe
universale.
Aveva
giocato
già
151
volte
con
l’United,
segnando
20
gol.
Nel
museo
di
Dudley
ci
sono
i 18
caps
(cappellini)
a
indicare
altrettante
presenze
in
nazionale,
con
5
gol.
La
leggenda
vuole
che
sia
stato
il
più
grande
di
tutti
i
tempi.
Secondo
Bobby
Charlton,
suo
compagno
di
squadra
e
sopravvissuto
alla
tragedia
di
Monaco,
un
solo
calciatore
lo
aveva
ha
fatto
sentire
inferiore:
Duncan
Edwards.
“Se
dovessi
giocare
per
la
mia
vita
e
potessi
prendere
un
uomo
con
me –
disse
una
volta
-
questi
sarebbe
lui”.
Edwards
aveva
ventuno
anni,
Charlton
venti,
Duncan
con
la
maglia
numero
6,
andava
per
ogni
dove
del
campo,
Bobby
con
il
9,
aveva
il
passo
elegante,
il
colpo
del
goleador
di
razza.
Leggenda
di
Duncan
Edwards,
storia
di
Charlton.
Pallone
d’Oro
nel
1966,
anno
del
titolo
mondiale
inglese,
una
cappelliera
piena
di
759
caps
e
249
gol
con
i
Red
Devils.
E in
nazionale
106
partite
con
49
gol,
uno
anche
all’Italia
nello
storico,per
gli
azzurri,
2 a
2 di
Wembley,
il 5
giugno
del
1959.
Fino
a
quei
giorni
lo
United
era
un
club
che
si
era
rialzato
lentamente
dalla
crisi.
Nel
dopoguerra
era
finito
persino
in
seconda
divisione.
Ma
con
l’arrivo
dello
scozzese
Matt
Busby
e
una
politica
che
puntava
sui
giovani,
aveva
rivisto
la
luce.
Aveva
vinto
la
coppa
d’Inghilterra
e
per
tre
volte
il
campionato,
coronando
il
tutto
con
la
partecipazione
alla
Coppa
dei
Campioni
nella
stagione
’57-58.
Le
partite
erano
state
disputate
sul
campo
del
Manchester
City,
l’altra
squadra
della
città,
la
quale
si
era
fatta
avanti
per
ospitare
(a
pagamento)
lo
United:
l’Old
Trafford
era
ancora
imparaticabile
a
causa
dei
bombardamenti
tedeschi
della
seconda
guerra
mondiale.
In
tal
modo,
la
tragedia
bavarese
unì,
in
un
certo
senso,
le
due
tifoserie,
benché
non
mancarono
idioti
che,
in
alcuni
pub
di
Manchester,
accolsero
con
gioia
cinica
la
morte
dei
rivali.
Ma
bisogna
andare
avanti.
La
prima
partita
dopo
il
disastro
è
quella
in
calendario
con
lo
Sheffield
Wednesday.
Finisce
3-0
per
i
Red
Devils.
Sul
programma
ufficiale
della
partita
lo
spazio
delle
fotografie
di
ogni
calciatore
era
stato
lasciato
in
bianco,
nessuno
sapeva
chi,
Jimmy
Murphy,
vice
di
Busby,
avrebbe
potuto
schierare.
La
batosta
si
fa
sentire.
Lentamente
la
squadra
perde
terreno,
scivola
in
basso,
per
finire
il
campionato
al
nono
posto.
Non
solo,
perde
la
finale
della
coppa
d’Inghilterra
per
2-0
contro
il
Bolton
e
viene
eliminata
dal
Milan,
prima
squadra
europea
ad
affrontare
gli
inglesi
dopo
la
tragedia,
nella
semifinale
dei
Campioni,
ritardata
a
maggio.
All’andata
il
Manchester
si
comporta
anche
bene,
vincendo
per
2-1,
ma ,
al
ritorno,
i
rossoneri
lo
travolgono
per
4-0.
Dieci
anni
dopo,
Matt
Busby
avrebbe
vinto
la
sua
più
grande
sfida,
lo
United
di
Dennis
Law
e
George
Best
avrebbe
conquistato
la
Coppa
dei
Campioni
nella
finale
contro
il
Benfica.
Sul
prato
di
Wembley
corrono
ancora
Bobby
Charlton
e
Bill
Foulkes.
Corrono,
pensando
agli
amici
caduti
a
Monaco.
A
quelli,
che,
amati
dagli
dèi
–
come
direbbero
gli
antichi
–
sono
stati
convocati
a
giocare
una
partita
eterna
nella
leggenda.
Una
partita
pensata
solo
per
i
più
grandi,
in
cui
trovano
posto
Valerio
Bacigalupo
ed
Edmon
Mumba,
Andrea
Fortunato
e
Renato
Curi,
Valentino
Mazzola
e e
Wisdom
Chansa,
Ezio
Loik
e
David
Pegg,
Antonio
Puerta
e
Duncan
Edwards,
Dani
Jarque
ed
Eston
Mulenga,
Miklos
Feher
e
Marc
Vivien
Foe.
Una
bella
partita,
di
sicuro.
Almeno,
stando
alle
formazioni
sulla
carta.
Ché
i
giocatori
sono
forti,
geniali
persino.
E si
sa,
il
diavolo
certi
brutti
scherzi
li
fa
solo
ai
geni;
gli
imbecilli,
solitamente,
li
trascura.

|
|
|
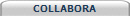
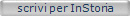
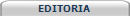
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
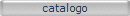
.
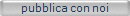
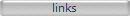
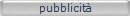
InStoria.it




|