|
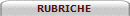

.

.

.

.
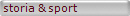
.
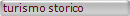
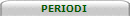
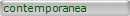
.

.
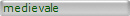
.


.
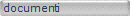
.
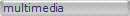
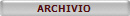

|
N. 19 -
Luglio 2009
(L)
IL CREPUSCOLO DEI VINTI
CRONACA DELLA SCONFITTA DELL'IMPERO INCA
di Cristiano Zepponi
“La
tribù
predatoria
degli
Incas
si
espanse”
scrisse
Richard
Schaedel
“attraverso
una
rapida
incorporazione
di
successive
popolazioni
vinte,
in
un
modello
cumulativo
di
aggressioni
espansive,
subito
seguite
da
ricompense
riparatrici”.
L’impero
quechua
si
estendeva
così,
attorno
al
1525,
per
quattromila
chilometri
lungo
la
costa
Pacifica
e a
ridosso
delle
Ande,
dalla
frontiera
dell’attuale
Colombia
fino
al
nord
del
Cile
e
dell’Argentina.
Occupava
quasi
un
milione
di
chilometri
quadrati
(il
Tahauantinsuyu,
“la
terra
dei
quattro
quadranti
o
punti
cardinali
del
mondo“,
divisa
nelle
quattro
regioni
di
Antisuyu,
Collasuyu,
Cuntisuyu
e
Chinchasuyu)
celebrati
e
rinomati
per
la
proverbiale
ricchezza
elargita
da
Pacha
Mama,
la
Madre
Terra,
ed
organizzati
attraverso
una
rigida
amministrazione
politica
ed
economica
dei
settori
da
dieci,
cento,
mille
e
dieci
mila
abitanti
in
cui
l’Impero
era
diviso,
ognuno
dei
quali
a
carico
di
persone
nominate
dall'Inca,
il
sovrano;
al
welfare
del
popolo
minuto,
frattanto,
provvedeva
l’ “ayllu”,
il
gestore
dell’annona,
che
amministrava
le
derrate
e i
prodotti
della
terra
considerati
di
proprietà
collettiva
in
cambio
di
una
corvée
gratuita
nelle
terre
destinate
al
patriziato
regale
e
alle
gerarchie
sacerdotali.
L'Impero
consisteva
dunque
in
una
teocrazia
dominata
dall'Inca,
adorato
come
dio
vivente:
ma
vigeva
comunque
un
sistema
di
potere
duale,
per
cui
tutte
le
autorità
apparivano
sempre
accoppiate;
per
esempio,
vigeva
il
sistema
dei
due
Inca
che
governavano
simultaneamente,
uno
dei
quali
(l’
“hanan”)
ad
un
livello
superiore
ed
uno
(l’
“hurin”)
sottoposto.
Lo
stesso
accadeva
alle
autorità
locali:
al
livello
degli
“ayllu”,
le
massime
autorità
erano
i
curacao,
anch’essi
divisi
in
hanan
ed
hurin.
Le
famiglie
degli
Inca
supremi
scomparsi,
che
formavano
gruppi
di
parentela
conosciuti
come
panacas
(o "
famiglia
nobile"),
erano
incaricate
di
mantenerne
il
ricordo,
di
realizzare
cerimonie
in
loro
nome
e di
curarne
beni
ed
alleanze,
ed
in
più
detenevano
grande
influenza
nella
nomina
dei
successori.
Scendendo
nei
gradini
gerarchici,
si
trovavano
i
capi
dei
popoli
conquistati
che,
in
caso
di
sottomissione,
ricevevano
un’educazione
quechua
oltre
ad
una
serie
di
privilegi.
La
gente
comune
era
raggruppata
nella
categoria
degli
“hatun
runa”,
contadini
membri
di
un “ayllu”,
mentre
alcuni
gruppi
(conosciuti
come
“mitimaes”
o “mitmaqunas”)
potevano
uscire
temporaneamente
da
questa
condizione
ed
essere
trasferiti
lontani
dal
luogo
d'origine.
L’ultimo
scalino
della
piramide
sociale
era
occupato
dagli
“yanoconas”,
separati
dagli
“ayllu”
per
svolgere
alla
diretta
dipendenza
dell’Inca
alcuni
lavori
specializzati.
Il
dio
supremo
degli
Inca
era
Huiracocha,
creatore
e
signore
di
tutti
gli
essere
viventi,
attorniato
dal
dio
della
creazione
e
della
vita,
Pachacamac,
del
Sole,
Inti
(non
si
dimentichi
che
gli
Inca
si
erano
assegnati
il
titolo
di
“Figli
del
Sole”),
e
dalle
dee
della
Luna,
Mamaquilla,
della
Terra
Pachamama,
del
fulmine
e
della
pioggia,
Ilapa.
Le
cerimonie
e i
rituali
in
loro
onore
erano
numerosi
e
frequentemente
complessi,
oltre
ad
essere
basicamente
relazionati
con
questioni
agricole
e di
salute,
ed
in
particolare
con
la
coltivazione,
la
raccolta
e la
guarigione
delle
più
diverse
malattie.
In
onore
del
dio
Inti
i
quechua
celebravano
la
“Intip
Raymi”,
la
danza
del
Sole,
due
volte
l’anno:
a
giugno
in
occasione
del
solstizio
d’inverno,
a
dicembre
di
quello
estivo,
producendo
il
fuoco
sacro
che
sarebbe
servito
per
un
intero
anno
per
mezzo
delle
proprietà
di
specchi
ustori
d’argento
o
dello
sfregamento
di
due
pezzi
di
legno.
Un
collegio
di
vergini
sacre,
dette
“spose
del
Sole”,
custodiva
detto
fuoco,
sotto
la
guida
del
“Villa
umu”
(“colui
che
parla
col
dio”),
attenendosi
ad
una
rigida
castità
(la
trasgressione
veniva
punita
mediante
la
sepoltura
da
viva
della
fanciulla,
e
gli
eventuali
complici
del
sacrilegio
erano
messi
a
morte
sulla
pietra
del
sacrificio
“intihuatana”,
l’altare
del
dio
Inti,
dove
s’innalzava
anche
lo
gnomone
per
i
calcoli
astronomici
legati
al
ciclo
solare).
Era,
quella
comminata
ai
responsabili
del
sacrilegio
con
le
spose
del
Sole,
l’unico
caso
di
esecuzione
capitale,
perché,
a
differenza
di
Maya
e
Aztechi,
gli
Inca
non
organizzavano
normalmente
sacrifici
umani
a
scopo
religioso:
alle
loro
divinità
offrivano
normalmente
cibi
e
bevande,
e
raramente
immolavano
lama
e
volatili.
I
quechua
coltivavano
soprattutto
mais
e
patate,
e
poi
il
peperoncino,
la
chirimoya,
la
papaia,
il
pomodoro
e i
fagioli,
ignoravano
l’uso
del
ferro,
della
volta
e
della
ruota
e
usavano
la
forma
di
scrittura
“Quipus”,
un
sistema
di
fili
annodati
che
ancora
oggi
aspetta
di
essere
decifrato.
Templi
ciclopici
si
innalzavano
maestosi,
ed
enormi
edifici
di
mattoni,
come
il
Tempio
del
Sole
a
Cuzco,
venivano
incastrati
con
cura
senza
calcina
e
con
una
minima
attrezzatura.
Terrazzamenti
e
pendii
opportunamente
trattati
per
la
coltivazione,
canali
d'irrigazione,
ponti
sospesi
a
base
di
corde
intrecciate
(alcune
di
100
metri
di
lunghezza),
miniere
e
luoghi
per
la
lavorazione
dei
metalli
coloravano
il
paesaggio,
e
umanizzavano
la
natura
negli
spazi
tra
le
fortezze
strategicamente
localizzate,
come
Machu
Picchu,
Ollantaytambo
e
Sacsayhuaman
presso
Cuzco.
Una
complessa
rete
di
camminamenti
lastricati
collegava
le
varie
parti
dell’Impero
mentre
messaggeri
addestrati
- i
chasquis
-,
operando
a
staffetta,
assicuravano
le
comunicazioni;
allo
stesso
tempo,
forme
artistiche
e
artigianali
di
rara
maestria
e
bellezza
si
elaboravano
di
continuo:
"a
Tiahuanaco,
ad
esempio,
ci
sono
pietre
lunghe
12
metri,
larghe
6 e
alte
2
metri.
A
Cuzco
ancora
più
grandi.
La
cosa
più
incredibile
è
che
pur
essendo
di
forma
irregolare
sono
incastrate
in
modo
così
bene
che
anche
senza
cemento
neppure
la
punta
di
un
coltello
riesce
a
penetrare
le
unioni.."
(Garcilaso
de
la
Vega
Inca
"Comentarios
Reales"
Biblioteca
di
Cultura
Peruana
-
Parigi
1938).
La
conservazione
del
patrimonio
storico/culturale,
come
strumento
di
coesione
sociale,
era
inoltre
affidata
alle
cure
dei
khipukamayoq,
i
custodi
dell’
“arte
della
memoria”.
La
pax
incaica
resisteva
grazie
alla
dipendenza
politica
–
senza
tralasciare
la
pratica
delle
punizioni
esemplari
-
oltre
che
all’assistenza
e ai
doni
elargiti
ai
sudditi.
L’impero
non
pretendeva
tributi
eccessivi,
forniva
il
necessario
per
vivere
alle
provincie
improduttive
ed
organizzava
il
tradizionale
criterio
di
autosufficienza
e
reciprocità
delle
popolazioni
andine
conosciuto
come
“mita”,
in
base
al
quale
l'inca
chiedeva
come
tributo
esclusivamente
manodopera,
inviata
poi
a
lavorare
sulla
terra,
modellare
la
ceramica,
costruire
marciapiedi
o
grandi
opere
architettoniche;
in
cambio,
ricompensava
questi
servizi
organizzando
rituali,
mantenendo
i
camminamenti,
distribuendo
i
beni
in
caso
di
necessità
o
nelle
feste.
Lo
Stato
era
florido,
organizzato
e
vitale,
quando
(intorno
al
1525)
morì
l’inca
Huayna
Càpac;
negli
ultimi
anni
del
suo
regno,
come
da
tradizione,
si
verificarono
“terremoti
di
violenza
inusitata,
il
fulmine
colpisce
il
palazzo
dell’Inca,
comete
solcano
l’aria
(…),
un
condor
solitario
viene
inseguito
da
falchi
mentre
attraversa
il
cielo
di
Cuzco
e si
abbatte
sulla
piazza
della
capitale
(…).
Uno
spettacolo
ancor
più
sinistro
colpisce
gli
abitanti
della
città:
in
una
notte
chiarissima,
la
luna
appare
circondata
da
un
duplice
alone:
color
del
sangue,
color
cupo
e
color
grigio
fumo.
Un
indovino
interpreta:
l’alone
color
del
sangue
indica
una
guerra
crudele,
che
avrebbe
dilaniato
i
discendenti
di
Huayna
Càpac;
il
colore
oscuro
rappresenta
la
rovina
della
religione
dell’Impero
incaico,
ormai
incombente;
il
color
fumo
simbolizza
che
presto
tutto
si
convertirà
in
fumo”.
Lo
stesso
Inca,
dicono
alcuni,
suggerì
di
sottomettersi
agli
stranieri,
il
cui
arrivo
era
stato
previsto
da
una
profezia
risalente
al
periodo
dell’ottavo
sovrano.
La
successione
al
trono
di
Càpac
non
fu
rapida
né
indolore:
una
guerra
mortale
si
scatenò
infatti
tra
Huàscar
(il
successore
legittimo)
e
Atahualpa,
stabilitosi
a
Quito.
Fu
per
questo
che
Huàscar
uscì
da
Cuzco
per
andare
incontro
all’avversario,
e
costringerlo
a
battersi.
Atahualpa,
però,
trionfò
a
Riobamba,
e
continuò
a
tallonare
l’avversario
fino
alla
sua
definitiva
sconfitta
sul
campo
di
Cotabamba,
nei
pressi
della
capitale,
dove
Huàscar
stesso
fu
catturato.
Nel
frattempo,
a
Panamà,
Francisco
Pizarro,
Diego
de
Almagro
e
l’ecclesiastico
Hernando
de
Luque
avevano
organizzato
alcune
spedizioni
alla
ricerca
dell’Impero,
la
cui
fama
doveva
essere
giunta
fino
ai
domìni
spagnoli;
nella
prima,
verso
la
fine
del
1524,
Pizarro
e
Almagro
esplorarono
il
fiume
Virù,
mentre
nella
seconda,
facilitata
dall’ausilio
della
guida
Bartolomè
Ruiz,
venne
scoperta
l’Isola
del
Gallo.
Qui,
Ruiz,
oltre
a
catturare
alcuni
prigionieri
(e
futuri
interpreti)
potè
osservare
attraenti
scambi
di
oro
e
tessuti.
Almagro
ritornò
dunque
a
Panamà,
per
riferire
quanto
visto;
e in
quel
frangente
la
personalità
di
Pizarro
si
impose
sugli
spagnoli
giunti
nell’Isola
del
Gallo.
Li
trascinò
allora
ad
esplorare
il
golfo
di
Guayaquil,
e
poi
lungo
la
costa
verso
sud,
fino
a
Tùmbez,
dove
le
mura
dei
templi
erano
ricoperte
da
enormi
placche
d’oro.
Lungo
il
percorso,
ottenne
informazioni
precise
sulla
posizione,
ed i
contrasti
che
agitavano
lo
Stato
incarico.
Ritornò
a
Panamà,
e da
qui
(nel
1528)
raggiunse
la
Spagna
per
ottenere
direttamente
dall’imperatore
Carlo
V la
benedizione
all’impresa;
nel
luglio
del
1529,
finalmente,
il
sovrano
firmò
le
“Capitolazioni”,
incaricandolo
di
fatto
di
“continuare
la
scoperta,
la
conquista
e il
popolamento
della
detta
provincia
di
Perù”.
L’anno
seguente
fece
ritorno
a
Panamà,
accompagnato
dai
fratelli
Hernando,
Gonzalo
e
Juan.
Aveva
ottenuto
il
comando,
scalzando
Almagro.
Il
13
maggio
1532
tre
imbarcazioni
scaricarono
quindi
presso
Tùmbez
duecento
uomini
circa,
di
cui
settantadue
a
cavallo
–
animale
sconosciuto
ai
locali
– e
soprattutto
20
cannoni.
Stretti
nelle
loro
armature
di
acciaio,
dotati
di
archibugi
e
spade
temprate,
i
“portatori
di
tuono”
entrarono
quindi
nella
città
deserta.
Atahualpa,
che
si
trovava
a
Cajamarca,
fu
subito
informato
del
loro
arrivo;
immediatamente
rinviò
la
partenza
per
Cuzco
ma
credette,
come
prevedibile,
ad
un
ritorno
degli
dèi,
ad
un
ritorno
di
Huiracocha.
Inviò
osservatori
e
messaggeri,
e
questi
riferirono
delle
violenze,
dell’avanzata
degli
uomini
di
Castiglia
verso
le
montagne,
e
verso
Cajamarca
stessa,
oltre
che
della
fondazione
di
una
città,
San
Miguel
(“di
giorno
e di
notte
in
sogno
dicevano
tutti:
le
Indie,
le
Indie,
oro,
argento
del
Pirù..”
scrisse
Guamàn
Poma).
Curioso
e
preoccupato,
nonostante
fosse
avvenuto
il
consueto
scambio
di
doni,
attese
gli
invasori
nella
piana
adiacente
la
città,
con
i
suoi
quarantamila
guerrieri,
le
sue
tende
ed i
suoi
falò.
Per
questo,
quando
gli
spagnoli
entrarono
in
città,
il
15
novembre
1932,
la
trovarono
ancora
una
volta
deserta.
A
quel
punto
Atahualpa
abbandonò
ogni
riserva,
e
decise
di
incontrarsi
con
loro,
dimentico
delle
antiche
profezie,
che
volevano
la
rovina
provenire
dalla
schiuma
del
mare
a
Oriente,
su
vascelli
con
grandi
ali
candide.
Difeso
da
una
guardia
di
nobili
–
gli
orejone
-,
assiso
sulla
portantina,
si
fece
trasportare
verso
la
piazza
di
Cajamarca:
ma
qui
lo
aspettavano
gli
spagnoli,
appostati
nella
zona
per
catturare
il
tredicesimo
Intip
Churin,
il
Figlio
del
Sole,
con
un’imboscata.
Le
fonti
di
entrambe
le
parti
(Francisco
de
Jerez,
Poma
de
Ayala)
raccontano
che
Pizarro
parlò
con
l’Inca
servendosi
di
un’interprete,
Felipillo,
si
presentò
come
ambasciatore
di
un
gran
signore,
e
chiese
amicizia.
L’Inca
rispose
duramente,
e
affermò
di
credere
alla
grandezza
del
signore
che
aveva
inviato
Pizarro,
“ma
che
non
era
tenuto
a
fare
amicizia,
giacchè
anche
lui
era
un
grande
signore
nel
suo
regno”.
Si
avvicinò
allora
Fra
Vicente
de
Valverde,
con
una
croce
nella
mano
destra
ed
un
breviario
nella
sinistra.
Gli
ordinò
di
adorare
Dio,
la
croce,
il
Vangelo,
“perché
tutto
il
resto
era
cosa
da
niente”.
Atahualpa
si
irrigidì,
e
rispose
che
“non
doveva
adorare
nessuno
se
non
il
Sole
che
non
muore
mai”,
e
gli
altri
dèi
della
sua
legge;
e
chiese
al
frate
chi
gli
aveva
insegnato
la
dottrina
che
andava
predicando.
Questi
rispose
chiamando
in
causa
il
Vangelo;
e
l’Inca,
incuriosito,
ne
chiese
la
copia,
“dallo
a
me,
il
libro”,
disse,
“perché
me
lo
dica”.
Ne
sfogliò
allora
alcune
pagine;
dopo
di
che,
aggiunse:
“Non
me
lo
dice,
né
mi
parla,
a
me,
detto
libro”,
e
concluse
la
frase
lasciandolo
cadere
di
mano,
maestosamente.
“A
me,
cavalieri,
contro
questi
indios
gentili
(che)
sono
contro
la
nostra
fede!”,
gridò
allora
l’uomo
di
Chiesa,
lanciando
il
segnale
dell’attacco.
La
cavalleria
caricò
la
scorta,
che
disponeva
solo
di
zagaglie
e
lance
di
rame
e
legno,
e si
riparava
con
elmetti
di
stoffa
e
piume,
prima
che
gli
archibugi
spazzassero
via
quel
che
ne
restava,
e
“morì
tanta
gente
tra
gli
indios
che
è
possibile
contare”;
nella
confusione
della
mischia
l’incauto
Atahualpa
fu
fatto
prigioniero,
secondo
le
fonti,
“sul
suo
stesso
trono”.
Subito
dopo
lo
scontro
l’Inca,
conscio
della
rapace
avidità
degli
avversari,
offrì
di
pagare
un
riscatto
in
oro
che
arrivasse
a
riempire
la
stanza
che
gli
faceva
da
prigione,
dopo
aver
dato
ordine
di
uccidere
il
fratello
Huàscar.
L’oro
arrivò
dunque
da
ogni
angolo
dello
Stato
incarico,
e
riempì
la
camera
fino
al
livello
convenuto;
ciò
nonostante,
con
freddezza,
Pizarro
preferì
disfarsi
del
suo
avversario,
e lo
accusò
dell’uccisione
di
Huàscar,
di
idolatria,
di
incesto
con
la
sorella,
e di
altri
crimini.
Venne
dunque
regolarmente
battezzato,
evitando
almeno
di
spirare
sul
rogo,
e
poi
giustiziato,
il
29
agosto
dell’anno
1533,
con
il
supplizio
della
garrote.
“Nella
città
di
Cajamarca
finì
la
sua
vita”.
L’avvenimento
sembrò
segnare
la
fine
dell’Impero:
l’una
dopo
l’altra
caddero
le
sontuose
città,
i
santuari
rivestiti
d’oro,
i
grandi
palazzi
del
potere;
il
15
novembre
fu
presa
Cuzco,
e
poi
lo
stesso
accadde
a
Quito,
Tambu
Machay,
Sacsahuaman,
dalle
possenti
mura
ciclopiche.
Si
salvò
però
Machu
Picchu,
osservatorio
e
tempio
solare,
sito
tra
vette
inaccessibili.
“Gli
spagnoli
si
sparsero
dovunque
nel
territorio
del
regno,
a
due
a
due,
e
alcuni
anche
da
soli
(…)
ciascuno
in
cerca
del
proprio
vantaggio
e si
arrangiava
facendo
agli
indios
e
molto
male
e
molto
danno,
col
chiedere
oro
e
argento,
col
portare
via
i
vestiti
e il
cibo”.
Ma
come
era
avvenuto
in
Messico
dieci
anni
prima
con
Montezuma,
la
cui
efferata
soppressione
da
parte
di
Cortes
aveva
scatenato
la
famigerata
vendetta,
culminata
nella
rivolta
indigena
della
“noche
triste”,
anche
l’uccisione
disumana
e
fraudolenta
dell’ultimo
sovrano
Atahualpa
diede
avvio
a
una
nemesi
inarrestabile
ai
danni
degli
uomini
di
Castiglia.
Nel
frattempo,
“per
amore
della
ricchezza,
l’Imperatore
mandò
governatori
e
presidenti
di
tribunale
e
vescovi
e
sacerdoti
e
frti
e
spagnoli
e
signore.
Bastava
dire
Pirù
e
ancora
Pirù”.
Agli
inizi
del
1534,
comunque,
si
scatenarono
le
prime
lotte
interne
al
gruppo
dei
vincitori,
quando
Pedro
de
Alvarado,
protagonista
della
conquista
del
Messico
e
del
Guatemala,
arrivò
da
nord
attratto
dalla
possibilità
di
partecipare
alla
spartizione
del
bottino;
ma
al
nord
tornò,
convinto
dall’eloquenza
di
Almagro
e da
un
probabile
(ricco)
risarcimento.
L’anno
seguente,
per
pacificare
i
quechua,
gli
spagnoli
incoronarono
come
Inca
Manco
II,
fratellastro
di
Atahualpa;
ed
in
più
fondarono
la
Città
dei
Re,
Lima,
nuova
capitale
del
Perù.
Ma
Manco
II
si
ribellò
ben
presto
alle
pretese,
ed
alle
violenze
dei
conquistatori,
ed
insieme
a
lui
prese
le
armi
il
popolo
intero,
da
ogni
parte,
ed
in
particolare
a
Lima
e
Cuzco,
attaccate
in
forze.
“Si
ribellò
contro
di
loro
per
i
maltrattamenti
e
gli
scherni
con
cui
svillaneggiavano
l’Inca
e
gli
altri
signori
di
questo
regno.
Davanti
ai
loro
occhi
prendevano
le
loro
donne
e
figlie
e
donzelle,
con
cattiveria
e
scarso
timor
di
Dio
e
della
giustizia;
e
perché
avevano
subito
molti
altri
torti”.
Per
miracolo
gli
uomini
di
Castiglia
mantennero
il
controllo
della
regione,
nonostante
la
morte
di
Juan
Pizarro;
ma
non
riuscirono
sulle
prime
a
riprendere
possesso
di
un
triangolo
fortificato
(formato
dai
fiumi
Apurìmac,
Urubamba
e
Vilcamajo)
dove
il
sovrano
rivoltoso
aveva
creato
una
sorte
di
piazzaforte,
con
capitale
Vilcabamba.
Da
qui,
sortite
e
assalti
di
sorpresa
molestarono
a
lungo
gli
spagnoli,
mentre
questi
si
massacravano
tra
loro
a
causa
della
mai
sopita
rivalità
tra
Almagro
e
Pizarro,
che
si
trasformò
presto
in
una
faida
familiare.
Nel
giugno
del
1537,
infatti,
Almagro
prese
Cuzco
(ed
insieme
a
questa
catturò
Alonso
ed
Hernando
Pizarro),
prima
di
essere
a
sua
volta
catturato
e
trucidato
dal
vecchio
compagno;
ma
ancora,
Diego,
il
figlio
di
Almagro,
assassinò
Francisco
Pizarro
il
26
giugno
1541.
Intorno
al
1545
morì
Manco
II e
gli
succedette
il
figlio
Sayri
Tùpac,
che
poi,
dieci
anni
più
tardi,
abbandonò
la
fortezza
e si
arrese,
prima
di
morire
avvelenato.
Fu
incoronato
allora
suo
fratello,
Titu
Cusi
Yupanqui,
che
riprese
le
sortite
contro
gli
spagnoli
e
continuò
a
resistere
fino
all’anno
1569
(secondo
le
stime
più
realistiche),
quando
morì
di
polmonite.
Ancora,
gli
succedette
il
fratello
Tùpac
Amaru,
l’ultimo
Inca;
nel
1572
dovette
subire
un
assalto
spagnolo
da
più
direzioni,
e,
costretto
alla
fuga
sul
fiume
Vilcamajo,
fu
raggiunto
e
sommariamente
giudicato
e
giustiziato.
Per
quarant’anni,
i
quechua
avevano
combattuto
contro
quelli
che
avevano
creduto
dèi;
da
quel
momento,
invece,
il
loro
opulento
e
potente
regno
smise
di
esistere.
“Sotto
estraneo
dominio,
cumulati
i
tormenti,
e
distrutti,
perplessi,
sperduti,
negata
la
memoria,
soli;
morta
l’ombra
protettrice,
piangiamo,
e
non
sappiamo
a
chi
o
dove
rivolgerci.
Stiamo
delirando.
Sopporterà
il
tuo
cuore,
Inca,
questa
nostra
errabonda
e
dispersa
vita,
da
pericoli
incontabili
accerchiata,
in
mano
d’altri,
calpestata?
I
tuoi
occhi,
che
come
avventurose
saette
ferivano,
aprili;
le
tue
magnanime
mani
stendile;
e da
questa
visione
rincuorati
salutaci”.
Riferimenti
bibliografici:
Miguel
Leòn-Portilla,
“Il
rovescio
della
conquista”,
Adelphi
1994
Francesca
Cantù,
“Coscienza
d’America”,
Ed.
Associate
2001
Poma
de
Ayala,
Guamàn,
“nueva
corònica
y
Buen
gobierno
(codex
pèruvien
illustrè)”,
ed.
a
cura
di
Paul
Rivet
Apu
Inca
Atawallpaman,
“Elegìa
quechua
anònima,
traducciòn
de
Josè
M.
Arguedas”
“Tragesia
del
fin
de
Atawallpa,
monografìa
y
traducciòn
de
Jesùs
Clara”,
Imprenta
Universitaria
1937

|
|
|
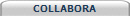
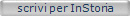
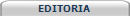
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
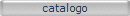
.
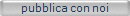
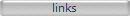
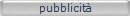
InStoria.it



|