|
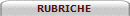

.

.

.

.
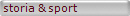
.
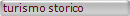
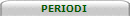
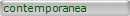
.

.
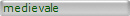
.


.
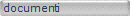
.
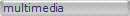
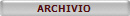

|
N. 24 -
Dicembre 2009
(LV)
IL CREPUSCOLO DEI VINTI
CRONACA
DELLA
SCONFITTA
DELL'IMPERO
AZTECO
di Cristiano Zepponi
Hernàn
Cortès
era
un
hidalgo,
vista
le
sua
(seppur
incerta)
provenienza
dalle
fila
della
piccola
nobiltà
iberica.
Nato
nel
1485
a
Medellìn,
in
Estremadura,
già
a
diciannove
anni
abbandonò
gli
studi
e
preferì
imbarcarsi
per
l’America.
Qui,
prese
parte
alla
conquista
di
Cuba
(1510),
l’ultima
tappa
della
prima
fase
della
Conquista
in
sudamerica,
avviata
appunto
nell’arcipelago
caraibico
(Portorico
era
stata
occupata
realmente
nel
1508,
la
Giamaica
l’anno
seguente).
Negli
stessi
anni,
i
mexica,
come
gli
aztechi
si
autodefinivano,
avevano
raggiunto
l’apogeo
dello
sviluppo,
e
dello
splendore,
sulla
scia
delle
conoscenze
ereditate
dai
toltechi,
ed
in
secondo
luogo
da
altri
popoli
più
antichi,
quali
i
teotihuacani.
Il
“Popolo
del
Sole”,
le
genti
elette
del
dio
della
guerra
Huitzilopochtli,
dominavano
allora
vaste
regioni,
dal
Golfo
del
Messico
al
Pacifico,
e a
sud
fino
all’attuale
Guatemala.
La
nazione
azteca
era
ricca,
potente,
temuta
ed
ammirata
per
la
sua
grande
capitale,
Mèxico-Tenochtitlan,
in
cui
campeggiavano
templi
e
palazzi
decorati
da
pitture
murali,
e
poi
centri
educativi,
dove
codici
e i
libri
istoriati
conservavano
il
ricordo
di
ciò
che
era
stato.
Contava
forse
25
milioni
di
abitanti,
ed
era
ancora
in
espansione.
La
fama
di
cui
godeva
era
nota
a
tutte
le
popolazioni
dell’area,
ed i
racconti
e le
leggende
si
rincorrevano
continuamente,
a
tal
punto
che
presto,
cavalcando
l’onda
delle
voci
e
scavalcando
il
mare
stesso,
approdarono
nella
piccola
isola
di
Cuba,
accolte
con
attenzione
dalle
orecchie
interessate
di
uomini
che
si
preparavano
ad
intraprenderne
la
conquista.
Il
18
febbraio
1519
Hernàn
Cortès
partì
così
dall’isola
caraibica
alla
testa
di
un’armata
lillipuziana
formata
da
undici
navi,
poco
più
di
seicento
uomini,
sedici
cavalli,
trentadue
balestre,
dieci
cannoni
di
bronzo
e
alcuni
pezzi
d’artiglieria
di
calibro
minore.
Lo
accompagnavano,
tra
l’altro,
Pedro
de
Alvarado
(soprannominato
“il
sole”
dagli
aztechi
stessi,
per
la
prestanza
ed
il
biondo
intenso
della
chioma),
che
avrebbe
partecipato
in
futuro
alla
conquista
del
Guatemala
e
del
Perù,
Francisco
de
Montejo,
che
avrebbe
preso
lo
Yucatàn,
Bernal
Dìaz
del
Castello
e
diversi
altri
testimoni
della
storia
di
quell’avventura.
Lo
sbarco
avvenne
sulle
coste
di
Veracruz
un
Venerdì
Santo,
il
22
aprile
1519,
ed
incominciarono
il
cammino
verso
il
centro
del
favoloso
impero.
Passando
lungo
le
coste
dello
Yucatàn
Cortès
raccolse
Jerònimo
de
Aguilar,
che,
reduce
da
un
naufragio
in
zona,
aveva
imparato
perfettamente
la
lingua
maya.
Proseguendo,
di
fronte
alle
foci
del
Grijalva,
catturò
inoltre
venti
schiave
indigene,
una
delle
quali,
Malinche,
parlava
sia
la
lingua
maya
sia
quella
azteca
(il
nàhuatl).
I
due
personaggi
ebbero
in
seguito
grande
importanza
nella
spedizione,
consentendo
a
Cortès
di
farsi
capire
direttamente
dagli
aztechi
(bastava
parlare
in
spagnolo
a
Jerònimo,
che
avrebbe
tradotto
in
maya
alla
donna,
che,
a
sua
volta,
avrebbe
riferito
quanto
desiderato
agli
emissari
aztechi,
incontrati
per
la
prima
volta
nei
dintorni
dell’attuale
Veracruz).
Il
viaggio
si
svolse
senza
particolari
difficoltà;
dopo
i
primi
contatti
con
la
popolazione
di
Cempoala
sulle
coste
del
Golfo,
gli
spagnoli
presero
la
strada
dell’altopiano,
si
allearono
con
i
signori
di
Tlaxcala
e
poi,
giunti
a
Cholula,
massacrarono
la
sua
gente.
Infine,
dopo
aver
valicato
i
vulcani,
l’8
novembre
dell’anno
1519
poterono
contemplare
attoniti
gli
splendori
di
Mèxico-Tenochtitlan,
che
apparvero
mentre
seguivano
la
grande
strada
di
Iztapalapa
che
univa
la
città
alla
sponda
del
lago,
verso
sud.
Il
sovrano
azteco,
Motecuhzoma,
aveva
già
da
tempo
inviato
doni
in
argento
ed
oro
alla
colonna
di
europei.
A
dire
la
verità,
le
cronache
nàhuatl
parlano
di
presagi
negativi
e
prodigi
funesti
manifestatisi
agli
occhi
degli
indigeni,
e
del
loro
sovrano
in
particolare,
a
partire
da
una
decina
d’anni
prima
dell’arrivo
dei
conquistatori.
Nel
1517
(anno
12-Casa
per
gli
antichi
messicani)
una
lingua
di
fuoco
in
cielo
causò
un
terrore
indicibile,
e
grave
confusione;
poi
arse
completamente,
forse
di
fuoco
spontaneo,
la
“casa
di
Huitzilopochtli”;
uno
degli
edifici
del
grande
Tempio
fu
poi
colpito
da
un
fulmine;
e si
udivano
grida
di
donna,
l’acqua
ribolliva,
riflessi
di
uomini
in
avvicinamento
comparivano
d’improvviso,
insieme
a
figure
deformi.
Motecuhzoma,
secondo
le
fonti,
si
mostrava
in
quei
giorni
preoccupato,
e
fantasticava
su
quello
che
sarebbe
successo
in
città;
e
mentre
le
genti
di
Castiglia
chiedevano
di
lui,
della
sua
età
e
del
suo
aspetto,
egli,
preso
dal
terrore
per
quelle
indagini,
meditò
la
fuga,
come
suggerito
dai
consiglieri.
Ma
alfine
decise
di
rimanere:
“Non
fece
altro
che
aspettarli.
Non
fece
altro
che
decidere
questo
nel
suo
cuore,
non
fece
altro
che
rassegnarsi;
dominò
infine
il
proprio
cuore,
si
rinchiuse
in
se
stesso,
si
preparò
a
vedere
ed a
osservare
quello
che
sarebbe
successo”
(Informantès
de
Sahagùn,
‘Còdice
Florentino’,
libro
XII,
cap.
IX).
La
religione
degli
aztechi
era
imperniata,
fondamentalmente,
sull’idea
della
precarietà
dell’ordine
cosmico,
continuamente
minacciato
da
divinità
colleriche
e
disastri
naturali.
Ne
era
esempio
la
figura
stessa
di
Huitzilopochtli,
che
ogni
giorno
doveva
combattere
contro
le
forze
avverse
necessitando,
perciò,
di
continue
offerte
di
sangue
umano
per
alimentarsi.
Già
quattro
volte,
secondo
la
tradizione,
l’umanità
era
perita
a
causa
di
immani
cataclismi,
e
l’angoscia
era
accresciuta
dal
ritorno
periodico
dei
giorni
e
dei
periodi
infausti.
Per
questo,
Motecuhzoma
credette
di
vedere
in
Cortès
la
reincarnazione
di
Quetzalcoatl,
il
“serpente
piumato”,
e
l’accolse
come
si
addice
ad
una
divinità.
“E
questo
era
ciò
che
ci
hanno
lasciato
detto
i
re,
quelli
che
ressero,
quelli
che
governarono
la
tua
città:che
dovevi
insediarti
sul
tuo
seggio,
sul
tuo
trono,
che
dovevi
venire
qui
[…].
Giungi
alla
tua
terra:
vieni
e
riposa;
prendi
possesso
delle
tue
dimore
reali,
dà
refrigerio
al
tuo
corpo.
Siete
giunti
alla
vostra
terra,
Signori!”
(Informantès
de
Sahagùn,
‘Còdice
Florentino’,
libro
XII,
cap.
XVI),
disse
il
sovrano
azteco
a
Cortès.
E
questi
rispose:
“che
Motecuhzoma
abbia
fiducia,
che
non
abbia
timore.
Noi
molto
lo
amiamo.
E il
nostro
cuore
è
oggi
molto
felice”(ibid.).
Purtroppo,
come
oggi
sappiamo,
mentiva.
Appena
stabiliti,
infatti,
gli
uomini
di
Castiglia
trasformarono
il
più
potente
sovrano
del
Centro-America
in
un
prigioniero.
Cortès,
però,
dovette
poi
lasciare
la
città
per
andare
a
combattere
Panfilo
de
Narvàez,
che
aveva
l’ordine,
trasmesso
dal
governatore
di
Cuba
Diego
Velàzquez,
di
togliergli
il
comando.
Alvarado,
“il
sole”,
divenne
quindi
il
comandante
delle
truppe
spagnole
nella
capitale.
Ma
manifestò
subito
i
suoi
veri
intendimenti,
e
nel
modo
più
drammatico.
Approfittando
della
festa
di
Tòxcatl,
in
occasione
della
quale
il
popolo
si
riuniva
nel
recinto
del
tempio
grande,
attaccò
quindi
gli
indigeni
a
tradimento.
“Mentre
si
sta
godendo
la
festa
e il
ballo
è
incominciato,
e
anche
il
canto,
e i
canti
si
allacciano
l’uno
con
l’altro,
e i
canti
sono
come
un
fragore
di
onde,
in
questo
preciso
momento
gli
uomini
di
castiglia
prendono
la
decisione
di
uccidere
la
gente”
(ibid.).
Chiusero
le
uscite,
ed
in
armi
massacrarono
senza
pietà
mentre
la
folla
si
accalcava
verso
le
uscite,
già
bloccate,
ed i
feriti,
orrendamente
mutilati,
ondeggiavano
incerti
alla
ricerca
di
salvezza.
“Il
sangue
dei
guerrieri,
come
acqua
scorreva”
(ibid.).
Ma
gli
aztechi
fuggitivi
avvertirono
i
capitani,
ed i
soldati,
in
tutta
la
città.
Presto,
gli
europei
si
acquartierarono
nelle
case
reali,
e da
lì
cominciarono
a
bersagliare
la
moltitudine,
contando
sull’impatto
del
cannone
e
dell’archibugio.
Mentre
i
padri
e le
madri
alzavano
i
pianti
funebri,
i
cadaveri
dei
caduti
furono
portati
al
Sacro
Patio.
Tra
loro,
c’era
quello
di
Motecuhzoma.
Sopraffatti
dal
numero,
gli
spagnoli
si
ritirarono
nella
notte
del
30
giugno
dell’anno
1520,
la
noche
triste,
verso
Tlaxcala.
Cortès
ebbe
il
dubbio
merito
di
intuire,
subito
dopo
l’avvenimento,
che
per
le
tribù
limitrofe
il
dominio
azteco
era
parimenti
straniero,
come
quello
spagnolo.
Organizzò
allora
i
contrasti,
amplificò
i
dissapori,
riorganizzò
le
sue
forze
e
riuscì
a
portare
dalla
sua
parte
un
gran
numero
di
genti
un
tempo
fedeli
agli
aztechi.
E se
godette
dell’insperato
aiuto
delle
epidemie
che
gli
uomini
bianchi
avevano
inconsapevolmente
trasportato
fin
lì,
“tosse,
pustole
ardenti,
che
bruciano”
(ibid.),
seppe
anche
sfruttare
la
mancanza
di
coesione
nel
campo
avversario.
I
mexica,
infatti,
presero
allora
ad
uccidersi
tra
loro:
tra
gli
altri
caddero
i
due
figli
di
Motecuhzoma,
Axayaca
e
Xoxopehuàloc.
Un
anno
dopo,
gli
spagnoli
tornarono.
Ed
ancora,
gravi
scontri
si
registrarono
nel
campo
azteco.
Il
nuovo
re,
Cuauhtèmoc,
andò
a
stabilirsi
ad
Acacolco,
per
guidare
la
battaglia.
Mentre
le
navi
sbarravano
le
vie
marine,
mentre
i
cannoni
aprivano
il
fuoco
sulla
Porta
dell’Aquila,
chiudendo
ogni
via
di
fuga,
il
popolino
di
Tenochtitlan
si
rifugiò
a
Tlatelolco,
e si
preparò
a
resistere.
I
capi
militari
urlavano
per
le
strade,
incoraggiando
i
difensori
della
città:
“Non
scoraggiatevi,
non
perdetevi
d’animo.
Dove
dobbiamo
andare?
Siamo
messicani,
siamo
tlatelolchi!”.
Rinforzati
da
soldati
indigeni
inviati
soprattutto
dalla
rivale
Tlaxcala,
e
poi
da
Huexotzinco,
Cholula,
Calco,
Acolhuacan,
Cuauhnàhuac,
Xochimilco,
Mizquic,
Cuitlàhuac,
Culhuacan,
i
reparti
spagnoli
bloccarono
la
città,
e la
situazione
degli
assediati
peggiorò
velocemente.
Nonostante
gli
sforzi
di
Cortès,
comunque,
i
messicani
tlatelolchi
si
mantennero
fino
in
fondo
leali
ai
tenochchi,
gli
abitanti
della
capitale,
e
non
li
lasciarono
soli
neanche
nell’ultima
battaglia.
L’assalto
finale
fu
contrastato,
strada
per
strada.
Si
combattè
quattro
giorni
nel
Sacro
Patio,
e
cinque
nel
mercato.
Combatterono
le
donne
azteche,
lanciando
dardi,
e
combatterono
tutti
gli
uomini
rimasti
fedeli,
dietro
le
trincee
di
crani
che
erano
state
erette
in
tre
diversi
punti
della
città.
La
possibilità
di
capitolare
non
fu
neanche
presa
in
considerazione.
Ma
comunque,
quando
cadde
il
tlatelolca,
“la
grande
aquila”
che
guidava
i
soldati
alleati,
la
battaglia
terminò.
"E
tutto
questo
è
successo
a
noi.
Noi
lo
abbiamo
visto,
noi
lo
abbiamo
contemplato:
è da
questa
lamentevole
e
triste
sorte
che
ci
vedemmo
angustiati.
Sulle
strade
giacciono
dardi
spezzati;
i
capelli
sono
sparsi.
Scoperchiate
sono
le
case,
tinte
di
rosso
hanno
le
mura.
Vermi
pullulano
per
strade
e
piazze,
e
sono
le
pareti
macchiate
di
cervelli.
Rosse
sono
le
acque,
come
le
avessero
tinte,
se
le
bevevamo,
erano
acqua
al
salnitro.
Percuotevamo
i
muri
di
creta
nell’ansia
E ci
restava
in
retaggio
un
traliccio
bucato.
Gli
scudi
furono
la
nostra
difesa,
ma
gli
scudi
non
fermano
la
desolazione.
Abbiamo
mangiato
pane
ammuffito,
abbiamo
masticato
gramigna
salnitrosa,
pezzi
di
creta,
lucertole,
topi,
e
terra
fatta
polvere
e
anche
vermi.
Abbiamo
mangiato
la
carne
appena
posta
sul
fuoco.
Quando
era
cotta,
ce
la
portavamo
subito
via,
e se
la
mangiavano
sul
fuoco
stesso.
Ci
hanno
messo
un
prezzo.
Prezzo
del
giovane,
prezzo
del
sacerdote,
del
bambino
e
della
donzella.
Basta:
il
prezzo
del
povero
era
appena
due
pugni
di
mais,
appena
dieci
torte
di
mosche;
il
nostro
prezzo
erano
soltanto
venti
torte
di
gramigna
salnitrosa.
Oro,
giade,
ricche
coperte,
piume
di
quetzal,
tutte
queste
cose,
che
sono
preziose,
non
vennero
valutate
un
bel
nulla.”
(Informantès
de
Sahagùn,
‘Còdice
Florentino’,
libro
XII,
cap.
XX).
Mèxico-Tenochtitlan
cadde
nell’agosto
dell’anno
1521
dell’era
cristiana,
o
3-Casa
per
i
mexica.
Una
cultura
in
pieno
sviluppo,
fieramente
imbevuta
di
attributi
guerrieri,
terminò
improvvisamente
la
propria
parabola,
sconfitta
dalla
superiorità
militare
europea,
dalla
sua
stessa
concezione
“sportiva”
della
guerra
(la
prima
potenza
dell’epoca
non
manifestava
certo
la
stessa
attenzione
dei
messicani
per
la
cattura
dei
prigionieri
vivi,
da
sacrificare
sugli
altari),
e,
soprattutto,
dalla
percezione
che
l’atteso
ritorno
delle
“stagioni
infauste”
fosse
prossimo.
Lo
shock
inflitto
all’orgoglio
di
questo
popolo,
che
solo
qualche
anno
prima
poteva
gloriarsi
del
dominio
di
buona
parte
del
Centro-America,
fu
talmente
intenso
da
scatenare
una
profonda
crisi
d’identità
nei
superstiti.
“Chi
era
stato
un
grande
capitano,
chi
era
stato
un
uomo
virile,
ora
se
ne
fugge
via
portando
con
sé
soltanto
stracci”
(ibid.).
Mentre
i
vincitori
setacciavano
abitazioni
e
templi,
scudi
ed
insegne,
anelli,
gioielli
e
lunule
alla
ricerca
di
oro,
al
pari
di
alcuni
capi
aztechi
speranzosi
di
ingraziarsi
l’invincibile
Cortès,
la
capitale
andò
via
via
spopolandosi,
secondo
le
intenzioni
dei
conquistatori.
L’ultimo
sovrano,
Cuauhtemoctzin,
fu
sottoposto
a
supplizio,
e,
legato
ad
un
palo,
gli
furono
bruciati
i
piedi;
il
sacerdote
che
custodiva
il
tempio
di
Huitzilopochtli
morì
ad
opera
di
soldati
che
volevano
sapere
dove
fossero
nascosti
gli
ornamenti
del
dio;
e le
vie
della
zona
si
riempirono
delle
sagome
dei
vinti,
impiccati
agli
alberi.
Gli
uomini
di
Castiglia,
allora,
presero
a
sparpagliarsi
da
tutte
le
parti
nei
diversi
villaggi,
come
si
era
sparpagliato
il
popolo
messicano:
“le
donne
avevano
la
carne
dei
fianchi
quasi
nuda.
E i
cristiani
frugano
dappertutto.
Aprono
loro
le
gonne,
mettono
loro
le
mani
addosso
da
tutte
le
parti,
orecchie,
seni,
capelli”.
Cortès,
caso
singolare
tra
molti
conquistadores,
oltre
a
vincere
la
guerra,
vinse
anche
la
pace,
e
riuscì
a
mantenere
il
potere
nelle
sue
mani
anche
nella
delicata
fase
di
consolidamento
e
riorganizzazione
del
territorio,
finchè
il
15
ottobre
del
1922
Carlo
V lo
nominò
governatore
e
capitano
supremo
della
Nuova
Spagna,
di
lì a
poco
divenuta
vicereame.
Ad
Amàxac
invece
si
ritrovarono
i
superstiti
tlatelolchi,
consci
come
gli
altri
che
da
quel
momento
il
popolo
messicano
avrebbe
dovuto
temere
i
desideri
di
un
padrone,
e
incapaci
di
vedersi
sconfitti:
“Ormai
non
avevamo
più
scudi,
ormai
non
avevamo
più
clave;
e
non
avevamo
niente
da
mangiare,
e
non
mangiammo
niente.
E
per
tutta
la
notte
su
noi
cadde
la
pioggia”.

|
|
|
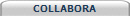
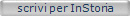
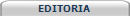
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
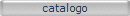
.
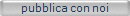
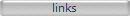
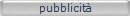
InStoria.it



|