|
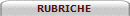

.

.

.

.
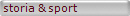
.
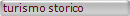
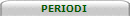
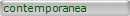
.

.
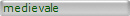
.


.
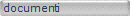
.
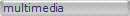
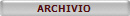

|
N. 22 - Ottobre 2009
(LIII)
La bandiera sventolante sul Monte degli UlivI
la capitale indivisibile
di Lawrence M.F. Sudbury
Sul
Monte
degli
Ulivi,
proprio
di
fronte
alla
Cupola
della
Roccia
di
Gerusalemme,
c’è
una
bandiera,
grande,
molto
grande,
certamente
più
di
cinque
metri
per
tre:
la
bandiera
d’Israele,
naturalmente.
Segna,
come
su
tutte
le
colline
intorno
alla
città,
il
possesso
statale
di
queste
alture
conquistate
nel
1967,
data
dell’unificazione
di
Gerusalemme,
a
poco
meno
di
vent’anni
dalla
nascita
dello
Stato
ebraico.
Mahamud
ha
66
anni
e da
sempre
vive
sul
Monte
degli
Ulivi.
Ogni
mattina
si
alza,
apre
il
suo
chiosco
di
kabap
e
falafel
davanti
alla
bandiera,
ma
non
solleva
mai
lo
sguardo:
per
quanto
lo
riguarda,
quel
pezzo
di
tela
è
solo
il
simbolo
dell’occupazione
iniziata
con
la
Guerra
dei
Sei
Giorni,
al
termine
della
quale
lui,
nato
Palestinese
in
Giordania,
si è
trovato
a
vivere
sotto
il
governo
d’Israele.
Come
lui,
nessuno
sul
Monte
degli
Ulivi
guarda
mai
quella
bandiera
e la
ragione
è
semplice:
qui
nessuno,
assolutamente
nessuno
è
Ebreo
e
nessuno,
assolutamente
nessuno
si
sente
Israeliano.
Forse
il
95%
degli
abitanti
del
Monte
sono
Mussulmani
Palestinesi
che
accorrono
cinque
volte
al
giorno
(o
quattro,
perché
molti
confessano
di
non
farcela
proprio
a
partecipare
alla
preghiera
della
mattina
presto)
al
richiamo
del
Muezzin
della
piccola
Moschea
locale,
costruita
su
quello
che
i
Cristiani
considerano
il
luogo
dall’Assunzione,
mentre
il
restante
5% è
formata
da
membri
di
quella
piccola
minoranza
di
Cristiani
(circa
l’1%
di
tutta
la
popolazione
d’Israele)
che
si
riconosce
in
una
delle
13
Denominazioni
ufficialmente
accettate
dal
governo
ma
che,
ed è
quello
che
conta
qui,
si
riconosce
anche
fieramente
come
palestinese.
No,
qui
nessuno
si
può
o si
potrà
mai
sentire
israeliano:
i
soldati
con
le
kippot
qui,
a
differenza
di
molte
altre
zone
della
pattugliatissima
Città
Vecchia,
passano
raramente
e
quando
passano
è
sempre
cattivo
segno,
segno
che
qualche
cugino
o
fratello
o
cognato
di
questi
incredibilmente
vasti
clan
famigliari
arabi
avrà
certamente
dei
problemi,
forse
meno
grandi
di
quelli
del
periodo
della
Prima
Intifada,
con
le
sue
centinaia
di
ragazzi
incarcerati
per
anni,
ma
pur
sempre
problemi.
Ben
pochi
qui
parlano
anche
solo
un
po’
di
ebraico
e le
insegne
dei
negozi,
tutte
strettamente
in
arabo,
sono
solo
una
conseguenza
di
ciò:
un
extraterrestre
caduto
sulla
Terra
proprio
sul
grande
stradone
che
corre
sulla
cresta
del
Monte,
potrebbe
tranquillamente
pensare
di
essere
capitato
ad
Amman,
a
Damasco
o a
Kuwait
City,
ma
non
certo
nella
“capitale
indivisibile”
dello
Stato
che
innalza
Menorah
e
Stella
di
David
come
propri
simboli.
E,
certamente,
il
Monte
degli
Ulivi
non
è un
caso
isolato.
Qui
non
è
questione
di
politica
o di
“scelta
di
campo
preventiva”
e
nemmeno,
quasi
paradossalmente
in
una
città
in
cui,
in
misura
esponenzialmente
maggiore
rispetto
a
qualunque
altro
insediamento
umano
al
mondo,
si
vive
quotidianamente
l’attesa
di
una
salvezza,
di
una
redenzione
o di
una
sottomissione
delle
genti
a
Dio,
una
questione
di
religione:
è
semplicemente
una
questione
di
conoscere
un
minimo
di
storia
e di
avere
gli
occhi
per
guardarsi
attorno.
Gerusalemme
Ovest,
con
la
sua
struttura
moderna,
con
i
suoi
grandi
viali
squadrati,
con
i
suoi
ristoranti
kosher
e la
sua
popolazione
perennemente
indaffarata
e di
corsa
è
una
cosa
e,
oggettivamente,
al
di
là
di
qualsiasi
presa
di
posizione
o di
qualsiasi
preconcetto,
questa
cosa
non
è la
stessa
di
Gerusalemme
Est,
con
i
suoi
vicoletti
polverosi,
le
sue
miriadi
di
bambini
vocianti,
i
suoi
immensi,
quasi
ininterrotti
e
labirintici
suk,
con
i
venditori
che
contrattano
su
tutto,
dalle
croci
dei
pellegrini
alle
spezie
per
le
massaie,
tutte
in
chador
come
richiede
il
Corano.
Semplicemente,
la
città
dei
bambini
ultraortodossi
con
i
lunghi
riccioli
sulle
tempie
e i
cappelli
di
foggia
ottocentesca
non
è la
stessa
città
dei
troppi
gruppi
di
giovani
senza
lavoro,
seduti
sui
muretti
delle
stradine
e
pronti
a
imbrogliare
qualsiasi
turista
per
portare
a
casa
qualche
shekel
e
poter
mangiare
(e
mi
rendo
conto
di
quanto
possa
suonare
retorica
una
frase
del
genere
in
occidente,
quando,
invece,
a
Gerusalemme
questa
è
solo
la
pura
constatazione
della
realtà).
Mi
domando
se
quello
che
mi
ha
detto
Walid,
taxista
da
dodici
anni,
è
vero:
“Ma
se
loro
hanno
perso
la
terra
duemila
anni
fa,
che
colpa
ne
abbiamo
noi?
Anche
noi
abbiamo
abitato
la
Palestina
a
lungo!
Non
siamo
stati
noi
a
fare
l’Olocausto:
perché
la
terra
agli
Ebrei
non
l’ha
data
la
Germania?
Chiediti
il
perché?
Ti
potrai
rispondere
che
è
solo
perché
noi
Palestinesi
siamo
poveri
e la
Germania,
invece,
è
ricca!”
No,
vorrei
dirgli,
non
è
solo
per
questo:
c’è
stato
altro,
c’è
stato
un
“diritto
storico”
applicato,
c’è
stato
un
Gran
Muftì
di
Gerusalemme
che
ha
appoggiato
le
criminali
farneticazioni
antisemite
hitleriane,
c’è
stata
una
risoluzione
delle
Nazioni
Unite.
Non
è
stata
questione
di
ricchezza
o
povertà.
Forse.
Insomma,
questa
è
pur
sempre
la
città
di
David,
di
Salomone,
dei
Maccabei…
Eppure,
una
domanda
continua
a
girarmi
per
la
testa:
e se
gli
Italiani,
un
giorno,
decidessero
di
occupare
la
Tunisia
perché
un
tempo
era
parte
dell’Impero
Romano,
come
reagirebbe
il
mondo?
O
se,
magari,
i
Greci
improvvisamente
si
stanziassero
a
Kandahar
perché
molti
secoli
fa
era
stata
una
città
conquistata
da
Alessandro
il
Macedone?
E
poi,
qualche
anno
fa
(ormai
parecchi,
a
dire
il
vero),
non
era
stato
forse
tutto
il
mondo
occidentale
a
condannare
l’Argentina
e il
suo
principio
di
“possesso
primo”
nella
vicenda
delle
Falkland?
Non
c’era
stato
chi
aveva
affermato
che,
seguendo
quel
principio,
avremmo
dovuto
ridisegnare
l’intera
geografia
politica
del
Pianeta?
E
anche
fosse,
proprio
applicando
quel
principio,
non
dovremmo
ricordare
che,
non
secondo
questo
o
quello
storico
ma
secondo
la
Bibbia
stessa,
questa
striscia
di
terra
era
stata
presa
ai
Filistei,
cioè
a
quelli
che
oggi
chiamiamo,
con
retaggio
che
si
palesa
persino
a
partire
dai
nomi,
Palestinesi?
E
perché
nessuno
ha
pensato
a
tutto
questo
nel
1948?
Forse
perché
l’occidente,
tutto
l’occidente
e
non
solo
quello
nazi-fascista
ma
anche
quello
che
“aveva
lasciato
correre”,
che
“non
ci
aveva
creduto”
e
che
“aveva
chiuso
gli
occhi”
per
poi
riaprirli
inorridito
solo
quando
quasi
tutto
era
stato
compiuto,
aveva
troppo
da
farsi
perdonare?
Ma
che
cosa
penserebbero
gli
Israeliani
stessi
se
riflettessero
sulla
nascita
del
loro
Stato
come
frutto
di
un
senso
di
colpa
non
sopito
per
la
Shoah?
Ma,
va
bene,
le
cose
sono
andate
così:
insomma,
gli
Israeliani
la
loro
terra,
in
un
modo
o
nell’altro,
se
la
sono
presa,
indubbiamente
l’hanno
saputa
far
fruttare
al
meglio
e
l’hanno
saputa
difendere
come
nessun
altro
avrebbe
saputo
fare.
Ma
non
c’era
stato
un
accordo
a
Oslo?
Non
c’era
un
processo
di
divisione
tra
i
due
stati?
Mahamud,
quando
glielo
chiedo,
scuote
la
testa,
sorride
malinconico
e
risponde
solo:
“Amico
mio,
è
solo
propaganda:
è il
denaro
che
conta
e il
denaro
ce
l’hanno
gli
Ebrei”.
Subito
penso
a
certe
antiche
litanie
sulla
“plutocrazia
giudaico-massonica”
di
ben
nefaste
memorie
e
questa
volta
non
posso
essere
d’accordo
con
il
mio
amico.
Poi
è
Suleiman,
direttore
Cristiano-Palestinese
di
una
delle
più
grandi
scuole
superiori
di
Gerusalemme
a
chiarirmi
le
idee,
spiegandomi
che
il
West
Bank,
quell’embrione
(o,
secondo
alcuni,
quell’aborto)
del
futuro
Stato
Palestinese
che
comprende
città
come
Betlemme,
Gerico
e
Ramallah,
è
formato
da
meno
di
1/4
dello
Stato
d’Israele,
il
che,
di
per
sé,
essendo
i
Palestinesi
circa
il
23%
della
popolazione,
potrebbe
essere
anche
equo,
ma
se,
a
sua
volta,
il
25%
del
West
Bank
è
occupato
da
350.000
coloni
israeliani
(quegli
stessi
che,
a
volte,
con
una
immagine
piuttosto
scioccante,
si
vedono
girare
armati
persino
nel
cuore
della
Città
Vecchia,
a
pochi
passi
dal
Santo
Sepolcro,
sotto
lo
sguardo
indifferente
delle
centinaia
di
soldati
e
poliziotti
che
pattugliano
ogni
angolo
della
zona
e
che,
normalmente,
non
si
fanno
scrupoli
a
far
chiudere
a
suon
di
calci
ai
tavoli
carichi
di
pagnotte
gli
affari
a
bambini
palestinesi
venditori
“abusivi”
di
focaccine
al
sesamo),
che
non
se
ne
vogliono
andare
e
che,
incredibilmente
(almeno
per
chi
viene
da
fuori),
finiscono
per
essere
difesi
proprio
da
quel
governo
che
dovrebbe
farli
sloggiare,
allora,
mi
sembra,
tutto
diventa
molto
meno
equo.
Ma,
insomma,
non
sono
questi
Palestinesi,
questi
Arabi
che,
con
il
loro
fanatismo,
il
loro
integralismo,
hanno
provocato
la
reazione
ebraica
e di
tutto
l’occidente?
Certo,
e
sicuramente,
per
quanto
non
si
possano
mescolare
le
carte
e
non
si
debbano
confondere
i
ragazzi
delle
Intifade
e i
Talebani
che
devastano
i
monumenti
storici
perché
“non
islamici”,
le
ali
moderate
e
maggioritarie
di
Hamas
e la
follia
sanguinaria
di
Al
Qaeda,
non
sarebbe
giusto
non
condannare
ogni
forma
di
violenza,
da
qualunque
parte
derivi...
Ma,
sarà
l’effetto
di
Gerusalemme,
di
questa
città
in
cui,
volente
o
nolente,
le
prospettive,
forse
tutte
le
prospettive,
finiscono
per
cambiare,
ci
sono
molte
domande
che
non
riescono
a
trovare
risposta.
La
prima
domanda
è
quella
che
fa
Fwad,
altro
taxista,
questa
volta
di
Betlemme,
che,
con
uno
sguardo
che
non
saprei
se
definire
sarcastico
o
semplicemente
disperato,
mi
chiede:
“Ma
voi,
in
occidente,
da
dove
le
prendete
le
notizie?
Te
lo
dico
io:
da
Haaretz
o
dal
Jerusalem
Post.
Ma
chi
ci
scrive
là?
Ebrei,
non
Palestinesi.
Così,
se
un
missile
degli
Hezbollah
colpisce
l’Alta
Galilea,
lo
sa
tutto
il
mondo,
ma
degli
arresti
sulla
base
della
regola
del
sospetto
che
l’esercito
israeliano
fa
ogni
giorno
nel
West
Bank,
che
dovrebbe,
in
teoria,
essere
indipendente,
nessuno
ne
parla
mai”.
Ribatto
che,
però,
alla
fine,
proprio
dal
West
Bank
Hamas
lo
hanno
cacciato
i
Palestinesi
stessi
e
scuote
la
testa.
“Se
ci
sono
elezioni
in
Italia,
tu
puoi
scegliere
se
votare
a
destra
o a
sinistra
e
sono
affari
tuoi
e il
governo
lo
prende
chi
ha
avuto
più
voti.
Qui
è
diverso:
la
gente
ha
votato
per
Hamas
perché
siamo
stanchi
di
Al
Fatah
e di
tutte
le
sue
grandi
trattative
che
non
hanno
portato
a
niente.
Ma
non
siamo
padroni
sulla
nostra
terra
e
così,
quando
Israele
ha
voluto,
ci
ha
chiuso
l’acqua
e
dopo
un
po’
la
gente
non
ce
l’ha
fatta
più
e si
è
ribellata
contro
il
suo
stesso
governo”.
Il
discorso,
mi
dico,
ha
una
sua
logica
ma i
kamikaze
che
fanno
saltare
gli
autobus
non
sono
certo
Ebrei.
E
qui
nasce
la
seconda
domanda
che
non
trova
risposta.
Samir
fa
l’insegnante,
è
Cristiano
Ortodosso,
è
Palestinese
e mi
chiede:
“Sei
convinto
che
certi
Hassidim
ultraortodossi,
quelli
che
se
capiti
nei
loro
quartieri
con
una
croce
al
collo
ti
sputano
addosso
e
che,
per
rispetto
alle
tradizioni,
si
mettono
dei
cappelli
di
pelliccia
anche
d’estate
con
40
gradi,
non
sarebbero
disposti
a
fare
lo
stesso
se
le
posizioni
fossero
invertite?
Guarda
che
noi
siamo
i
primi
a
soffrire
per
l’immagine
che
i
Palestinesi
ottengono
da
questi
fanatici
kamikaze,
ma
che
cosa
porta
all’esasperazione?
E
poi,
chi
ha
invaso
chi?
I
morti
del
vostro
Risorgimento
voi
non
li
chiamate
eroi?”
Aumenta
la
dose
Nabil,
volontario
della
Caritas,
che
spiega:
“Un
attacco
suicida
è il
massimo
della
disumanizzazione
e
siamo
tutti
d’accordo
su
questo.
Ma
se
ti
tolgono
la
dignità,
se
ti
tolgono
l’identità,
se
non
hai
un
lavoro,
se
non
hai
un
passaporto,
se
non
hai
una
Patria
e
una
casa,
se
vivi
come
un
prigioniero
dentro
campi
profughi
recintati,
che
cos’hai
da
perdere?
Chi
si è
portato
via
la
tua
umanità?
Lo
sai
che
a
Gaza
l’80%
della
popolazione
mangia
solo
perché
noi
e le
Nazioni
Unite
distribuiamo
razioni
alimentari?”.
Non
so...
Gerusalemme
può
essere
una
città
che
confonde
e
io,
che
vivo
in
un
quartiere
arabo,
che
parlo
in
prevalenza
con
Arabi,
forse
mi
sto
facendo
confondere,
in
questa
giostra
tragica
in
cui
sembra
che
tutti
abbiano
qualcosa
da
recriminare,
in
cui,
come
forse
inevitabile
in
ogni
guerra,
combattuta
o
non
combattuta
che
sia,
nessuno
è
senza
peccato
e
nessuno
ha
torto
al
100%.
Ma
penso
a
quello
che
vedo
e
quello
che
vedo
è
che
a
pochi
chilometri
da
Gerusalemme
c’è
un
muro
enorme,
lunghissimo,
più
alto
di
quello
di
Berlino,
più
massiccio
di
quello
di
Nicosia,
che
segna
il
confine
con
il
West
Bank
e
non
posso
fare
a
meno
di
pensare
alla
parola
più
ricorrente
riguardo
ai
muri
che
dividono
le
Nazioni:
vergogna!
Penso
a
quello
che
vedo
e
quello
che
vedo
è
che,
mentre
sto
attraversando
il
confine
per
andare
a
Betlemme,
i
soldati
israeliani,
che
poi
sono
dei
ragazzi
e
delle
ragazze
che
stanno
lì
perché
ce
li
hanno
mandati,
a
regalare
tre
anni
di
vita
al
loro
Paese,
in
attesa
di
ritornare,
nella
vita
civile,
studenti
universitari,
operai,
impiegati,
ingegneri,
camerieri
e
quant’altro,
danno
solo
un’occhiata,
vedono
che
sono
un
occidentale
e mi
fanno
passare
senza
neppure
controllare
i
documenti.
E mi
domando,
allora,
perché
Mahamud,
per
andare
a
trovare
sua
cognata,
che
vive
a
quattro
chilometri
dal
suo
chiosco
del
Monte
degli
Ulivi,
ci
metta
due
ore
per
andare
e
due
ore
per
tornare
a
causa
delle
file
dei
controlli,
mi
domando
perché
Suleiman
il
preside
mi
dica
che
i
suoi
insegnanti
che
vivono
nel
West
Bank
si
devono
alzare
tutte
le
mattine
alla
quattro
per
arrivare
a
scuola
alle
nove,
ma
comunque
sono
contenti
perché
almeno
hanno
un
pass
per
poter
attraversare
il
muro
e,
per
venire
a
Gerusalemme,
dove
possono
fare
le
guide
turistiche
nel
pomeriggio,
andrebbero
ad
insegnare
anche
gratis.
Mi
domando,
ed è
la
domanda
più
difficile
da
farsi
per
tutte
le
sue
implicazioni,
se
quello
che
mi
dicono
in
tanti,
in
troppi,
Palestinesi
ed
Europei
che
vivono
da
anni
in
Israele,
che
il
governo
vuole
rendere
Israele
un
Paese
ebreo
per
gli
Ebrei
e
sta
facendo
di
tutto
per
far
sì
che
tutti
gli
altri
emigrino,
non
sia
forse
vero.
A
Gerusalemme
Ovest
osservo
questi
Ebrei
che
starebbero
cercando
di
compiere
una
sottile,
strisciante
“ebraicizzazione”
del
Paese,
proprio
loro
che
dovrebbero
essere
i
più
attenti
a
questo
genere
di
cose.
Ecco,
quell’Askenazita
ultraortodosso,
quel
“ricciolone”
come
li
chiamano
qui
per
le
lunghe
basette,
che
viene
dalla
Russia,
non
parla
una
parola
d’inglese
e
arranca
sbuffando
sotto
la
sua
palandrana
nera
leggendo
un
Testo
religioso,
magari
potrebbe
essere
d’accordo,
dimenticandosi
forse
dei
pogrom
di
qualche
decennio
fa,
quella
famiglia
Lubavitcher,
con
lui
con
le
frange
del
Tallit
che
spuntano
dalla
camicia
e
lei
con
la
gonna
alla
caviglia
e i
capelli
raccolti
sotto
un
foulard
annodato,
anche,
ma
quei
tanti
ragazzi
senza
neppure
la
kippah,
quelle
ragazze
abbronzate
in
canottiera,
quelle
centinaia
di
uomini
e
donne
che
non
si
distinguerebbero
mai
da
migliaia
e
milioni
di
altri
uomini
e
donne
di
Napoli,
Malaga
o
Salonicco,
loro,
certamente,
non
potrebbero
volere
una
cosa
simile.
E,
mi
accorgo,
anche
questa
è
una
generalizzazione
indebita,
basata
sull’aspetto
e
sul
grado
di
religiosità,
quando
avrei
dovuto
già
capire
che
qui
ogni
caso
è un
caso
a
sé,
che
sfugge
da
ogni
regola.
Di
una
cosa,
però,
sono
certo,
girando
per
Gerusalemme,
“capitale
indivisibile”
e
già
divisa
dai
fatti
e
dalla
storia,
sottoponendomi
alla
lunga
trafila
di
controlli
all’aeroporto
Ben
Gurion,
con
l’addetta
alle
perquisizioni
che
sobbalza
sgranando
gli
occhi
quando,
ridendo
(e,
mi
rendo
conto,
con
una
frase
incredibilmente
infelice),
le
faccio
notare
che,
dopo
il
terzo
controllo,
se
mi
fanno
aprire
ancora
una
volta
i
bagagli,
la
mia
valigia
strapiena
“esploderà”,
osservando
gli
occhi
di
un
gruppo
di
ragazzi
palestinesi
a
cui
l’ennesima
pattuglia
sta
facendo
l’ennesimo
controllo
documenti,
notando
come
tutti
si
girano
di
scatto
quando
un
bambino
fa
scoppiare
una
castagnola
in
un
vicoletto
della
Città
Vecchia...
Due
Popoli
hanno
bisogno
di
due
Nazioni
libere,
autonome
e
indipendenti
e
chiunque
si
opponga
a
questo,
di
qualunque
schieramento
sia,
qualunque
siano
le
sue
idee,
sta
compiendo
un
delitto,
non
solo
un
delitto
contro
i
Palestinesi
schiacciati,
non
solo
un
delitto
contro
gli
Israeliani
che
vivono
nella
paura,
ma
un
delitto
contro
il
concetto
stesso
di
umanità.

|
|
|
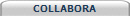
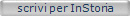
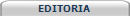
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
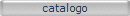
.
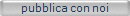
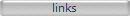
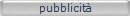
InStoria.it



|