|
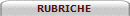

.

.

.

.
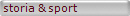
.
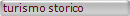
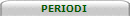
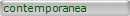
.

.
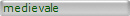
.


.
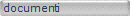
.
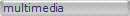
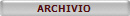

|
N. 27 - Marzo 2010
(LVIII)
ISTITUZIONI E ASSISTENZA PUBBLICA IN ITALIA TRA FASCISMO E REPUBBLICA
gli Enti Comunali di Assistenza - Parte III
di Maria Giovanna Pipino
Anche
l’Italia,
come
molti
altri
Paesi
europei,
fu
alle
prese
con
il
dibattito
relativo
alla
necessità
di
una
riforma
del
sistema
assistenziale,
ma,
a
differenza
di
quanto
accadde
in
gran
parte
d’Europa,
che
in
quegli
anni
conobbe
la
nascita
e il
rafforzamento
di
sistemi
di
protezione
sociale,
in
Italia
non
si
riuscì
a
realizzare
un
sistema
assistenziale
strutturato
e
omogeneo.
Il
sistema
politico
italiano
estremamente
frammentato
e
caratterizzato
da
una
forte
litigiosità
tra
gli
schieramenti,
rese
sterile
qualsiasi
proposta
di
rinnovamento
basato
sul
concetto
di
sicurezza
sociale.
Tale
concetto
era
stato
teorizzato
in
Europa
dall’economista
inglese
William
H.
Beveridge.
Nel
dicembre
del
1942,
per
conto
del
governo
inglese,
Beveridge
redasse
il
rapporto
Social
Insurance
and
Allied
Services,
che
costituì
la
base
teorica
del
Welfare
State.
In
Italia
il
pur
fecondo
dibattito
attorno
alla
questione
delle
riforme
sociali
non
riuscì
a
tradursi
in
un
riassetto
complessivo
del
sistema
di
sicurezza
sociale,
se
non
dopo
alcuni
decenni.
Nonostante
i
contenuti
molto
avanzati
del
testo
costituzionale,
nonostante
il
livello
delle
proposte
formulate
da
apposite
commissioni,
in
Italia
la
radicalizzazione
della
lotta
politica
seguita
alle
elezioni
del
1948,
rese
impossibile
qualsiasi
grande
riforma
e
non
passò
il
concetto
di
sicurezza
sociale,
ma
piuttosto
si
consolidò
il
cosiddetto
“particolarismo
clientelare”.
Particolarismo
perché
l’assistenza
continuò
ad
essere
considerata
a
lungo
come
strumento
per
mantenere
l’ordine
sociale
ed
era
basata
esclusivamente
sui
sussidi
temporanei,
che
venivano
erogati
in
modo
settoriale,
a
seconda
delle
diverse
categorie
e
senza
un
coordinamento
tra
le
azioni
degli
innumerevoli
enti
preposti.
Clientelare
perché
i
molteplici
istituti
ed
enti
assistenziali
costituirono
una
fonte
di
clientelismo
e
corruzione,
nonché
strumenti
di
potere
e di
controllo
politico
e
sociale.
Nel
corso
della
stagione
centrista
i
“confini”
dello
Stato
sociale
furono
ampliati.
Molte
categorie
precedentemente
non
tutelate
furono
progressivamente
inserite
all'interno
degli
schemi
di
protezione
sociale.
Tuttavia,
ciò
avvenne,
sulla
base
di
criteri
e di
scelte
contingenti,
che
non
si
inserivano
in
un
programma
organico
ma
erano
piuttosto
frutto
di
pressioni
di
determinate
categorie,
spesso
accolte
per
motivi
elettoralistici.
Per
citare
alcuni
esempi
si
possono
ricordare
le
disposizioni
in
ambito
infortunistico
progressivamente
ampliate
sotto
il
profilo
della
copertura
(nel
1959,
per
esempio,
si
attuò
con
legge
la
copertura
contro
le
malattie
professionali
per
i
lavoratori
agricoli)
ma
più
sulla
base
dell'importanza
e
del
peso
–
soprattutto
elettorale
–
dei
settori
economici
e
sociali
destinatari
del
provvedimento
che
in
base
ad
un
disegno
di
riforma
complessivo.
L'estensione
degli
schemi
di
copertura
a
categorie
sociali
precedentemente
non
tutelate
rappresentò
l'elemento
caratterizzante
anche
degli
interventi
nell'ambito
della
sanità.
Nel
1952
si
fornì
per
legge
tutela
in
questo
ambito
al
settore
dei
lavoratori
domestici.
Seguirono
i
coltivatori
diretti,
coloni
e
mezzadri
(1954),
gli
artigiani
(1956),
i
lavoratori
a
domicilio
e i
pescatori
(1958),
i
commercianti
(1960).
Questo
ampliamento
del
sistema
mutualistico
si
realizzò
tuttavia
secondo
gli
schemi
classici
del
particolarismo
clientelare
che,
del
resto,
rappresentarono
l'elemento
caratterizzante
di
buona
parte
delle
politiche
sociali
del
decennio.
Gli
anni
Cinquanta
furono
gli
anni
della
mancata
modernizzazione
del
sistema
complessivo
di
welfare
in
Italia.
Le
cause
vanno
ricercate
in
una
serie
di
fattori
sociali,
economici
e
politici,
che
caratterizzavano
la
situazione
post-bellica.
Innanzitutto
le
disastrose
condizioni
dell'economia
nazionale
tali
da
non
consentire
il
finanziamento
di
un
sistema
di
protezione
sociale
gestito
dallo
Stato
sul
modello
di
quello
britannico
o
scandinavo.
Inoltre
il
particolare
contesto
politico
interno,
che
vedeva
l’esclusione
delle
sinistre
dal
governo
e il
forte
scontro
tra
maggioranza
centrista
e
opposizione,
impedirono
per
lungo
tempo
la
possibilità
di
realizzare
un
fronte
più
ampio
tra
le
varie
forze
politiche
attorno
alle
questioni
della
riforma
dello
Stato
sociale.
Un
altro
importante
elemento
fu
costituito
dalla
dirigenza
democristiana,
che
vide
nel
carattere
particolaristico
e
clientelare
delle
politiche
sociali
uno
strumento
per
la
gestione
del
consenso
a
livello
locale
e
nazionale
o
per
convogliare
le
richieste
provenienti
da
gruppi
di
pressione
e
organizzazioni
ad
essa
vicina.
Il
welfare
state
italiano
si
sviluppò
per
volontà
dei
gruppi
dirigenti,
che
non
avevano
intenti
redistributivi,
ma
volevano
mantenere
la
società
il
più
possibile
inalterata
rispetto
al
passato,
ovvero
diseguale.
A
frenare
la
realizzazione
di
una
riforma
complessiva
e
organica
del
sistema
di
welfare
negli
anni
Cinquanta
concorsero
però
anche
il
mancato
interessamento
dei
partiti
della
sinistra.
Questo
fu
dovuto
all'avvio
della
stagione
della
Guerra
fredda
e
all’isolamento
determinato
dalla
sconfitta
del
Fronte
popolare
alle
politiche
del
1948,
ma i
partiti
della
sinistra
manifestarono
per
una
lunga
fase
una
scarsa
attenzione
ai
temi
dello
Stato
sociale,
delegando
in
larga
parte
queste
tematiche
al
sindacato
(Cgil).
La
politica
assistenziale
negli
anni
Cinquanta
fu,
quindi,
connotata
da
una
forte
continuità
con
il
periodo
precedente
e
gli
interventi
continuarono
ad
essere
concepiti
come
aiuto
materiale,
erogazione
di
beni
alle
persone
e
alle
famiglie
povere,
o a
favore
di
categorie
protette.
Il
sistema
continuò
a
prevedere
assistenza
e
interventi
per
le
pensioni,
malattia
e
maternità
,
infortuni,
disoccupazione,
tubercolosi
e
assegni
familiari,
gestiti
da
una
molteplicità
di
enti,
tra
cui
gli
stessi
creati
dal
regime
fascista
nel
corso
degli
anni
Trenta
(INPS,
INAIL,
INAM).
Il
retaggio
fascista
condizionò,
quindi,
il
tentativo
di
riforma
dello
stato
sociale,
facendo
fallire
l’intento
di
riorganizzazione.
I
grandi
istituti
ed
enti
previdenziali
costituiti
durante
il
fascismo,
divennero
importanti
pilastri
della
rete
di
controllo
politico
e
sociale
e
caratterizzarono
il
tipo
di
welfare
che
si
sviluppò
nel
dopoguerra.
Un
esempio
della
continuità
con
il
passato
fu
il
mantenimento
dell’Ente
comunale
di
assistenza,
a
dimostrazione
di
come
la
fine
del
regime
non
fu
seguita
automaticamente
dallo
smantellamento
delle
strutture
da
esso
create.
Anzi,
gli
ECA
continuarono
ad
essere
uno
strumento
fondamentale
per
l’assistenza
locale,
in
un
periodo,
come
il
dopoguerra,
che
richiese
notevoli
sforzi
ed
interventi
per
affrontare
le
numerose
conseguenza
sociali
della
guerra.
Ma
vediamo,
nello
specifico,
le
varie
proposte
di
legge
che
caratterizzarono
quegli
anni,
ma
che
non
portarono
ad
un
processo
di
riforma.
Nei
primi
anni
Cinquanta,
l’ANEA,
l’Associazione
nazionale
degli
enti
comunali
di
assistenza,
inviò
a
ciascun
ECA
iscritto
un
questionario,
che
rientrava
in
un
progetto
ben
preciso
voluto,
in
particolare,
dal
Presidente
dell’associazione,
il
socialdemocratico
Ezio
Vigorelli.
L’obiettivo
del
questionario
fu
quello
di
effettuare
una
rilevazione
delle
modalità
e
dei
criteri
delle
prestazioni
dell’assistenza
nell’ambito
delle
attività
degli
ECA,
attraverso
un’indagine
estesa
a
tutto
il
territorio
italiano,
per
definire
la
situazione
dell’assistenza
a
livello
nazionale.
Questo
studio
venne
promosso
dalla
“Commissione
Parlamentare
di
Inchiesta
sulla
miseria
in
Italia
e
sui
mezzi
per
combatterla”
proposta
dallo
stesso
Vigorelli
nel
settembre
1951,
affiancata
da
un’inchiesta
parallela
sulla
disoccupazione
(guidata
dal
socialdemocratico
Roberto
Tremelloni).
Nel
clima
di
democrazia
e
libertà
sorto
in
Italia
nel
dopoguerra,
l’esigenza
di
un
riordinamento
del
settore
assistenziale
derivò
dalla
volontà
di
rendere
effettivo
il
diritto
di
ogni
cittadino
all’assistenza,
che
era
stato
sancito
nella
Costituzione
(art.38).
Nelle
intenzioni
dei
promotori,
il
compito
della
Commissione
doveva
essere
quello
di
studiare
il
funzionamento
del
settore
assistenziale,
per
poi
proporre
una
sua
riforma
organica
intesa
a
realizzare
i
principi
sanciti
nella
Costituzione.
Lo
Stato
non
avrebbe
più
solo
dovuto
imporre
obblighi
di
solidarietà
agli
altri
soggetti,
come
era
avvenuto
nello
Stato
corporativo
fascista,
ma
era
suo
compito
assumerne
la
responsabilità
e
agire
direttamente.
A
tale
proposito
l’ANEA
fu
incaricata
di
«effettuare
una
rilevazione
connessa
all’esame,
con
carattere
comparativo,
delle
modalità
e
dei
criteri
della
prestazione
dell’assistenza
nell’ambito
dell’attività
degli
ECA
in
Italia».
Da
qui
l’idea
del
questionario,
il
quale
fu
redatto
«prendendo
a
modello
l’ipotesi
di
un
ECA
dotato
di
un’organizzazione
il
più
possibile
vasta
e
completa,
che
si
presume
rispondente»
e
che
consentì
di
colmare
un
grave
vuoto
conoscitivo
sulla
situazione
assistenziale.
Dall’Inchiesta
emerse
un
quadro
preoccupante
della
situazione
sociale
italiana.
In
primo
luogo
si
cercò
di
contare
le
istituzioni
che
componevano
l’intricata
rete
di
assistenza
italiana:
ben
40.000
enti
e
istituzioni
tra
pubblici
e
privati,
scoordinati
l’uno
dall’altro,
ognuno
dei
quali
preposto
ad
una
specifica
categoria
di
persone.
La
possibilità
(non
il
diritto)
di
ottenere
assistenza
da
un
determinato
ente,
dipendeva
dal
possesso
di
certi
requisiti
che
dovevano
essere
ogni
volta
dimostrati.
In
secondo
luogo,
fu
messa
in
luce
la
gravità
della
situazione
degli
Enti
comunali
di
assistenza,
che
all’epoca
tutelavano
2.570.000
persone
(circa
il
5,50%
della
popolazione
italiana):
il
95%
degli
ECA
non
disponevano
di
fondi
propri,
a
parte
il
contributo
elargito
dallo
Stato,
il
cui
gettito
complessivo
si
aggirava
attorno
agli
11
miliardi
di
lire,
il
che
significava
che
a
ogni
assistito
era
riservata
una
quota
di
3.000
lire
annue
per
l’assistenza:
una
cifra
irrisoria.
Le
indagini
statistiche
fornirono
una
fotografia
dei
problemi
sociali
dell’epoca,
attraverso
il
rilevamento
del
tenore
di
vita
della
popolazione,
valutando
aspetti
quali
l'abitazione,
l'alimentazione
e
l'abbigliamento:
migliaia
di
persone
vivevano
in
condizioni
disagiate,
per
non
dire
disumane,
mettendo
in
luce
una
situazione
preoccupante.
Di
fronte
ad
una
situazione
di
degrado
e
povertà
ben
documentata,
Vigorelli
sostenne
la
necessità
di
trasformare
il
settore
assistenziale
"in
un
vero
e
proprio
sistema
di
sicurezza
sociale"
(vol
II,
p.13).
Su
questo
aspetto
si
concentrarono
le
proposte
legislative
avanzate
della
Commissione,
che
furono,
però,
limitate.
Si
suggerì
la
realizzazione
di
un
maggiore
coordinamento
nella
macchina
assistenziale,
attraverso
la
creazione
di
un
ente
supervisore
in
seno
al
governo.
Oltre
non
si
poteva
andare
nelle
condizioni
politiche
dell’epoca,
in
cui
i
tentativi
di
riforma
trovavano
un
ostacolo
insormontabile
negli
interessi
consolidati.
Nonostante
gli
ostacoli
incontrati
dall’iniziativa
della
riforma
dell’assistenza,
nel
corso
del
decennio,
da
più
parti,
si
continuò
ad
insistere
sull’argomento,
cercando
di
sensibilizzare
non
solo
le
istituzioni,
ma
anche
la
società
civile
su
quel
fronte.
È
del
1956
un
articolo
pubblicato
sulla
rivista
dell’ANEA
“Solidarietà
Umana”,
in
cui
si
lamenta
la
mancanza
di
un
testo
unico
delle
leggi
sull’assistenza
pubblica
aggiornato
e
completo.
L’ANEA
auspicava
una
riforma
che
contenesse
anche
la
regolamentazione
dell’attività
degli
Enti
comunali
di
assistenza.
Innanzi
tutto
con
la
riforma
erano
da
attribuirsi
all’ECA,
oltre
alla
competenza
primaria
nell’assolvere
compiti
di
assistenza
generica,
la
competenza
di
carattere
integrativo
o
surrogatorio
nell’assolvere
compiti
di
assistenza
specifica
(assistenza
ai
minori
abbandonati,
agli
inabili
al
lavoro,
apertura
di
Istituti
di
ricovero
post-ospedaliero,
etc…),
che,
dalla
fine
della
guerra
gli
ECA
si
erano
ritrovati
a
dover
affrontare.
Ma,
per
svolgere
tali
attività,
era
necessario
aumentare
la
disponibilità
finanziaria
degli
enti,
osservazione,
questa,
che
rientrava
nella
discussione
relativa
all’addizionale
ECA
del
5%,
che
non
veniva
del
tutto
devoluta
agli
enti
comunali
di
assistenza.
Il
3%
di
quella
addizionale,
infatti,
era
distribuito
alle
province
e
solo
il
rimanente
2%
era
devoluto
agli
ECA.
La
riforma
del
settore
assistenziale,
pur
essendo
auspicata
e
pur
essendo
oggetto
di
discussione
in
sedi
istituzionali,
non
venne
realizzata.
Le
ragioni
di
questa
mancata
realizzazione,
vanno
ricercate
nella
volontà
della
classe
dirigente
di
allora
di
non
alterare
lo
status
quo.
Buona
parte
del
ceto
politico
di
governo
e
l’intero
fronte
conservatore
avevano
interesse
a
mantenere
il
vigente
frammentato
meccanismo
di
elargizione,
caratterizzato
da
molteplici
enti
e
istituti,
che
costituivano
un
apparato
fortemente
burocratico
e
clientelare,
terreno
fertile
per
il
fenomeno
della
corruzione.
È
possibile
elencare
le
diverse
tipologie
di
enti
preposti
all’assistenza,
per
una
breve
panoramica
della
moltitudine
di
livelli
di
intervento:
Enti
pubblici
nazionali
di
assistenza,
tra
cui
l’ONMI,
l’ENAOLI
(Ente
nazionale
di
assistenza
agli
orfani
dei
lavoratori
italiani),
l’ENPMF
(Ente
nazionale
per
la
protezione
morale
del
fanciullo),
l’ONOG
(Opera
nazionale
orfani
di
guerra),
ecc.;
altri
enti
pubblici
tra
cui
gli
ECA
e le
IPAB;
enti
ed
associazioni
privati
riconosciuti
giuridicamente
dallo
Stato,
detti
anche
enti
morali;
enti,
associazioni,
fondazioni
non
riconosciuti
dallo
Stato;
molte
competenze,
infine,
afferivano
a
vari
ministeri
e
alle
Prefetture.
Dal
punto
di
vista
organizzativo,
il
panorama
istituzionale
assistenziale
risultava
generalmente
accentrato
e
verticistico
(in
particolar
modo
per
quanto
riguardava
gli
enti
statali,
i
ministeri,
le
Prefetture)
e
fortemente
burocratizzate.
Le
fitte
maglie
della
burocrazia
causavano
ingenti
spese
e
sprechi
e
tendevano
a
trasformare
gli
interventi
assistenziali
in
mere
risposte
formali,
senza
porre
attenzione
alla
risoluzione
dei
veri
problemi
sociali,
che
potevano
essere
affrontati
solo
con
una
sincera
solidarietà
umana.
Alcuni
enti
pubblici
avevano
un’articolazione
periferica
molto
capillare
e
vicina
alla
popolazione,
ma
il
distacco
dai
problemi
degli
assisiti,
dovuto
all’organizzazione
prettamente
burocratica,
impediva
quell’empatia
e
quella
comprensione
del
bisogno
o
del
disagio,
che
avrebbe
potuto
facilitare
la
risoluzione
definitiva
del
problema.
Inoltre,
le
decisioni
relative
alle
modalità
di
funzionamento
erano
prese
dall’alto
e
distribuite
in
modo
gerarchico.
Questo,
se
si
escludevano
gli
enti
locali
(Comuni),
impediva
qualsiasi
tipo
di
controllo
da
parte
dei
cittadini
sulle
concrete
risposte
ai
loro
bisogni.
L’impostazione
settorializzata
e
parziale
dell’assistenza
non
faceva
altro
che
dare
risposte
inefficaci
ai
cittadini
bisognosi,
per
le
cui
situazioni
spesso
erano
competenti
più
istituzioni:
ad
esempio,
un
minore
illegittimo
in
difficoltà
economiche
e
comportamentali
era
seguito
dall’ONMI,
dall’ECA,
da
un’IPAB
(se
ricoverato
in
istituto),
dall’ENPMF,
dal
Ministero
di
Grazia
e
Giustizia,
ciascuno
dei
quali
era
competente
per
un
singolo
aspetto.
Si
creavano,
di
conseguenza,
situazioni
di
sovrapposizione
degli
interventi,
completamente
slegati
tra
loro,
poiché
mancava
totalmente
una
linea
unitaria
che
li
coordinasse.
La
causa
ti
tutto
ciò
era
l’assenza
del
concetto
di
sicurezza
sociale
e
della
percezione
dell’assistenza
come
prevenzione
e
non
come
rimedio
provvisorio
del
bisogno.
Inoltre,
la
coesistenza
di
istituzioni
pubbliche
e
private
(sancita
dalla
stessa
Costituzione)
non
solo
ostacolò
lo
sviluppo
della
complementarietà
tra
gli
interventi,
ma
consentì
la
salvaguardia
di
poteri
e
privilegi.
Infatti,
in
particolare
la
dirigenza
democristiana,
che
mantenne
le
redini
del
potere
per
tutto
il
decennio,
vide
nel
carattere
particolaristico
e
clientelare
delle
politiche
sociali
uno
strumento
per
la
gestione
del
consenso
a
livello
locale
e
nazionale.
In
Italia
il
welfare
state
si
sviluppò
per
precisa
volontà
dei
gruppi
dirigenti,
non
tanto
con
quegli
intenti
redistributivi
caratteristici
di
altre
realtà
europee,
quanto
piuttosto
di
mantenerla
il
più
possibile
inalterata
rispetto
al
passato.
Un
altro
elemento
che
ostacolò
l’approvazione
di
una
riforma
organica
dell’assistenza
fu
l’ostilità
del
mondo
cattolico
all’affermarsi
del
ruolo
dello
Stato
sul
fronte
dell’assistenza
e
della
previdenza.
Il
rischio
era
che
la
Chiesa
dovesse
cedere
una
parte
dei
suoi
poteri
in
un
ambito
dove,
per
secoli,
aveva
esercitato
quasi
un
monopolio.
Questo
timore
ebbe
ripercussioni
sul
rapporto
tra
Vaticano
e
partito
di
governo,
la
Dc,
che
riuscì
ad
ottenere
un
largo
consenso
elettorale,
pressoché
in
tutte
le
consultazioni
elettorali
degli
anni
Cinquanta,
grazie
anche
alla
mobilitazione
del
mondo
cattolico,
di
cui
era
il
rappresentante
politico.
È
evidente
che
potenti
pressioni
puntavano
a
vanificare
qualsiasi
tentativo
di
riforma.
Inoltre,
come
sostiene
Ginsborg:
«la
maggioranza
della
Dc
guardava
con
sospetto
alle
riforme.
Essa
era
disposta
a
promuovere
aggiustamenti
parziali
del
sistema,
che
limitassero
le
tensioni
sociali,
ma
non
voleva
modificare
la
struttura
fondamentale».
Nell’arco
di
un
decennio
dalla
fine
della
guerra,
all’entusiasmo
post-bellico,
subentrò
un
profondo
scetticismo
sulla
possibilità
di
ammodernare
il
sistema
assistenziale
italiano.
Su
questo
fronte
l’ANEA
fu
sempre
molto
presente
e
propositiva
e
volle
dare
un
nuovo
impulso
alla
volontà
riformatrice
convocando
il
Congresso
nazionale
degli
ECA
dal
9 al
12
novembre
1957.
Tema
principale
del
Congresso
fu
la
necessità
di
una
riforma
fortemente
reclamata,
poiché
la
legislazione
vigente
risultava
inadeguata
alle
esigenze
di
un
moderno
sistema
assistenziale.
Il
punto
di
partenza
doveva
essere
la
Costituzione,
la
quale
esigeva
che
fossero
protetti
i
deboli,
curati
i
malati
e
assistiti
gli
inabili,
in
altre
parole,
doveva
essere
assicurata
la
cosiddetta
“protezione
sociale”.
L’ANEA
fu,
quindi,
l’ispiratrice
dell’ultimo
disegno
di
legge
di
riforma
degli
anni
Cinquanta,
Riforma
degli
Enti
comunali
di
assistenza
e
della
altre
istituzioni
pubbliche
di
assistenza,
presentata
in
Parlamento
nel
1960,
che
aveva
lo
scopo
di
rendere
più
funzionali
e
più
aderenti
alla
realtà
gli
istituti
assistenziali,
facendo
dell’attività
assistenziale
un
vero
e
proprio
cardine
della
vita
sociale
del
Paese.
Ma
anche
questa
proposta
di
riforma
non
venne
messa
in
atto.
Da
tutto
ciò
si
capisce
come,
nonostante
la
riconosciuta
inefficacia
del
sistema
assistenziale
italiano,
le
cui
mancanze
erano
state
nascoste
all’opinione
pubblica
durante
il
fascismo
in
nome
del
prestigio
e
dell’efficienza,
non
si
arrivò
ad
una
sintesi
tra
le
diverse
posizioni.
Durante
tutti
gli
anni
Cinquanta,
quindi,
l’attività
del
Parlamento
non
seppe
mettere
in
pratica
i
nuovi
orientamenti
costituzionali
e fu
disattesa
l’ipotesi
di
una
riforma
organica
del
settore
assistenziale,
mantenendo
inalterato
il
panorama
frammentato
e
molteplice
degli
enti
adibiti
ad
attività
di
previdenza
e
assistenza,
che
spesso
si
sovrapponevano
creando
da
un
lato
confusione
e
conflitti
di
competenze,
dall’altro
sprechi
elevati.
Anzi,
gli
anni
’50
fecero
registrare
un
aumento
dell’istituzionalizzazione,
con
una
crescita
degli
istituti
di
ricovero
pubblici
e
privati
da
4.917
del
1952
a
5.544
del
1961.
Lo
strumento
di
intervento
più
capillare
rimase
però
l’ente
comunale
di
assistenza,
che
coinvolgeva
anche
il
maggior
numero
di
assistiti:
nel
1952
risultavano
assistere
mediamente
quasi
60
persone
ogni
1.000
abitanti
(i
Comuni,
invece,
ne
assistevano
direttamente,
nello
stesso
anno,
solo
10
ogni
1.000
abitanti),
ma
con
una
spesa
media
per
ogni
assistito
irrilevante,
pari
cioè
a £
3.800
annue,
che
si
abbassava
ulteriormente
nelle
regioni
meridionali
dove
aumentava
il
numero
degli
assistiti.
Ma
nell’Italia
che
si
avviava
al
boom
economico,
uscendo
dalla
secolare
arretratezza
e
correndo
verso
i
consumi
di
massa,
si
pensava
che
grazie
allo
sviluppo,
miseria
ed
emarginazione
sarebbero
scomparse.
In
questo
contesto
nazionale
di
grande
dibattito
attorno
alla
questione
della
riforma
dello
stato
sociale,
a
livello
locale
per
l’ECA
di
Monza
gli
anni
cinquanta
furono
anni
di
forte
impegno
sul
fronte
dell’assistenza
ai
bisognosi,
per
i
quali
furono
garantite
le
consuete
prestazioni
di
assistenza
generica,
parallelamente,
come
già
ricordato
in
precedenza,
a
nuovi
impegni
assunti
per
far
fronte
alle
nuove
necessità.
Il
decennio
’60
fu,
al
contrario,
ricco
di
spinte
innovative.
In
particolare
conobbe
la
diffusione
del
concetto
di
“sicurezza
sociale”
e di
“servizi
sociali”,
permise
di
interpretare
l’assistenza
non
più
come
rimedio
temporaneo,
ma
come
un
servizio
finalizzato
a
prevenire
l’insorgere
del
bisogno.
Iniziarono
a
sorgere
le
prime
scuole
per
assistenti
sociali,
ovvero
figure
professionali
con
una
formazione
adeguata
a
riconoscere
i
problemi
psico-sociali
degli
assistiti,
capaci
di
andare
alla
radice
del
bisogno
e di
trovare
i
metodi
e
gli
strumenti
per
“estirparla”.
Accanto
a
questo
nuovo
modo
di
concepire
l’assistenza,
in
quegli
anni
si
sviluppò
la
presa
di
coscienza
dei
guasti
provocati
nel
tessuto
sociale
dai
processi
di
inurbamento
e di
industrializzazione
causati
dal
“boom
economico”
degli
anni
’50.
Si
posero
le
basi
culturali
del
Welfare
State,
la
cui
importanza
e
necessità
fu
accentuata
dalla
protesta
studentesca
sul
finire
degli
anni
Sessanta,
che,
criticando
il
sistema
vigente,
chiedeva
un
rinnovamento
che
rendesse,
tra
l’altro,
l’apparato
assistenziale
più
efficiente
e
idoneo
a
rispondere
alle
istanze
economico-sociali
dell’epoca.
Il
processo
di
sensibilizzazione
della
società
civile
fece
aprire
gli
anni
Settanta
con
la
prospettiva
di
una
grande
trasformazione
nella
politica
assistenziale
del
Paese.
Soprattutto
quando
si
fecero
più
forti
e
pressanti
le
rivendicazioni
dei
movimenti
collettivi
e
più
teso
il
livello
di
scontro
sociale,
vennero
prese
una
serie
di
misure,
come
l’istituzione
degli
asili
nido
comunali,
nel
1971,
dei
consultori,
nel
1975,
o la
soppressione
tra
il
1975
e il
1977
di
alcuni
enti
assistenziali
come
l’ONMI
e
gli
ECA.
Inoltre,
l’istituzione
delle
Regioni
e il
conseguente
decentramento
delle
competenze
assistenziali
furono,
effettivamente,
un
elemento
“rigenerante”
per
il
sistema
assistenziale
italiano,
che
conobbe
una
nuova
stagione,
grazie
al
maggior
coordinamento
e
alla
maggiore
efficacia
delle
attività.
Bisognerà,
però,
attendere
il
nuovo
millennio
per
avere
in
Italia
una
legge
quadro
di
riforma
del
sistema
assistenziale.
Nel
2000
venne,
infatti,
approvata
la
legge
n.
328
"Legge
quadro
per
la
realizzazione
del
sistema
integrato
di
interventi
e
servizi
sociali",
che
diede
finalmente
una
configurazione
complessiva
al
sistema
dei
Servizi
sociali.

|
|
|
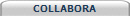
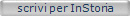
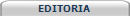
GBe
edita e pubblica:
.
-
Archeologia e Storia
.
-
Architettura
.
-
Edizioni d’Arte
.
- Libri
fotografici
.
- Poesia
.
-
Ristampe Anastatiche
.
-
Saggi inediti
.
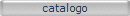
.
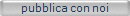
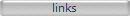
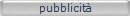
InStoria.it



|